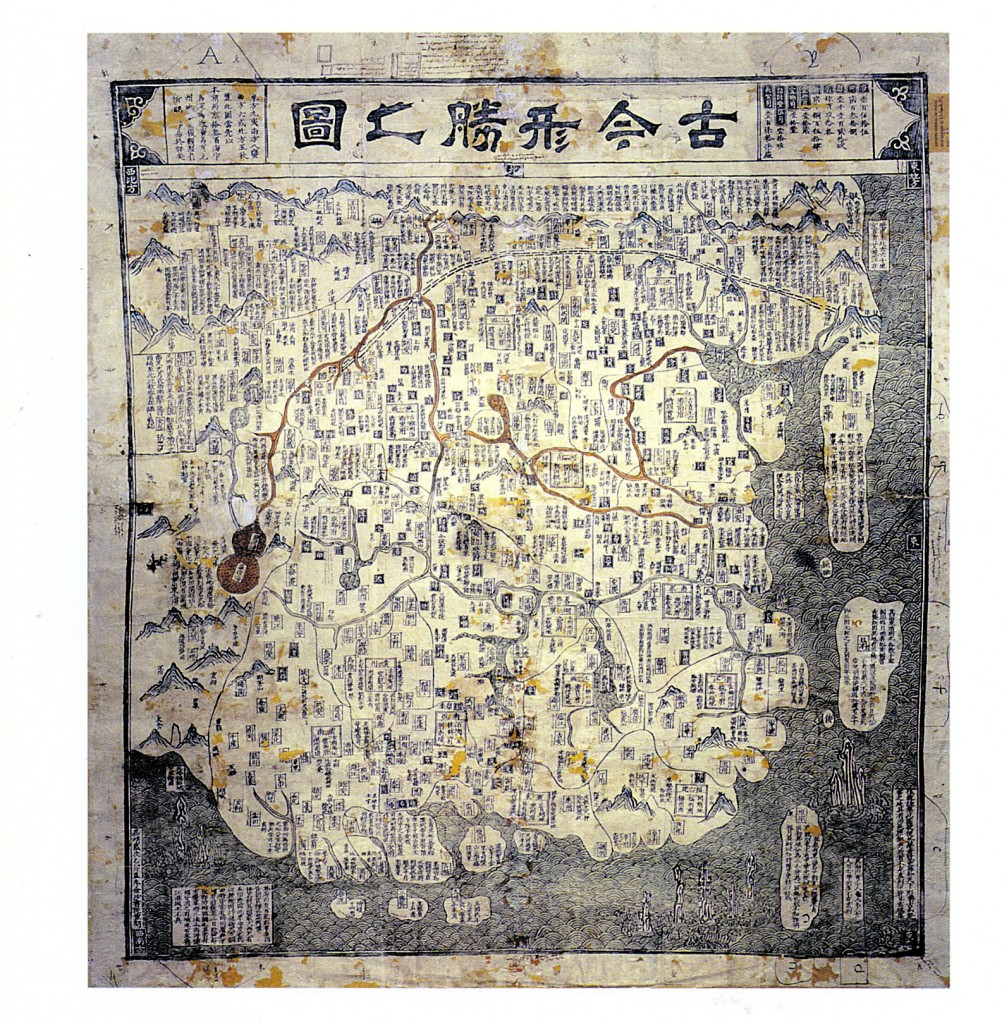Avete mai visto una palla di cervo lanciata a 140 all’ora?
Estremo Sport Da Sarajevo a Kabul viaggio tra eventi sportivi. Metafore e simboli di una violenta competizione per il potere politico che pare sempre pronta a esplodere

Estremo Sport Da Sarajevo a Kabul viaggio tra eventi sportivi. Metafore e simboli di una violenta competizione per il potere politico che pare sempre pronta a esplodere
Conclusi nel 1995 gli accordi di Dayton, che avevano decretato la fine della guerra in Bosnia, eravamo partiti per Sarajevo ancora un volta.
L’occasione ghiotta era la partita di calcio allo stadio Koshevo che doveva sancire la ripresa della normalità nella capitale del Paese più devastato da quel conflitto alle porte di casa.
Ricordo che la radiocronaca Rai era affidata nientemeno che a Bruno Pizzul – voce inconfondibile, piglio deciso, conoscenza dettagliatissima di squadre e giocatori – e i giornalisti erano tantissimi, assiepati con me alle spalle di Pizzul per far la cronaca di quell’incontro che si giocava sul prato da poco ricostruito dello stadio.
Odio lo sport
Io non avevo alcun interesse per la partita in sé: odio lo sport e il calcio in particolare da che quattordicenne, convinto da un manipolo di amici tifosi, ero andato controvoglia a San Siro per una partita Milan Verona conclusasi 2 a 0 ma soprattutto col furto del mio motorino nuovo di zecca.
Se odiavo lo sport, in quell’occasione gliela avevo proprio giurata. Mi siedo dunque col fedele taccuino e comincio a chiedere ai colleghi più esperti la provenienza etnica dei calciatori: «… quello è un serbo che ha giocato là e quello forse un croato che faceva l’ala destra… ». Forse?
Bene non sapevano: conoscevano la provenienza dalle varie squadre ma i miei colleghi, Pizzul in testa, sembravano ignorare che la forza di quella partita stava nel metter assieme serbi, croati e musulmani o, come li chiaman adesso, bosgnacchi. A loro importava poco l’etichetta politica: guardavano al dribbling, al contropiede, alle azioni in area di rigore. Ne venni a casa sconcertato e mentre scrivevo in albergo il mio pezzo, mi domandavo che razza di giornalisti fossero quelli sportivi.
Ma forse avevano ragione. Quella partita era la normalità e forse era giusto passar sopra alle connotazioni etniche che avevano costituito il terreno prediletto dei nazionalisti e fatto da corollario alle stragi.
E l’incontro era solo il segno che era finita una stagione e ne iniziava un’altra. Io rivangavo, loro ignoravano. Forse il torto era mio.
Una parte di un contesto
Lo sport però, come tutto nella vita, va oltre l’azione in sé. È divertimento, certo, e, per chi lo ama, grande passione. Ma è pur sempre parte di un contesto.
In Asia, come nel resto del mondo. Sarajevo è in un certo senso la porta dell’Asia: ti accoglie con una sfilza di casermoni realsocialisti – ma di una certa raffinatezza architettonica – che ti conducono, lungo il fiume Miljacka, nella città asburgica e alla fine ti proiettano nella cittadella turca, Bascarsija, ornata di cupole e minareti, fontane e piccole botteghe.
Respiri un’aria che troverai a Istanbul, la Sublime Porta, il vero ingresso del Continente al di là dei Dardanelli. Un viaggio in Asia è dunque anche un viaggio nei suoi sport. E il calcio non la fa sempre da padrone.
Ci sono sport antichissimi e diffusi in un solo Paese, come il buzkashi afgano, e altri, come il cricket, che nonostante siano d’importazione, hanno in Asia il loro cuore pulsante: dall’Arabia Saudita al Pakistan, dall’India allo Sri Lanka per finire in Australia, il cricket è in termini numerici, il secondo sport più popolare del mondo.
Si gioca in grandi spiazzi (ground) dove la partita può durare giorni o settimane; si vede in India su decine di canali televisivi e si gioca nei vicoli di Islamabad con tre birilli di legno, una palla gualcita e la classica mazza piatta.
Con l’arrivo dei migranti è ritornato in Europa, sua terra d’origine, per sbarcare a Piazza Vittorio, dietro la Stazione Termini di Roma, o nei giardinetti di altre città: squadre che si allenano in club ben organizzati o semplicemente con team messi assieme la domenica nelle ore più fresche della giornata. Dallo stadio Koshevo passo allo stadio Ghazi di Kabul.
L’arena dei talebani
Qui di giochi se ne fanno tanti anche se una volta era l’arena prediletta dei talebani per punire gli apostati.
Ora ci corrono per allenarsi i giocatori di khosti, un’afgana versione della lotta libera, chissà se imparentata con la yağlı güreş, la «lotta turca» sport nazionale della Turchia, o ancora colcoreano taekwondo, uno sport che ha fatto portare a casa agli afgani anche un bronzo olimpico nel 2012.
Ci sono persino donne che si allenano: ci correva ad esempio Mahboba Ahadyar, velocista e unica femmina tra i quattro atleti afgani che nel 2008 erano in lista per le Olimpiadi di Pechino, sostituita all’ultimo momento (aveva chiesto asilo politico in Europa perché minacciata) da un’altra atleta di nome Robina Jalali, che aveva già rappresentato l’Afghanistan ad Atene nel 2004.
Eccola la politica, o il contesto, rientrare di diritto nello sport. Il gioco nazionale comunque è il buzkashi, che si gioca nel vasto piazzale antistante lo stadio.
È un gioco vecchio come il mondo, forse di origine mongolica: secondo la leggenda, quando i prigionieri catturati venivano gettati sul terreno davanti ai vincitori, se li portava a casa chi, a cavallo, se li caricava.
Ed ecco i chapandaz
Da gioco di guerra a gioco di squadre il buzkashi, nelle sue diverse versioni, funziona grosso modo così: in mezzo all’arena di terra battuta, c’è la carcassa di un animale con la testa mozzata e le zampe tagliate all’altezza del garretto.
Un centinaio di cavalieri – i chapandaz – si lanciano verso la preda al centro del campo e il giocatore che per primo afferra il trofeo cerca di trascinarlo verso l’esterno dell’arena, in un punto che segna la vittoria finale. Inseguito dagli altri senza esclusione di colpi (bassi).
Gli occidentalisti impenitenti lo hanno definito un violento «polo senza regole» ma il buzkashi le sue regole le ha. Di più: Whitney Azoy, autore di Buzkashi: Game and Power in Afghanistan, sostiene che è il manifesto di questo Paese: «Il buzkashi – mi ha detto una volta – è il simbolo di una violenta competizione per il potere politico che è sempre pronta a esplodere».
Una chiave che a suo dire permette di capire il potere dei signori della guerra, dei capi di clan e tribù. «Chiamarlo “sport nazionale” non ha senso – dice Azoy – perché l’Afghanistan non è mai stata, e non è, una nazione, nel senso di un rapporto di coerenza e responsabilità delle sue anime con l’autorità centrale. E infatti nel buzkashi si gioca in squadra ma ognuno corre per sé».
Non so se Azoy abbia ragione ma ecco che di nuovo questo gioco non è solo uno sport anche perché, argomentava il saggista, dietro ogni cavaliere c’è sempre un padrone, un capo clan.
Come dietro l’Inter o la Juve.
Dallo stadio di Ghazi potremmo passare al Margalla Ground di Islamabad o al Gymkhana Ground di Mumbai. Qui si gioca la versione moderna di un’invenzione sportiva nata nel Sud dell’Inghilterra tra il XIV e il XV secolo e diventata molto popolare in epoca vittoriana per poi trasferirsi, con grande fortuna, nelle colonie dell’Impero.
Per Pakistan e India, fratelli coltelli dal giorno in cui il Raj Britannico li mise al mondo con un parto gemellare quanto sanguinoso, il cricket è diventato sia il simbolo di un orgoglio identitario durante i campionati internazionali, sia il modo più o meno ufficioso col quale tornare a parlarsi quando la diplomazia ha bisogno di altri canali per raffreddare gli animi.
Sport come orgoglio identitario
Questi due colossi asiatici si guardano sempre in cagnesco per un motivo o per l’altro: dagli incidenti di frontiera agli attentati, al recente contenzioso sull’ingresso nel Nuclear Suppliers Group, un consesso di una cinquantina di Stati che trattano materia e tecnologia nucleare.
Entrambi ci vorrebbero entrare e la diatriba è su chi sarà ammesso per primo. Lo sport che si gioca con una palla di pelle di cervo, che va bene a musulmani e indù, è diventato per questi due
Paesi anche la metafora di una diplomazia indiretta: la «cricket diplomacy».
C’è tensione? Una partita potrebbe stemperarla. Dunque la politica c’entra eccome nello sport più diffuso nel mondo (2,5 miliardi di fan) dopo il calcio (3,5 miliardi) e del resto è un rapporto ineludibile se è vero quanto sostiene Cyril L. James, un intellettuale socialista e anticolonialista nato nelle Indie occidentali, che nel 1938 ha scritto The Black Jacobins: Toussaint L’Ouverture and the San Domingo Revolution.
Dice che il cricket può essere interpretato con le categorie della politica e viceversa e che, per gli abitanti delle colonie, fu la metafora dell’indipendenza: vincere nello sport della «madrepatria» imperiale, diventava per gli oppressi la possibile liberazione dalle proprie catene.
Se per qualcuno è il gioco più noioso del mondo e per altri una passione che non ha eguali, nei rapporti difficili tra India e Pakistan è invece il termometro di un dialogo non sempre lineare.
Ed è diventato, da Londra a Sidney passando per Lahore e Calcutta, anche un modo di dire se qualcosa non è corretto o non va per il verso giusto: «it’s not cricket».
Non so se i diplomatici dei due Paesi usino questa espressione quando la «cricket diplomacy» si arena, ma so che questa lettura può riconciliare con lo sport anche chi cordialmente lo detesta.
E mi son sorpreso, in qualche alberghetto del Maharashtra o in qualche stanzetta di Sri Lanka, a guardare la partita.
Senza capire gli applausi per l’azione ma affascinato da quella palla che può viaggiare a 140 km l’ora. Più veloce dei lenti e maldestri tentativi della politica o dei nostri tentativi di spiegarla.
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento