Artur Nuraj, nel cuore di tenebra dell’Albania
L'intervista Parla lo scrittore nato a Valona, e che vive da tempo a Verona, autore di «La valle dei bambini perduti» per Marsilio. Un noir affascinante che fa luce sull’ultima stagione del regime indagando sulla scomparsa di piccoli rom. «Il poliziesco è il modo migliore per raccontare gli scenari raccapriccianti di un regime totalitario per il semplice fatto che, come in un thriller, nulla è come appare». «Il detective Lamani, come la mia generazione, ha avuto il coraggio di guardare il Mostro in faccia pur non essendo un dissidente»
 Un'immagine d'epoca del centro di Tirana
Un'immagine d'epoca del centro di TiranaL'intervista Parla lo scrittore nato a Valona, e che vive da tempo a Verona, autore di «La valle dei bambini perduti» per Marsilio. Un noir affascinante che fa luce sull’ultima stagione del regime indagando sulla scomparsa di piccoli rom. «Il poliziesco è il modo migliore per raccontare gli scenari raccapriccianti di un regime totalitario per il semplice fatto che, come in un thriller, nulla è come appare». «Il detective Lamani, come la mia generazione, ha avuto il coraggio di guardare il Mostro in faccia pur non essendo un dissidente»
Per Ludovik Lamani non è facile districarsi tra le veline di Stato, la verità ufficiale stabilita dal Partito, l’apparenza che definisce il decoro degli ambienti che contano nel Paese e il volto selvaggio e imprevedibile della violenza che scuote, seppure nelle proprie zone d’ombra, anche la società albanese. Per il trentenne detective di Valona che ha da poco preso servizio nella polizia della capitale, il trasferimento a Tirana e il confronto con i vertici del regime, a causa di un’indagine, rappresenteranno molto di più che una brillante occasione professionale. Protagonista dell’affascinante noir La valle dei bambini perduti di Artur Nuraj (Marsilio, pp. 452, euro 20), Lamani finirà per misurarsi fino in fondo con la spaventosa realtà che il volto sereno imposto al Paese grazie ad una meticolosa macchina repressiva orchestrata dalla Sigurimi – la polizia segreta – nasconde ad ogni costo. Lo farà indagando su un delitto eccellente, quello della figlia di un membro di primo piano del Partito, ma soprattutto cercando di fare luce sulla misteriosa sparizione di molti bambini rom, scomparsi senza lasciare tracce dagli accampamenti in cui vivono le loro famiglie, ai margini delle città o nelle valli di montagna. Soprattutto, il giovane poliziotto, eroe riluttante che con modestia rivela le proprie doti di investigatore, incarna in questa storia ambienta a metà degli anni Ottanta, quando la fine del regime comunista è prossima anche se non se ne scorge ancora alcuna traccia concreta, le speranze e le attese di una generazione che all’epoca era affamata di letteratura quanto lo era di vita, «perché nella loro condizione, (gli albanesi) la libertà, la vera libertà, potevano trovarla soltanto nei libri».
Nato a Valona nel 1968, e già autore di alcuni romanzi tra pulp e spy story con lo pseudonimo di Anthony J. Latiffi, Artur Nuraj vive da tempo a Verona.

Cosa significa scrivere romanzi polizieschi, che presuppongono la possibilità di giungere a una qualche forma di «verità», o comunque di scavare sotto la superficie delle cose, ambientati nello scenario di un regime totalitario che ammette solo verità ufficiali, come l’Albania degli anni ’80 che fa da sfondo a «La valle dei bambini perduti»?
Vuol dire raccontare attraverso il genere crime una vicenda sociale e politica inserita in un determinato contesto storico del Paese. In questo caso l’Albania nell’epoca più delicata e feroce della sua storia, ossia quella del regime totalitario. Sotto la superficie apparentemente gloriosa e altrettanto fragile del «paradiso dei proletari», si nasconde una realtà oscura, corrotta, violenta e piena di ogni genere di restrizioni, dove i diritti umani vengono calpestati dalla demagogia comunista. Sono convinto che il poliziesco sia il modo migliore per raccontare gli scenari raccapriccianti di un regime totalitario per il semplice fatto che, come in un thriller, nulla è come appare. Così, in questo caso, la «lotta di classe» tra comunisti e dissidenti fa da sfondo alle indagini costruite attorno a personaggi che appartengono a un conflitto silenzioso che è andato avanti per decenni.
Il protagonista del romanzo, il detective di Valona Ludovik Lamani, sembra maturare progressivamente la consapevolezza del contesto in cui opera e, sebbene non si possa definire come un oppositore o un dissidente, attraverso i suoi occhi si scorge il profilo del regime che guida il Paese. Lo sguardo di Lamani traduce l’opinione di un’intera generazione di albanesi, che poi è anche la sua?
Questa domanda coglie il mio vero intento. Ho cercato di presentare l’Albania dell’epoca così come io l’ho vissuta; un’infanzia serena, una gioventù spensierata a cui veniva promesso un futuro sicuro e garantito sotto la protezione del Partito. Tuttavia, a mano a mano che crescevi, osservando la vita dei dissidenti, le loro sofferenze e i pregiudizi di cui erano vittime, realizzavi che la nostra realtà non era altro che un teatro di burattini. Dunque, attraverso la figura di Lamani, ho voluto esprimere l’opinione e il pensiero della mia generazione che, pur non appartenendo alla «classe dissidente», aveva il coraggio di togliersi i paraocchi e anche di guardare il Mostro in faccia.
Tra gli elementi che ritornano nel libro c’è la presenza costante del peso che le tradizioni esercitano nella vita dei protagonisti: per molti versi quello che lei descrive sembra essere un mondo arcaico in cui la modernità si è intrecciata con regole non scritte che datano da tempi lontani. Cosa ci dice questo della realtà nella quale si muove Lamani?
Come molti altri popoli, gli albanesi sono molto attaccati alle proprie usanze e tradizioni. È sempre stato così e continua a esserlo tuttora, specie nelle zone rurali, dove le regole non scritte e tramandate in forma orale costituiscono una solida base sociale. Tradizioni molto antiche che solitamente sono figlie della religione, di fedi diverse, e sono impresse nel nostro quotidiano a tal punto che spesso si intrecciano con la modernità. Di conseguenza, anche Lamani non può allontanarsi da questo contesto, perché, a dirla tutta, spesso e volentieri le tradizioni condizionano le nostre scelte di vita. È stato indispensabile evocare nel romanzo questa parte della nostra esistenza per rendere più comprensibili al lettore le scelte e le decisioni del personaggio principale.
Al centro del libro c’è una vicenda, che ruota intorno alla misteriosa scomparsa di molti bambini rom, che pare rovesciare volutamente uno degli stereotipi spesso proiettati sulle comunità nomadi. Come nasce questa scelta?
Confesso che durante l’infanzia ero affascinato dai nomadi, dal loro stile di vita caratterizzato da uno spirito libero e dall’avventura. Nonostante la condizione politica del Paese e le regole restrittive che vigevano, all’epoca erano una popolazione molto libera quanto alle scelte e alla possibilità di movimento all’interno del territorio nazionale: e grazie a tutto ciò erano riusciti a conservare il loro modo di vivere e il proprio spirito migrante. Questo però comportava un distacco importante dagli organi dello Stato e dal resto della popolazione. Non avendo una dimora fissa e una situazione demografica stabile, per lo Stato potevano risultare incontrollabili e di conseguenza costituivano prede facili per chi nutriva intenzioni oscure nei loro confronti.
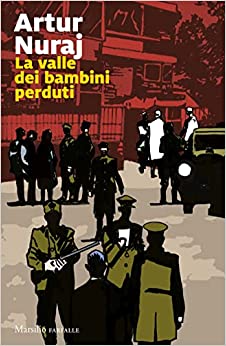
Questo «doppio registro» è una scelta voluta, come un confronto fra due generi, il thriller e il noir, che in realtà s’intrecciano e si amalgamano con dinamiche e tipologie di linguaggio precise. È proprio questo elemento stilistico a sancire il ritmo narrativo e a contraddistinguere il romanzo. Quanto a Lamani, direi che si muove soprattutto in modo sobrio e senza eccessi. L’apparente leggerezza di un giovane uomo con una posizione sociale rispettata, e a tratti invidiata, viene contrapposta alla solennità con cui affronta il proprio lavoro; quando si tratta di indagare, Lamani tira fuori le peculiarità proprie ad un detective competente e di grande umanità.
Nell’Albania comunista i «gialli» erano vietati, lei vive e lavora da tempo in Italia, ma l’interesse per questo genere ha comunque a che fare con qualche autore locale che magari da noi non è conosciuto?
È vero, all’epoca la censura comunista vietava i «gialli». Circolava qualche testo di contrabbando scritto in francese o in italiano, ma dovevi possedere una buona conoscenza delle lingue in questione per poterli leggere. Mi innamorai del genere poliziesco sin da giovane, scoprendo i romanzi di Neshat Tozaj, un detective che raccontava con grande fascino e ritmo le indagini cui aveva partecipato nonostante i suoi testi fossero censurati fino all’osso. È considerato il padre del crime albanese e i suoi romanzi segnarono la nascita del thriller di spionaggio nella nostra letteratura.
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento




