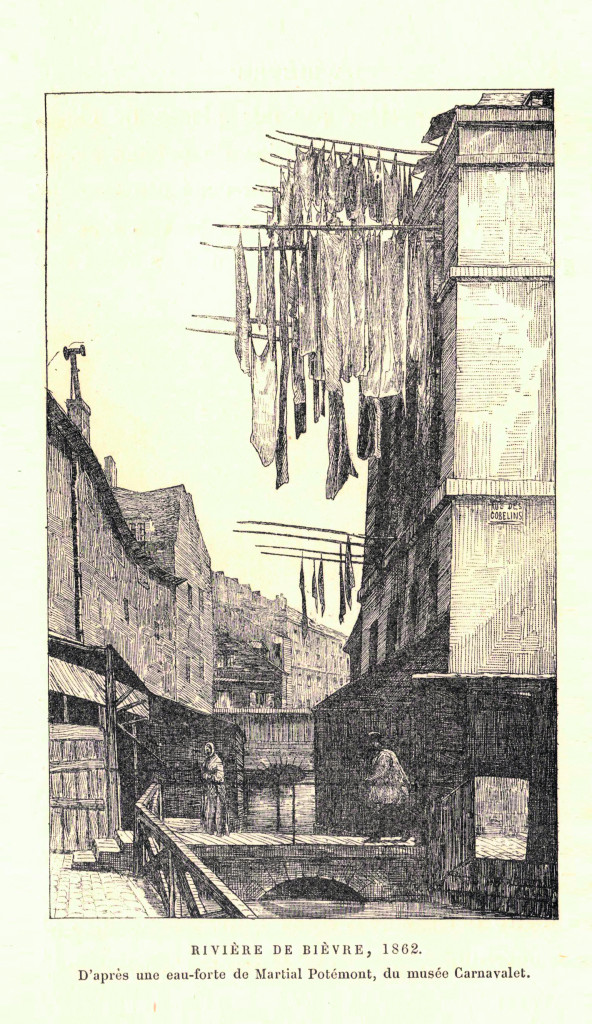Affilato, astratto, ipnotico: un Simenon anni sessanta
Scrittori belgi Come in «Bergelon», scritto nel 1939, il protagonista di questo romanzo è uno stimato medico: nel frattempo però Simenon s’è fatto più penetrante, mentale: torna «L’orsacchiotto», da Adelphi
 Parigi anni sessanta, foto REPORTERS ASSOCIES /Gamma-Rapho via Getty Images
Parigi anni sessanta, foto REPORTERS ASSOCIES /Gamma-Rapho via Getty ImagesScrittori belgi Come in «Bergelon», scritto nel 1939, il protagonista di questo romanzo è uno stimato medico: nel frattempo però Simenon s’è fatto più penetrante, mentale: torna «L’orsacchiotto», da Adelphi
Horkheimer e Adorno scrissero – in un celebre saggio contenuto nella Dialettica dell’illuminismo – che, organizzando razionalmente la sua nave e lasciando ai marinai il compito di lavorare al posto suo per consentirgli di trarne il massimo godimento (ascoltare, senza pagarne le conseguenze, il canto delle sirene), Odisseo incarnerebbe una delle prime e più fulgide testimonianze dell’«uomo borghese». Tra i romanzieri del Novecento che più spregiudicatamente hanno approssimato il ritratto di questa figura dai contorni incerti, Georges Simenon spicca quale autore della galleria più spaventosa, e forse più convincente. Tra le pagine di L’orsacchiotto – ora pubblicato da Adelphi a distanza di quasi sessant’anni dalla prima edizione Mondadori nella «Medusa», nella nuova traduzione di Laura Frausin Guarino («Biblioteca», pp. 147, € 18,00) – si avverte una «ostilità diffusa» che grava sul protagonista, da parte tanto di alcuni personaggi quanto del narratore, incline a restare fisso, fino quasi alla allucinazione, sui suoi pensieri, salvo scartare improvvisamente – in pochissime, decisive occasioni – per assumere la focalizzazione zero al solo scopo di presentarsi ufficialmente tra coloro che incombono su di lui.
Al centro del racconto il cinquantenne Jean Chabot, chirurgo, ginecologo e professore di medicina molto stimato a Parigi, dove dirige una clinica privata. La dinamica che innesca la sua crisi psichica ha un innegabile sapore di déjà vu che l’editore italiano non nasconde affatto: già in Il dottor Bergelon, pubblicato da Adelphi l’anno scorso, il medico protagonista rimaneva implicato, anche se soltanto moralmente, nella morte di una donna, ciò che metteva in moto una narrazione a tratti rasente al noir. Il confronto è interessante soprattutto alla luce della distanza cronologica che separa la stesura dei due romanzi: tipico Simenon degli anni trenta, Il dottor Bergelon si reggeva sul dinamismo delle scene, su una accennata fuga del protagonista attorno al quale ruota il congegno romanzesco, fino alla conclusione stemperata da una vacua «mediocrità» che riverberava Flaubert; il testo era tenuto insieme da una affabulazione ricca di dettagli descrittivi, che lasciavano emergere, con deliberata lentezza, lo stato di crisi emotiva del protagonista. L’orsacchiotto invece è del 1960: qui poco avviene al di fuori della mente di Chabot, dentro la quale ci si immerge fin dall’inizio con un tono grave in cui la crisi, piuttosto che manifestarsi per gradi, è già conclamata; il violento finale è di segno opposto rispetto a quello che sfumava la vicenda di Bergelon; e, nella scrittura, si trova forse la differenza più evidente: meno materici, più sfuggenti, quanto più i consueti dettagli puntellano lo spazio del narrato, tanto più astratto sembra farsi il resoconto.
Chabot immagina una istruttoria che segua al suo suicidio, pensiero ricorrente che lo induce a girare in città per diversi giorni con in tasca la proverbiale rivoltella, e si chiede cosa testimonierebbero sua figlia, che non gli parla, o sua moglie, con la quale la relazione si è esaurita ormai da tempo, o piuttosto il tassista che lo ha visto barcollare ubriaco in strada. Anche Chabot, come Bergelon, ha un ruolo decisivo nella morte di una donna, una infermiera che ha voluto aggiungere al novero delle sue amanti passeggere, e senza chiedere il permesso. E anche lui riceve minacce di morte da una silhouette persecutoria e vendicativa, in perfetto stile Simenon: non sembra che un pretesto, qui come nel caso del collega Bergelon, per avviare la messa in discussione di ogni aspetto della propria vita, laddove sembra divenuto impossibile ricordare i giorni in cui «era calmo, sicuro di sé, convincente, indossava la maschera».
Il Simenon degli anni sessanta non tesse più trame intriganti, non pesca dal baule dei trucchi, anzi si diverte a riutilizzare vecchi cliché già consumati da lui stesso, intaccandone semmai la matrice in alcuni, significativi punti. Diversa è la coloratura della sua voce, più affilata e più fredda, mentre la consueta sensibilità, e una quasi miracolosa abilità mimetica gli consentono una penetrazione nell’animo del suo malcapitato protagonista tanto profonda da produrre un effetto ipnotico, quasi senza «azioni» e riuscendo a non scadere in psicologismi di sorta. Lo scrittore di Liegi aveva ben chiaro questo confine da non oltrepassare, tanto che verso la fine del romanzo il medico si prende gioco di un collega psichiatra dal qual si reca spontaneamente e al quale finisce poi per negare la chiave di accesso al proprio sé, in quella che sarebbe la perizia psichiatrica conclusiva della istruttoria vagheggiata fin dalle prime pagine del libro.
Nella magistrale descrizione erotica del rapporto furtivo e ambiguo con l’infermiera mezza addormentata si intravede il vero volto di Jean Chabot: nonostante il suo patimento interiore, tardivo e confuso, egli è del tutto privo della capacità di sentire chi gli sta intorno. Una mancanza di empatia evidenziata dal nomignolo che affibbia alla ragazza, «l’orsacchiotto» del titolo, appunto, e visibile anche nel modo di chiamare le pazienti della clinica con il numero del letto loro assegnato («la numero sette», «la numero dodici»).
La scena di un sontuoso ricevimento che forse sarebbe piaciuta a Stanley Kubrick – con un Cognac del 1843 sul tavolo, un racconto pornografico di un lontano parente, gli occhi lucidi e sovreccitati degli invitati, un Rodin autentico da cui «non è stato ricavato alcun bronzo» che troneggia in salotto, e porte socchiuse dietro le quali si consuma il vitalismo laido e mortuario dell’upper class parigina – introduce magnificamente all’inopinato episodio definitivo, nel quale fino all’ultimo Chabot non riuscirà a uscire da se stesso. Un gesto tragico – nel cui negativo si intuisce anche quel crudelissimo segno comico che talvolta Simenon si lascia dietro come una scia segreta – chiude la sua catabasi. Una discesa borghese, naturalmente, alla fine della quale, a farne le spese, come sempre, è l’altro.
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento