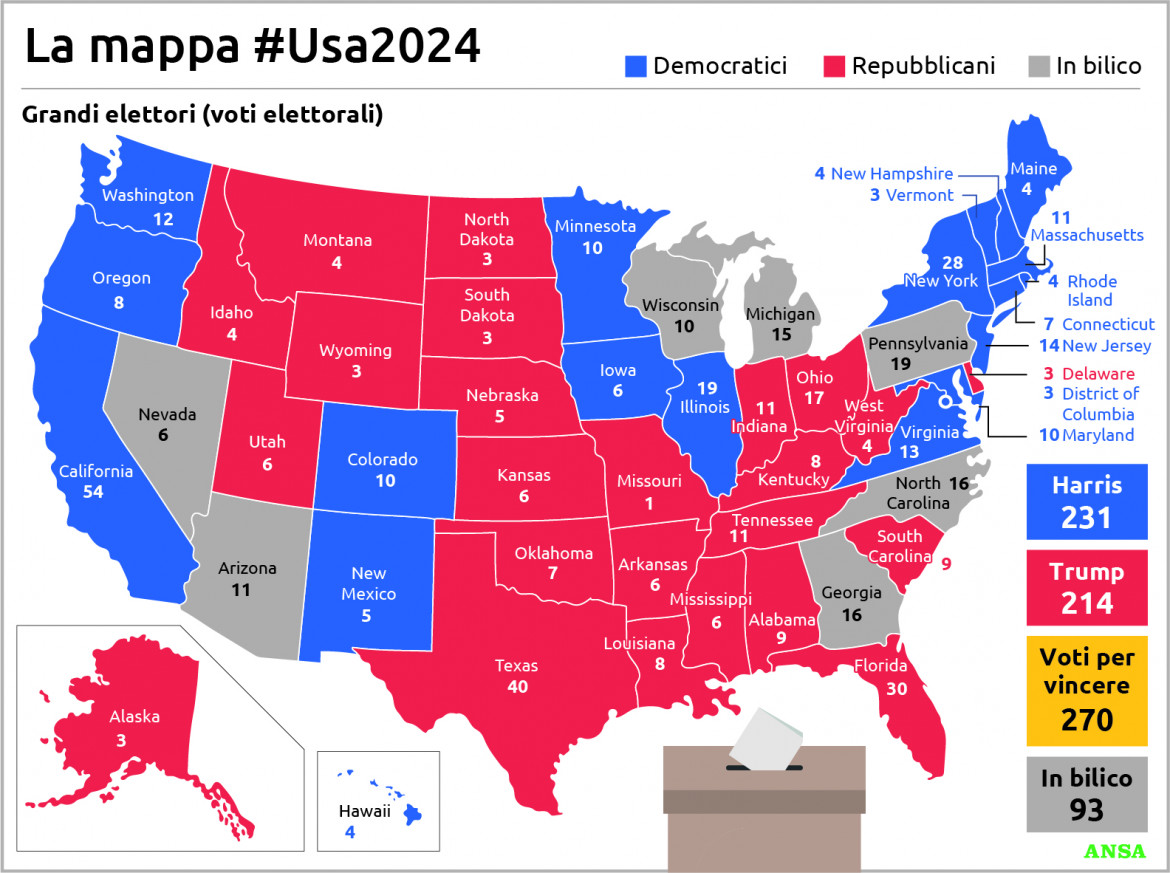Washington 1963. Il desiderio del sogno e la realtà dell’incubo
60 anni di «I have a dream» Il sermone durò mezz’ora, la parte più celebre recitata a braccio «Questo è un inizio», esordì Martin Luther King Jr. Non era vero
 Manifestanti camminano lungo il National Mall durante la marcia su Washington, il 28 agosto 1963 – Getty images
Manifestanti camminano lungo il National Mall durante la marcia su Washington, il 28 agosto 1963 – Getty images60 anni di «I have a dream» Il sermone durò mezz’ora, la parte più celebre recitata a braccio «Questo è un inizio», esordì Martin Luther King Jr. Non era vero
Il 28 agosto 1963, Martin Luther King accompagnò i neri americani agli sportelli della «banca della giustizia» per richiedere il pagamento della cambiale scaduta che gli Stati uniti avevano rilasciato al suo popolo. E che fino a quel momento avevano solamente fatto finto di pagare, rilasciando sempre «assegni scoperti». I neri avevano ragione nel pretendere che gli Stati uniti rispettassero gli alti principi che loro stessi si erano dati. E immaginando che un giorno fossero stati capaci di farlo, diventava possibile «sognare» un mondo di uguaglianza e di libertà per tutti. Fratelli.
QUEL GIORNO King fu l’ultimo a prendere la parola, introdotto dall’anziano ex sindacalista nero A. Philip Randolph come «la guida morale del nostro paese». Parlò come tale. La costruzione retorica del suo discorso fu perfetta. L’iniziale denuncia della vergogna storica del razzismo e delle infinite inadempienze del potere dovevano sollecitare l’indignazione morale dei presenti, ma anche aprire infine i varchi alla speranza, con la prefigurazione di che cosa sarebbe potuto essere un futuro di armonia tra le razze, invece che di prevaricazione e oppressione. Le reiterazione del «sogno», in crescendo, con le diverse immagini che di volta in volta dovevano illustrarlo e renderlo desiderabile, fu il culmine del discorso. Fino alla liberatoria e profetica invocazione finale: «Che la libertà risuoni dal fianco di ogni montagna. E se facciamo che la libertà risuoni, se facciamo che risuoni da ogni villaggio e ogni borgo, da ogni stato e ogni città, riusciremo ad avvicinare il giorno in cui tutti i figli di Dio, neri e bianchi, ebrei e gentili, protestanti e cattolici saranno capaci di prendersi per mano e cantare le parole del vecchio spiritual nero, ‘Liberi infine!, liberi infine, grazie a Dio onnipotente, siamo liberi infine!’».
Il sermone durò meno di mezz’ora. King pose molta cura nel prepararlo, nel dosarne le parole e costruirne la linea. A un certo punto ne abbandonò la lettura, si è detto, ed è certamente vero che Mahalia Jackson, dietro di lui, a un certo punto lo incitò: «Martin, digli di quel sogno!». King andò a braccio, non per la foga, ma perché sapeva a memoria quello che voleva dire; lo aveva già detto altre volte. E Mahalia lo richiamò al «sogno» perché ne conosceva sia i contenuti, sia l’efficacia: King aveva già impiegato quello stratagemma retorico poche settimane prima a Detroit, in un’altra manifestazione con più di centomila partecipanti.
Ho continuato a pensare che le attuali istituzioni si potessero riformare, un piccolo mutamento qui e uno là. Ora la penso in modo del tutto diverso King due anni dopo
Questo «millenovecentosessantatré è un inizio», disse King nelle battute iniziali. Non era vero, naturalmente. Il movimento di cui lui stesso era testimone vivente era in atto da quasi dieci anni. E ne era testimone anche A. Philip Randolph, il sindacalista che nel 1941 aveva chiamato a una Marcia su Washington dei lavoratori neri che Roosevelt aveva evitato soltanto emettendo un Ordine esecutivo con cui bandiva le discriminazioni basate «sulla razza, sul credo, sul colore, sull’origine nazionale» negli impieghi pubblici e nelle industrie impegnate nella produzione bellica. Allora e nel dopoguerra la segregazione razziale e le discriminazioni nei luoghi di lavoro non cessarono, nella realtà. Nel 1963, la grande manifestazione «per la libertà e il lavoro» diceva che era necessario un nuovo inizio.
DUE ANNI PIÙ TARDI, dopo l’assassinio di Malcolm X a febbraio e dopo la rivolta nera di Watts a Los Angeles, King riconobbe che il sogno si era trasformato in «un incubo». Diede ancora momentaneamente fiducia a Lyndon Johnson per le sue politiche sociali, ma dopo i loro fallimenti e dopo l’inizio dell’escalation in Vietnam fu costretto ad ammettere di avere sbagliato: «Ho continuato a pensare che le attuali istituzioni si potessero riformare, un piccolo mutamento qui, un piccolo mutamento là. Ora la penso in un modo del tutto diverso. Credo che si debba avere una ricostruzione dell’intera società, una rivoluzione di valori», con una «ridistribuzione radicale del potere economico e politico» e una «ricostruzione radicale» della società. Malcolm X si era avvicinato a King, e l’ultimo King si era avvicinato all’ultimo Malcolm. Ma ormai era tardi. Aveva contro i grandi media e Washington. Non era più riconosciuto come guida morale della sua gente, e dopo le rivolte del 1967 il suo ruolo politico era contestato da altri protagonisti, da altre forze.
Tuttavia, la rabbia per il suo assassinio nel 1968 scatenò l’ultima grande sollevazione nera in tutto il paese. Nel 2018, a cinquant’anni da allora, i lavoratori della McDonald’s di Memphis, dove fu ucciso dopo aver partecipato allo sciopero dei netturbini, scesero in sciopero proprio il 4 aprile per ricordare il suo impegno per la «giustizia economica e razziale». E ora, a sessant’anni di distanza, nonostante i mutamenti legislativi conquistati dal movimento per i diritti civili, la temporanea presenza di un afroamericano alla Casa Bianca ha avuto ancora il potere di risvegliare il razzismo che sembrava dormiente nelle istituzioni e nella società.
Nessuno parlò di sogno realizzato quando fu eletto Obama. Anzi, come scrisse Kareem Abdul-Jabbar dopo l’assassinio poliziesco di George Floyd, il 25 maggio 2021, negli Stati Uniti il razzismo è dappertutto, è come «il pulviscolo atmosferico». E come decenni prima, gli eredi di Martin e Malcolm sono stati costretti a un altro nuovo inizio, tornando nelle strade a gridare che le vite nere contano.
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento