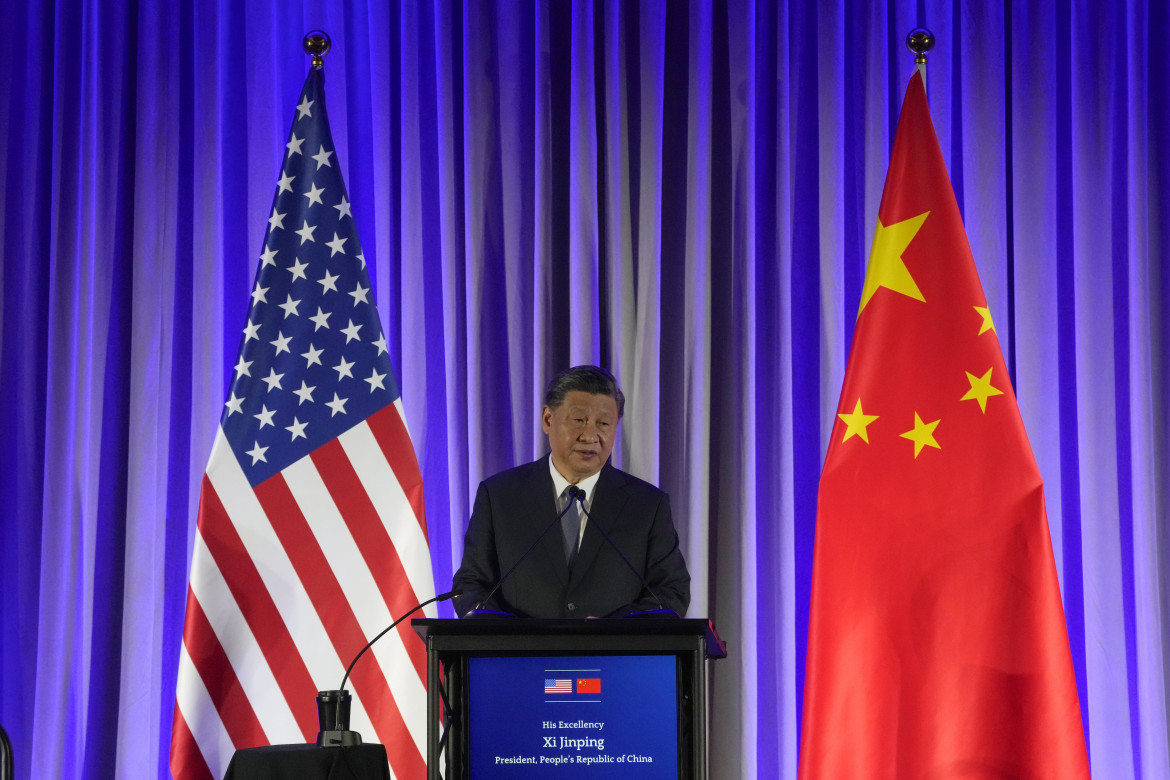Pressioni da Pechino, chiude la tribù femminista del peperoncino
Cina Improvvisa sparizione del sito e delle pagine social del forum online Jianjiao Buluo, dopo anni di attacchi, multe e chiusure di altre realtà radicali femministe dalle principali piattaforme
 Pechino – Ap
Pechino – ApCina Improvvisa sparizione del sito e delle pagine social del forum online Jianjiao Buluo, dopo anni di attacchi, multe e chiusure di altre realtà radicali femministe dalle principali piattaforme
Lunedì 9 agosto il forum online Jianjiao Buluo, «la tribù del peperoncino», ha comunicato l’immediata chiusura del sito e di tutti i canali social. Attiva dal 2014, la piattaforma non aveva l’intento di condividere ricette piccanti: «peperoncino» e «urlare» hanno una pronuncia molto simile in cinese, e l’obiettivo dichiarato nello slogan era quello di «dare voce alle lavoratrici cinesi che lottano per i propri diritti».
Oltre a riflessioni e analisi su tematiche di genere, il sito offriva numerose storie di lavoratrici migranti alle prese con la più recente emergenza pandemica o, in generale, con la vita da addette alla consegna o lavoratrici domestiche. In uno degli articoli, ad esempio, una operaia della Foxconn denunciava l’esistenza di una vera e propria «cultura delle molestie sessuali» che impera nei luoghi di lavoro e che si traduce in battute e commenti inappropriati e contatti corporei non consensuali. L’autrice elencava una serie di proposte per contrastare tali atteggiamenti: rompere il tabù delle violenze sessuali, investire nell’educazione civica e sessuale e stabilire procedure di reclamo.
Il collettivo promuoveva anche workshop per le donne migranti con l’obiettivo di creare una rete di supporto, aderendo a un femminismo radicalmente opposto a quello cosiddetto «aziendale» di stampo liberale. Un esempio, commenta Dong Yige, professoressa di Studi di genere e sessualità all’Università di Buffalo, nel suo saggio per il trimestrale Made in China Journal, di «convergenza delle lotte contro l’ingiustizia di genere e l’oppressione del lavoro», manifestatasi in particolare dopo il 2015.
In quell’anno, un giro di vite aveva coinvolto movimenti femministi come lo YFA (Young Feminist Activism) comportando anche l’arresto delle Feminist Five, appartenenti al China’s Women’s Rights Action Group e conosciute per l’impatto visivo delle loro proteste. Ma l’onda di repressione della mobilitazione civile aveva travolto soprattutto avvocati per i diritti umani, attivisti del lavoro e ong, limitando il dibattito alla sfera digitale ma generando una «congiuntura involontaria» tra le diverse forze sociali.
L’intersezionalità delle lotte come filo conduttore dei contenuti proposti dalla «tribù» ha attirato negli anni le istanze repressive del governo. Già nel 2018 il collettivo aveva comunicato su Wechat che il proprio account Weibo – la prima una polifunzionale app di messaggistica e il secondo una sorta di Twitter cinese – era stato bloccato per presunte violazioni degli standard. Malgrado i 20mila follower del social media si fossero mobilitati contro la chiusura, la pagina non era stata ripristinata.
Un’azione censoria affatto causale, viste le varie riflessioni con le quali aveva contribuito alla discussione sul movimento statunitense #Metoo, nato l’anno precedente dopo le rivelazioni sulle molestie sessuali a Hollywood. Due anni dopo, Jianjiao Buluo era finito al centro di una controversia sul lavoro che aveva fatto sì che ad aprile la polizia facesse irruzione nella sede a Shenzhen e trattenesse per 24 ore un membro del team.
A destare l’interesse degli organi regolatori era stata la denuncia da parte di Wang Xiaohui, web editor del sito, che aveva raccontato di essere stato licenziato senza motivi validi. Il tribunale aveva condannato la «tribù» al pagamento di più di 12mila yuan per la mancata indennità.
Stavolta l’avviso comparso in tutte le pagine del collettivo non ha fornito spiegazioni sulla chiusura improvvisa, ma è plausibile che sia legata a quanto successo ad aprile: il social Douban ha eliminato una decina di gruppi che affrontavano i temi legati al movimento radicale femminista 6B47 per aver divulgato idee «radicali ed estremiste».
Secondo quanto twittato da Feminist China, una pagina internazionale che segue gli sviluppi femministi nel paese asiatico, non c’è alcun dubbio che si tratti dell’ennesima azione delle autorità cinesi per sopprimere questo genere di lotte.
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento