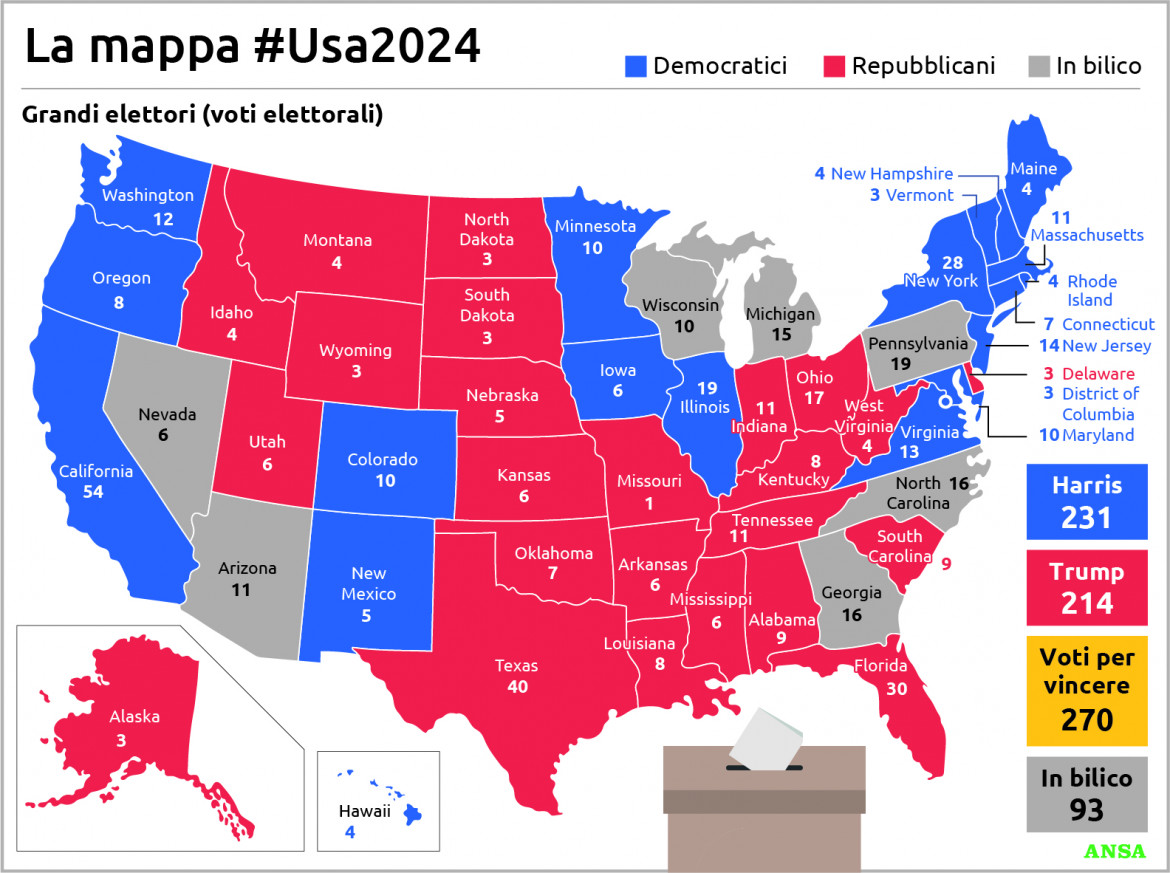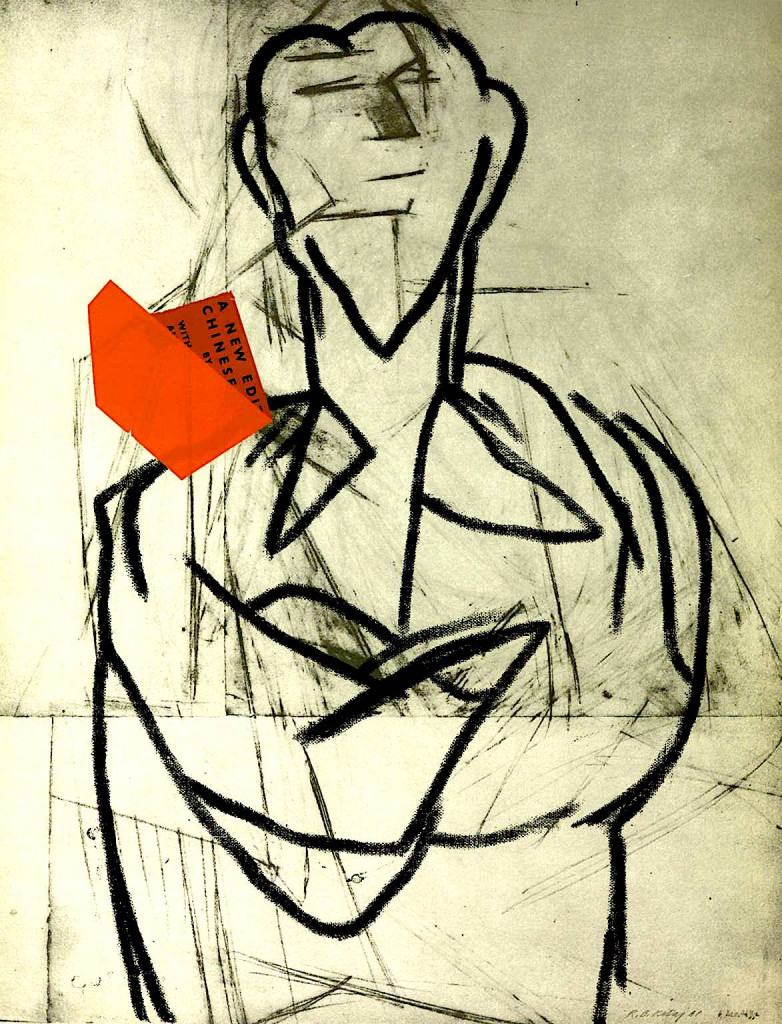
Pound secondo Valduga, una traduzione contagiata dall’energia del testo
Nel 1919, a guerra appena conclusa, Paul Valéry scrisse per una rivista inglese un saggio, La crisi dello spirito, che comincia così: «Noi, le civiltà, adesso sappiamo di essere mortali». Pochi testi riescono a illustrare con così poche parole il clima in cui, una manciata di anni dopo, due poeti americani produssero i monumenti del modernismo di lingua inglese.
Squarciata dalle bombe, la terra fa affiorare ciò che aveva in ogni dove inghiottito. Dalla storia emergono i fantasmi di navi cariche di ricchezze dello spirito. Presente e passato, vicino e lontano formano un’unica gestalt spazio-temporale. Un brivido fa fremere il midollo dell’Europa: «Ninive, Babilonia» sono bei nomi, ma lo sarebbero anche «Francia, Inghilterra».
In una difesa disperata del proprio essere, i suoi grandi uomini e libri riemergono alla rinfusa. Keats e Baudelaire si ritrovano accanto a Menandro. Da un’immensa terrazza di Elsinore l’Amleto europeo medita su una pletora di crani illustri. Con terribile chiaroveggenza contempla il passaggio dalla guerra alla pace, tanto più arduo di quello dalla pace alla guerra, ed è oppresso dall’ennui di ricominciare un passato che ha avuto quella fine.
L’immagine finale di Valéry anticipa l’inizio della Terra desolata di T. S. Eliot, dove un coro di morti lamenta la crudeltà dell’aprile che li chiama alla rinascita, e preferirebbe restare sotto una coltre di neve e di oblio. Il testo, uscito nel 1922, è un breve poemetto di 432 versi. Originariamente era più lungo, ma l’amico Ezra Pound, cui Eliot aveva sottoposto il manoscritto, ne aveva tagliato più della metà con dei freghi di matita blu.
Venne ricompensato, nella dedica, con quell’appellativo di «miglior fabbro» che Dante nella Commedia riserva a Arnaout Daniel, il trovatore prediletto da Pound. La novità più vistosa del poemetto sta nell’uso del collage, che incastona nell’inglese citazioni in altre lingue moderne e antiche. «Con questi frammenti», scrive Eliot alla fine, «ho puntellato le mie rovine», e le ultime parole sono in sanscrito.
Quanto a Pound, già nel 1915 lavorava a «un poema crisoelefantino di incommensurabile lunghezza che – dice – mi occuperà per i prossimi quattro decenni, a meno che non diventi una noia». Due anni dopo scrive a Joyce di avere cominciato «un poema infinito, di una categoria ignota … tutto su ogni cosa».
Nel 1922 spera che Ford Madox Ford faccia con i suoi «dannati canti» quello che lui aveva fatto per Eliot: leggerli «con una matita rossa, rosso-sangue, verde, blu o altra e cancellare quel che sembra troppo orrendo». Un compito impossibile, perché il poema era per sua stessa natura interminabile.
Nel 1931, a Rapallo, Pound parla a un italiano di un’opera che doveva abbracciare «tutti i motivi della storia universale», e gli assicura che «dopo la Divina Commedia non vi è più stato alcun libro che abbia compreso tutta la vita di tutta l’umanità». Col passare degli anni il metodo del collage plurilinguistico esonda, le citazioni arrivano a comprendere ideogrammi e brani di spartiti musicali. Poiché questo babelico poema aspira a un’inclusione infinita della realtà, solo la morte del titanico poeta poteva porvi fine: avvenne a Venezia, nel 1972.
Di quest’opera sotto ogni aspetto «straordinaria» Patrizia Valduga ha tradotto e annotato, per Mondadori, i Canti I-VII (pp. 132, € 18,00): è solo l’inizio, meno di un sedicesimo del tutto, ma basta a introdurci nell’essenziale. Nel 1928 Pound spiegò a Yeats che una volta finito il centesimo canto il poema avrebbe rivelato una struttura simile a una fuga di Bach: «Non ci sarà intreccio, né cronaca di eventi, né logica di discorso, ma due temi, la discesa nell’Ade tratta da Omero, una Metamorfosi tratta da Ovidio e, mescolati con questi, personaggi storici medioevali e moderni».
Tutto ciò è presente nei primi sette canti, che sono dunque un microcosmo compiuto dell’intero poema. E il poderoso apparato di note di cui sono corredati – almeno pari, per mole, al testo annotato – recupera nei limiti del possibile tutto il materiale letterario e storico che è consustanziale alla poesia.
«I grandi poeti» ha scritto Pound «di rado fanno mattoni senza paglia. Ammucchiano tutte le eccellenze che possono mendicare, o rubano da predecessori e contemporanei». Di quella paglia Valduga ha ammucchiato tutte le individuabili festuche – e non è affatto detto che le sue note siano utili soltanto «al bisogno dei giovani lettori, resi sempre più ignoranti da una scuola sempre più ignorante».
Nel primo Canto Odisseo scende tra i morti per nutrirli di un «sugo di sangue» che dia ai «tenui teschi» la forza di parlare, e «i morti impetuosi impotenti» gli si affollano accanto. Ma Odisseo è anche Pound, che si appresta a dar sangue e voce ai suoi personaggi. Il primo compare nell’incipit del secondo canto – «Mannaggia, Robert Browning» – Browning essendo l’autore di un poemetto su Sordello, trovatore mantovano di dantesca memoria. Morto a Venezia, a Ca’ Rezzonico, nel 1889, Pound lo considera il proprio padre, perché era l’unico dei moderni che avesse avuto coscienza di quella fase del Medioevo che fu il primo e mai dimenticato amore dello stesso Pound. Già nel 1913, apprendiamo dalla nota, egli aveva scritto un articolo dove riportava una Vida manoscritta di Sordello conservata nell’Ambrosiana di Milano. Un suo frammento compare nel Canto VI: «E lo Sordels si fo de Mantoana, / Figlio di un povero cavaliere, Sier Escort, / E trasse gran piacere da chançons…»
Dalle chançons sue e di altri trovatori trasse un non minore piacere lo stesso Pound, come attesta l’inizio del Canto: «Guillaume esaurì le sue rendite / (Settimo di Poitiers, nono di Aquitania) / «Tant las fotei com auzirets / Cen e quatre vingt et veit vetz…»».
Ancora una volta il lettore, giovane o no, può trarre tanto profitto quanto diletto dalla nota. Guillaume è Guglielmo di Aquitania, che aveva ereditato quindicenne un dominio che andava dai Pirenei alla Loira. Impulsivo e libertino, era per Pound il più «moderno» dei trovatori. La chançon qui citata si intitola Farai un vers, pos mi somelh (Scriverò un verso, poi schiaccerò un pisolino), e Guillaume vi parla di un fine settimana trascorso con due nobildonne: «Le fottei, come sentirete / per ben cento e ottantotto volte».
Citare da Pound, ha scritto Marianne Moore, è «estrarre aculei da un porcospino». Strappiamone un ultimo, non meno puntuto del precedente, dal Canto V: «Sprona Barabello / L’elefante del Papa, né ha corona, dove Mozarello / Prende la via di Calabria, e alla fine / È soffocato sotto un mulo, fine da poeta, / Giù in pozzo di piscia, oh fine da poeta».
La nota, di nuovo, vale la pena. Barabello e Mozarello sono due poeti vicini a papa Leone X. Il primo, abate di Gaeta, aspirava a essere incoronato poeta, come Petrarca. Il papa gli offre l’elefante, ricevuto in dono dal re del Portogallo, per raggiungere il Campidoglio, ma l’impresa non gli riesce. Mozarello, autore di versi latini con il nome di Arelius Mutius, ha dal papa un incarico vicino a Rimini, ma è spinto dagli abitanti in un pozzo insieme al suo mulo.
Per Pound «la cosa che importa, in arte, è una sorta di energia, qualcosa più o meno simile all’elettricità o alla radioattività, una forza che trasfonde, salda e unifica». Da quella radioattività Valduga si è lasciata contagiare, e perciò stesso contagia noi.
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento