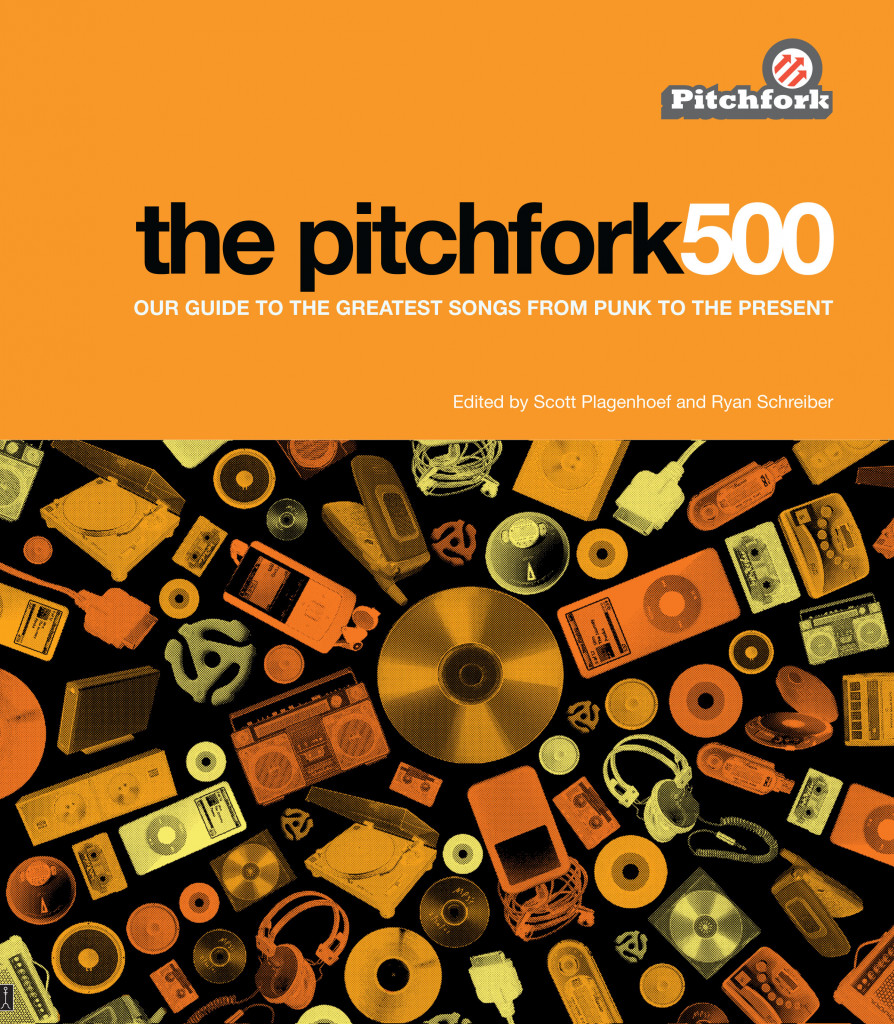
Pitchfork & Co., la musica è finita
Sembra una delle tante leggende un po’ romanzate dell’epica rock, ma corrisponde alla realtà. La storica band dei Cream, uno dei trii più esplosivi nella scena musicale dei Sixties, si sciolse per colpa di una recensione. La formazione composta da Eric Clapton alla chitarra, Jack Bruce al basso e Ginger Baker alla batteria, nel marzo del 1968 era all’apice della fama ed era impegnata in un tour americano che fece tappa a Boston. La loro esibizione alla Brandeis University fu seguita da uno studente che scriveva per un giornale universitario locale ed aveva iniziato a collaborare con un magazine musicale nato da poco, Rolling Stone.
Quell’aspirante giornalista si chiamava Jon Landau. Il concerto iniziò in clamoroso ritardo e deluse il giovane critico che dopo aver stroncato la performance sulla testata universitaria, rincarò la dose qualche settimana dopo proprio su Rolling Stone, la cui fama come voce della cultura giovanile si stava consolidando. Landau se la prendeva soprattutto con Clapton che ai tempi era considerato il miglior chitarrista rock sulla piazza, tanto che circolava lo slogan «Clapton is God». «Il problema – diceva la recensione – è che, pur avendo un vasto potenziale creativo, al momento non ha ancora iniziato a realizzarlo».
La redazione consiglia:
«Solo per me», commedia erotica nel mondo dello strip-teasePoi rincarava la dose: «È un virtuoso che esegue idee altrui». Anche gli assolo del musicista venivano messi in discussione e presentati come derivativi e in parte copiati dai grandi del blues. Dirà Clapton: «Per tutto il periodo dei Cream ho cavalcato il mito di “Clapton è dio”. Poi abbiamo avuto la nostra prima recensione negativa su Rolling Stone. La rivista pubblicò un’intervista con noi, seguita da una recensione che diceva quanto noiosa e ripetitiva fosse stata la nostra performance. Ed era vero! Ero in un ristorante e sono svenuto. Mi ripresi e decisi che era la fine della band». Confermerà Ginger Baker: «Era un tipo molto sensibile e sono convinto che l’articolo gli abbia fatto molto male. Era la sua rivista preferita e leggere una cosa del genere lo ha ferito».
Insomma, esisteva un’epoca in cui una recensione su una rivista musicale poteva cambiare la storia. Jon Landau lo farà di nuovo qualche tempo più tardi, ma questa volta non con una stroncatura. Presenterà il giovane Bruce Springsteen come il futuro del rock, cosa di cui era così convinto da rinunciare a qualsivoglia carriera giornalistica per diventare il manager di quella promettente star. Sarà uno dei produttori di Born to Run.
CUORE «INDIE»
«O tempora, o mores!», amavano dire i latini. L’editoria musicale è entrata in crisi non da oggi, ma ha fatto un certo scalpore la notizia che il sito Pitchfork, pubblicazione nativa digitale e diventata nel tempo cuore della cultura musicale «indie» e guida spirituale di una certa musica alternativa, verrà assorbito dalla testata GQ con l’effettivo rischio di diventare solo una rubrica musicale addomesticata se non di scomparire del tutto.
Pitchfork è stata una delle prime testate musicali del web. Era il 1995 e in tempi in cui l’accesso a internet era ancora privilegio di pochi, un diciannovenne di Minneapolis, Ryan Schreiber, decise di aprire quella che ai tempi veniva definita una «web-zine» chiamata Turntable, con interviste, recensioni e aggiornamenti mensili. La testata cambiò nome e divenne Pitchfork («forcone», a quanto pare un nome ispirato dal film Scarface) e mutò da fanzine a vera testata online con aggiornamenti quotidiani. Essere arrivati prima di altri a capire che il futuro era nell’informazione digitale, anche per quanto riguardava la musica, fu la chiave di un successo che negli anni è cresciuto.
La redazione consiglia:
Perturbazione. Ecco la buona novella del tempo rubatoNon fu comunque facile. Agli sgoccioli del XX secolo il web era il futuro, ma non ancora il presente. La tecnologia non era al passo con la creatività e inoltre in molti cercavano di cavalcare l’onda, spesso con operazioni ambiziose. La rivista online ai tempi più evoluta era Addicted to Noise, che proponeva non solo articoli, ma anche brevi preview audio degli album. Per Pitchfork i primi profitti arrivarono solo nel 1999. Il vero successo arrivò con gli anni Duemila. La musica diventava digitale, nascevano Napster e il file sharing. Tutto poteva essere ascoltato con facilità. Pitchfork si ritagliò una nicchia di credibilità e autorevolezza, soprattutto grazie alle recensioni che esaltavano ogni musica alternativa o indipendente a discapito del mainstream.
Nulla è più evidente che nelle parole della recensione che salutava l’album Kid A dei Radiohead uscito nel 2000, un disco che di fatto archiviava proprio quel «classic rock» che Pitchfork voleva raffigurare come ormai stantio. «Persino l’acclamato OK Computer è stato spostato di un posto nel Valhalla – scriveva il recensore estasiato -. Kid A rende il rock and roll puerile (…) Paragonarlo ad altri album è come paragonare un acquario alla carta da parati blu. E non perché sia jazz o fusion o ambient o elettronico. Le classificazioni non vengono in mente una volta entrati in questo mondo espansivo e ipnotico (…) È un’esperienza emotiva e psicologica. Kid A suona come un cervello annebbiato che cerca di ricordare un rapimento alieno. È il suono di una band, e del suo leader, che perde fiducia in se stessa, si distrugge e successivamente ricostruisce un’entità perfetta».
Il sito noto per dare voti da 1 a 10, con tanto di decimali, ovviamente premiava il disco dei Radiohead con un 10 pieno. Per capire la linea scelta dalla testata basta confrontare questa recensione con quella di All that You Can’t Leave Behind degli U2, album che uscì in contemporanea a quello dei Radiohead e che finirà per vendere 12 milioni di copie. Il voto era 5, ma le parole erano anche più crude: «Cercando così duramente la loro anima, gli U2 si sono tolti la pelle e tagliati la testa, lasciando solo un’approssimazione lobotomizzata della loro gloria».
Per molti rimarrà imperdonabile la colossale stroncatura di Lateralus dei Tool accolto con il voto 1,9 e da una recensione (scritta da Brent Di Crescenzo, lo stesso autore del panegirico di Kid A) che era una grossa presa in giro della band. Andò anche peggio ai Metallica che si presero un voto inferiore all’unità per St. Anger, ma su questo, se non altro, molti fan del quartetto erano d’accordo. Il sito stesso ha poi elencato gli artisti più stroncati: Weezer, Foo Fighters, Coldplay, Eminem, Madonna, Nine Inch Nails e Interpol. Arrivò anche uno 0,0 a una riedizione di Music from «The Elder», l’ineffabile concept album progressive dei Kiss. Voti e giudizi a parte, Pitchfork riuscì a diventare tanto caustico quanto stimato. Portando in trionfo la nuova scena hip hop incarnata da Kanye West, il cantautorato non ortodosso di autori come Sufjan Stevens e il nuovo rock psichedelico di band come Tame Impala.
STRATEGIA
Questa strategia aveva portato alla crescita non solo dell’audience del sito, ma anche del business. Aperta una sede a Chicago dal 1999, Schreiber cercò di trasformare Pitchfork in una vera media-company creando nel 2008 prima una web tv e poi nel 2010 il sito parallelo Altered Zones, dedicato alla cultura underground. Nel 2012 arrivò Nothing Major, rivolto all’arte, alla grafica e alla fotografia. Ma nessuna di queste operazioni ebbe particolare successo, i siti paralleli chiusero, lasciando Pitchfork come unico brand. Sfortunata anche l’idea di creare uno spin-off cartaceo, The Pitchfork Review, che voleva diventare l’omologo del New Yorker per la musica indipendente contemporanea.
Nonostante gli obiettivi fossero quelli di creare una rivista elegante e di nicchia con una tiratura di poche migliaia di copie, l’esperimento durò solo 11 numeri. Forse non di ottimo auspicio fu l’idea di mettere sulla copertina del primo numero un’urna funeraria… L’unica operazione parallela che è rimasta attiva nel tempo è quella del Pitchfork Music Festival, un raduno musicale di tre giorni inaugurato un po’ in sordina nel 2006 a Chicago e poi sempre ripetuto (a parte gli anni della pandemia) fino all’edizione del 2023 che ha visto come headliner Bon Iver, The Smile e Big Thief.
Il festival, con formule diverse, è stato poi esportato in Europa, a Parigi, Londra e Berlino. I tanti esperimenti ambiziosi portarono a consolidare la credibilità del marchio, ma resero alla fine necessario guardarsi intorno per avere nuovi capitali. Nel 2015 si fece avanti il grande gruppo editoriale Condé Nast (Vogue, The New Yorker, GQ, Vanity Fair…) che acquistò la testata per una cifra non rivelata ai media, lasciando comunque alla guida Schreiber che salutò la partnership dicendo: «È davvero una grande cosa. Un momento straordinario per me e per Pitchfork. Sono passati vent’anni da quando ho iniziato a fare questo dalla mia cameretta. A pensarci è davvero folle oggi diventare parte di una realtà che include così tante leggendarie voci editoriali.
Significa anche che manterremo la creatività e l’indipendenza che abbiamo sempre avuto». L’entusiasmo durò poco. Nel gennaio 2019 Schreiber annunciava, con il comunicato di rito, ma senza fornire vere spiegazioni, la sua uscita da Pitchfork. «Non è una decisione facile – recitava la sua dichiarazione – ma è quella giusta da prendere». Intanto la testata che si era negli anni ribattezzata «La più rispettata voce nella musica» aveva già perso un po’ del suo accanimento anti-mainstream, ampliando lo spettro musicale e ospitando recensioni celebrative di dischi classici del passato, tra cui il repertorio di grandi artisti che probabilmente anni prima sarebbero stati schifati.
Un’evoluzione inevitabile per stare al passo con i tempi, ma che nascondeva una crisi sottostante. È arrivata quindi all’inizio dell’anno la notizia della fusione con GQ comunicata proprio da Anna Wintour, chief content officer di Condé Nast, e giustificata così: «Abbiamo fatto un’accurata valutazione della performance di Pitchfork. La decisione presa è la migliore per poter andare avanti, la nostra copertura della musica proseguirà e si svilupperà all’interno della compagnia». Nessuno a oggi sa ancora cosa riserva il futuro per il brand nato all’alba di internet.
La redazione consiglia:
Il mestiere e la musica militanteCerto è che Wintour, nella miglior interpretazione della parodia di se stessa, si è presentata a una riunione di redazione annunciando il licenziamento di buona parte dello staff. «Un particolare bizzarro – ha scritto sui social una giornalista lasciata a casa – è che Anna Wintour in una stanza al chiuso e seduta al tavolo non si è neppure tolta gli occhiali da sole mentre ci diceva che ci avrebbe cacciato. L’indecenza che abbiamo visto dal management è terrorizzante».
Il gruppo Condé Nast, secondo quanto ha riferito il New York Times, è sì un gigante, ma dai piedi di argilla: due miliardi di dollari di fatturato l’anno con perdite però annuali di 100 milioni. Ha commentato Schreiber: «Sono estremamente rattristato dalla notizia che Condé Nast ha scelto di ristrutturare Pitchfork e di licenziare gran parte del suo personale, compresi alcuni che sono stati parte integrante delle sue attività per molti anni. Un abbraccio a tutti coloro che sono stati colpiti e speriamo nel meglio per il suo futuro».
I fan dei Tool, degli U2 e magari l’unico estimatore della svolta progressive dei Kiss probabilmente avranno festeggiato, ma la notizia ha fatto scalpore nel mondo dei media americani perché per molti rappresenta un momento di svolta per quello che rimane dell’editoria musicale. «La fine di Pitchfork è un presagio orribile per il futuro del giornalismo musicale – ha scritto Chris Richards sul Washington Post -. Se la critica musicale è diventata una pratica in via di estinzione in pubblicazioni con un’influenza massiccia, una storia profonda e un ampio pubblico di lettori, dove potrà mai sperare di sopravvivere?».
IN VIA DI ESTINZIONE
L’editoria legata al pop e al rock è entrata in una crisi ormai cronica dall’inizio degli anni Duemila. Quella cartacea è quasi in via di estinzione. Il primo vero segnale di un’epoca che si stava per concludere fu la chiusura di una delle più prestigiose riviste inglesi, Melody Maker, tra le più antiche pubblicazioni musicali, fondata nel 1926 e scomparsa nel dicembre del 2020. Confluì nella testata rivale NME New Musical Express, che ha cessato le pubblicazioni cartacee nel 2018, per ripresentarsi, ma con cadenza bimestrale (e si ignora con quale futuro) a fine 2023.
Il mensile Q, fondato nel 1986, ha chiuso nel luglio 2020, cercando di ritornare l’anno scorso come magazine online. Nelle edicole inglesi sono sopravvissute le testate che si rivolgono a un pubblico più maturo come Mojo, Uncut o Record Collector, mentre altre, come la metallara Kerrang!, hanno ridotto drasticamente le uscite annuali. Negli Stati Uniti Spin, voce dell’alternative rock, ha rinunciato all’edizione su carta nel 2012, sopravvive Rolling Stone ma si è trasformato da quindicinale in mensile, abbandonando sempre di più l’idea, ormai un po’ démodé, di essere la «bibbia del rock».
La redazione consiglia:
Led Zeppelin, ritratto di un’ebbrezza fra immagini e canzoniLa moria ha coinvolto inevitabilmente anche l’Italia, dove il mercato è sempre stato molto ridotto; sopravvivono, tra mille difficoltà, ormai poche testate, gran parte delle quali dedicate al rock classico e rivolte a lettori in età. Anche l’informazione musicale online però nel corso degli anni ha fatto fatica ad affermarsi. La già citata Addicted to Noise era così innovativa agli albori di internet da non essere sostenibile e scomparve nel 2000. Nel 1994 Blender fu la prima testata a sperimentare la multimedialità, debuttò su cd-rom, lanciando le prime forme di advertising digitale; si trasferì sul web nel 1996, per poi cercare fortuna nel cartaceo sopravvivendo, a stento, fino al 2009.
Come cantava Bob Dylan, «The Times They Are a-Changin’» e questo vale anche per il modo in cui il pubblico consuma, vive e si informa di musica. Le recensioni oggi si leggono sui social. Le piattaforme streaming come Spotify, Apple Music, YouTube Music, non solo propongono contenuti on demand, ma aggiornano gli utenti su nuove uscite, preparando playlist mirate o conformate ai gusti dell’ascoltatore. Il futuro però è un’incognita perché anche lo streaming musicale sta mostrando le sue criticità. Gli artisti sono pagati troppo poco e i ricavati spesso non coprono le spese. Spotify, che conta 230 milioni di abbonati e che influenza i gusti a livello globale, ha annunciato a fine 2023 il licenziamento di un quinto della forza lavoro. 1.500 dipendenti saranno lasciati a casa. Una politica aggressiva di posizionamento sul mercato ha inciso sui bilanci, facendo registrare una perdita di 462 milioni di dollari nei primi nove mesi del 2023.
Ma oggi è comunque lo streaming a dominare il mercato e anche il modo in cui ci si informa sulla musica. In fondo perché leggere quando si può semplicemente ascoltare? Ha provato a rispondere il cantautore americano Josh Ritter, commentando la notizia sul destino di Pitchfork: «Amare la musica è una cosa, ma tentare di tradurre queste emozioni ineffabili in parole per il resto di noi, richiede talento e coraggio e un bellissimo ottimismo umano». Se state leggendo queste pagine probabilmente c’è qualcun altro che la pensa così.
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento