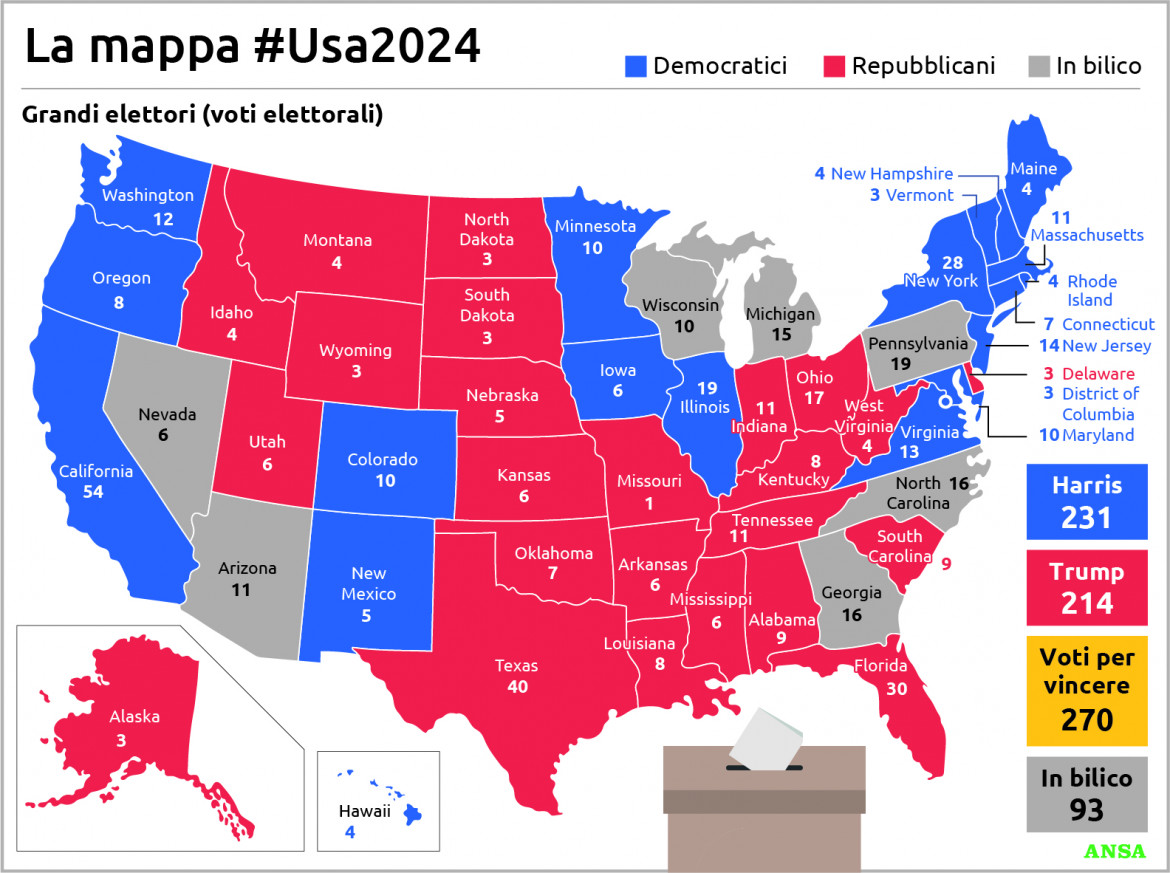Paul Auster, affondo nelle pagine di una tenace predilezione
Scrittori statunitensi Banditi i rimandi accademici e teorici dalla ricognizione della vita e degli scritti di Stephen Crane, Paul Auster completa il suo ritratto del «Ragazzo in fiamme» con citazioni e ipotesi puntuali: da Einaudi
 Ritratto del capitano James Cunningham, ufficiale unionista nella Guerra civile, 1863; colorazione: Jordan J. Lloyd/Dynamichrome
Ritratto del capitano James Cunningham, ufficiale unionista nella Guerra civile, 1863; colorazione: Jordan J. Lloyd/DynamichromeScrittori statunitensi Banditi i rimandi accademici e teorici dalla ricognizione della vita e degli scritti di Stephen Crane, Paul Auster completa il suo ritratto del «Ragazzo in fiamme» con citazioni e ipotesi puntuali: da Einaudi
Nel 1943 Edmund Wilson raccolse (in una antologia poi riproposta in edizione arricchita nel 1953) un’ampia scelta di saggi sulla letteratura americana i cui autori non erano critici e storici letterari, bensì gli stessi scrittori che avevano contribuito a formare quella storia letteraria. Rubando il titolo a un celebre saggio di Melville su Hawthorne, The Shock of Recognition, Wilson decise di privilegiare i rispecchiamenti di un artista nell’altro, quelle reciproche affinità, scoperte fra esaltazione e turbamento; ma non mancò d’includere anche pagine di critiche serrate (per esempio l’attacco di Mark Twain alle «offese letterarie» di James Fenimore Cooper), convinto che queste opposizioni si fossero anch’esse rivelate indispensabili alla crescita letteraria del paese. Aggiornare l’opera di Wilson, porterebbe a aggiungervi saggi come quello di Charles Olson su Melville (Chiamatemi Ismaele, 1948), di Adrienne Rich su Emily Dickinson (Vesuvius at Home, 1975), o di Eliot Katz su Allen Ginsberg (The Poetry and Politics of Allen Ginsberg, 2015), ma in questa ideale prosecuzione del volume di Wilson difficilmente si giustificherebbe l’inclusione dell’imponente biografia letteraria di Paul Auster, Ragazzo in fiamme Vita e opere di Stephen Crane, traduzione di Cristiana Mennella (Einaudi, pp. 1006, € 24,00).
A parte il fatto di essere entrambi nati nella città di Newark, New Jersey, i due scrittori sembrano avere, infatti, ben poco in comune: la prosa cerebrale, fitta di rimandi metaletterari e intertestuali di Auster, è assai distante dallo stile «impressionistico» di Crane, impegnato a riprodurre le sensazioni fisiche e istintive dei suoi protagonisti, con scelte metaforiche e lessicali spesso sorprendenti. A muovere Auster a lavorare per tre anni su questo Burning Boy – morto nel 1900, prima del suo ventinovesimo compleanno – è stata la consapevolezza di trovarsi dinanzi a un genio, la cui reputazione è tutt’altro che solida e indiscussa: la critica accademica su Crane (dalla quale Auster rivendica di essersi tenuto debitamente distante) è sterminata, ma questo non sembra avergli garantito quella posizione inattaccabile di cui godono altri classici americani. Sebbene Il segno rosso del coraggio – un romanzo che sta alla base di tutta la narrativa di guerra degli ultimi centoventi anni – sia stato tradotto più volte, come peraltro diverse opere che Auster considera a ragione capolavori assoluti come il romanzo breve Maggie, ragazza di strada, la novella Il mostro, i racconti La sposa arriva a Yellow Sky, The Blue Hotel, La scialuppa, nessun editore s’è però mai preso la briga di proporre un’edizione organica degli scritti maggiori di Crane, che dovrebbe includere anche una selezione delle sue raccolte di poesie, da I cavalieri neri a La guerra è buona.
Il caso dell’Italia è tutt’altro che isolato. E proprio perciò Auster passa in rassegna, dedicandovi più della metà del volume, tutti gli scritti di Crane, esplorando con finezza ogni singolo testo, compresa la vasta produzione giornalistica, e prestando una particolare attenzione alle corrispondenze di guerra. Dal suo close reading è volutamente bandito ogni specialismo o riferimento teorico, e grazie a numerosissime citazioni l’intento è avvicinare la specificità di Crane fermandosi sulle singole parole, sulle costruzioni sintattiche, sulle metafore, talvolta bizzarre eppure quasi sempre appropriate: una per tutte, la celebre immagine, in The Red Badge of Courage del «sole rosso appiccicato al cielo come un’ostia». Sebbene Auster non intenda offrire letture innovative dei testi di Crane, le sue discussioni talvolta aprono prospettive interessanti anche per chi conosce non solo quei testi, ma la relativa critica accademica; e almeno nel caso dell’ampia analisi riservata al romanzo La terza violetta, Auster sorprende anche lo specialista, trovando insospettati motivi d’interesse in un’opera in genere bistrattata persino dai più devoti ammiratori dello sfortunato scrittore americano. Anche la tentazione di cedere a qualche lettura in chiave autobiografica è perfettamente comprensibile in un lavoro dove alla vicenda umana di Crane è dedicata una grande attenzione: le complesse relazioni con i numerosi familiari, le vicende amorose (soprattutto quella con Cora Taylor), le amicizie con Howells e Garland, prima, e poi con H. G. Wells e con Conrad, sono tutte passate al setaccio e laddove – come spesso accade – incontra vuoti incolmati, Auster formula con puntiglio le sue ipotesi esplicative, senza mai forzare il lettore a privilegiarne una. Ma è soprattutto nel descrivere la lotta quotidiana di Crane per sopravvivere con i soli proventi della propria arte che si fa palpabile la partecipazione sincera di Auster alle sofferenze materiali e psicologiche di uno scrittore che, sino alla fine, si rifiutò caparbiamente di divenire «un orso ammaestrato» ai gusti del pubblico.
In tutta la lunga discussione riservata a Il segno rosso, tuttavia, Auster non fa mai cenno al ritrovamento del manoscritto originario del romanzo, e alle sue sensibili difformità rispetto al testo poi pubblicato. Se è vero che mancano riscontri obiettivi in grado di svelarci in quale misura Crane concordò tagli e revisioni con l’editore, e sino a che punto viceversa tali cambiamenti gli vennero più o meno imposti, è indubbio che l’opinione di Auster su questi travagli sarebbe stata interessante, anche perché convergono su questo episodio molte ricorrenze tematiche del libro: il rapporto di Crane con la nascente cultura di massa, il suo costante ricorso al registro ironico, l’attenzione per la «duplicità del reale».
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento