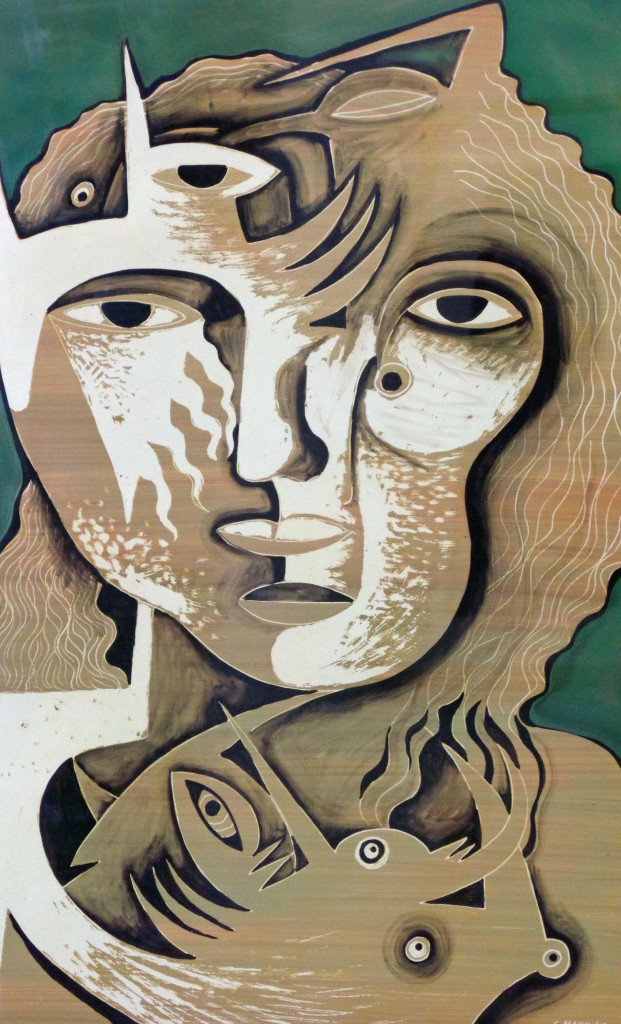
Miguel Barnet, uno schiavo in fuga nella Cuba dell’800 e il suo «romanzo documentale»
A proposito del suo lavoro cinematografico, soprattutto per la parte che riguarda i suoi geniali documentari, sempre in bilico tra stilizzazione e racconto documentale, il regista tedesco Werner Herzog ha negato qualsiasi pretesa di «realismo», e ha parlato della ricerca di una «verità estatica», effetto che si può produrre secondo lui soltanto attraverso l’invenzione di una forma, nella quale sono all’opera inevitabilmente i meccanismi del novel.
Nel 1963, a pochi anni dalla conclusione dell’insurrezione rivoluzionaria cubana, un ragazzo di ventitre anni che stava studiando da etnologo venne a sapere dai giornali dell’Avana che era ancora in vita uno schiavo nero sfuggito da giovane alla propria condizione e rifugiatosi nella natura, sul «monte». Di persone così, fino alla fine dell’Ottocento, ce ne furono moltissime: erano chiamate nei paesi ispanoamericani e caraibici cimarrónes. L’uomo che il giovane Miguel Barnet decise di intervistare di anni ne aveva allora centotre, e dopo essere sfuggito alla violenza coloniale aveva lavorato una vita nella filiera dello zucchero, e aveva combattuto per la causa indipendentista durante la guerra del 1898.
Incoraggiato dai suoi maestri ad approfondire l’incontro – in special modo dal grande studioso messicano Ricardo Pozas, che Barnet avrebbe poi citato come sua maggiore fonte di ispirazione –, il giovane etnologo si intrattenne per mesi, poi per anni, con il veterano, al secolo Esteban Montejo, prendendo infine a registrare le conversazioni nelle quali l’uomo raccontava la sua visione animistica della natura, le tradizioni legate al culto della santería, e le sue personali avventure: una vera e propria epopea individuale. Riscrivendola, Barnet capì di averne tratto un’opera del tutto eccedente i suoi cauti intenti antropologici, che si collocava in quella zona felicemente ambigua tra finzione e documento, avvicinandosi al «vero» quanto più si valeva della forza poetica di cui era intrisa la narrazione.
Scritto direttamente alla prima persona singolare nella forma di un lungo monologo, intervallato da note dell’autore a commento, e sistemato secondo l’ordine cronologico dei fatti narrati, Biografía de un cimarrón fu presto tradotto in molte lingue e venne accolto con entusiasmo soprattutto, ma non solo, in seno a quella comunità di intellettuali europei apertamente schierati dalla parte del comunismo, ai quali Barnet offriva il devoto ritratto di «un autentico protagonista del processo storico cubano», con «un grado di onestà e spirito rivoluzionario ammirevoli». Tessero le lodi del libro, tra gli altri, Peter Weiss, Hans Magnus Enzensberger – il quale riversò la voce di Esteban in un lavoro teatrale –, Italo Calvino, che lo presentò ai lettori della Einaudi, ma anche scrittori come Graham Greene o il più importante uomo di lettere conterraneo di Barnet, Alejo Carpentier.
Già soltanto questo elenco eterogeneo di personalità suggerisce la magnitudine ma anche l’eccentricità di quella novità letteraria: aspetti che la nuova edizione italiana, ora da Quodlibet a sessant’anni da quella einaudiana, esalta e, per certi versi, amplifica: c’è innanzitutto un nuovo titolo, più aderente alla lettera dell’originale, Cimarrón Biografia di uno schiavo fuggiasco (nella precedente traduzione di Marina Piazza e Gabriella Lapasini revisionata da Elena Zapponi, curatrice e autrice anche di un saggio conclusivo, pp. 235, € 18,00), che manda in soffitta quella Autobiografia di uno schiavo originariamente collocata nei «Saggi» Einaudi; viene ripresa l’introduzione di Calvino, che contiene a sua volta un commento di Carpentier; infine, è presente un saggio che Barnet scrisse alcuni anni fa, dunque di molto posteriore alla prima edizione del 1966. Letto insieme agli altri apparati, questo testo autoriale propone, sotto una luce inedita, questioni che i commenti coevi al libro lasciarono quasi del tutto inesplorate, vuoi per la temperie ideologica del tempo, vuoi per la concitazione del momento editoriale.
Mentre Zapponi si impegna nel suo saggio a evidenziare il prezioso apporto di Cimarrón allo studio etnologico della schiavitù, ricorrendo a diversi riferimenti bibliografici, Barnet si addentra in un autocommento di carattere letterario, citando in poche pagine i suoi ammiratori e non solo, da Enzensberger a Weiss a Greene, Carpentier, Cortázar, Cela, Rulfo, Poniatowska e Tournier.
Certo è che i due aspetti, quello documentale e quello letterario, concorrono alla (intatta) grandezza del libro, come già avevano sintetizzato Carpentier («un lavoro condotto con penna di poeta e rigore di etnografo») e Calvino («uno di quei rari casi in cui il ‘materiale’ etnografico e sociologico assume spontaneamente, per la sua forza interna, un valore poetico e letterario»).
Dopo aver letto, o riletto, le «incredibili» (nella definizone di Barnet stesso) vicende di Esteban, la sensibilità contemporanea ne resta, tuttavia, in qualche modo urtata, e il lettore finisce per chiedersi cosa sia sopravvissuto della testimonianza del centenario, passata in primis dalle forche caudine della sua stessa memoria, poi da quelle del dialogo a voce, benché in parte registrato, con l’intervistatore, infine della rielaborazione in una pagina per forza di cose ficta.
A questo turbamento contribuisce lo stesso Barnet, quando annota a margine che a un certo punto Esteban «si identificò con me», oppure quando cade nella trappola autoriale della «non fiction», e scrive, ormai troppo tardi per guastare il suo capolavoro, che «ognuno è un solitario, e perché no, un cimarrón, così io e lui ci identificammo»: frase che oggi basterebbe forse da sola a sbarrargli l’ingresso in qualunque organigramma universitario.
Lo scrittore cubano dà del suo libro la definizione di «romanzo testimoniale». Eppure, forte sì di un flusso affabulatorio prodigioso, Cimarrón trascende la verità documentale per accostare piuttosto quella tendenza estatica di cui parlava Herzog, che immerso nella natura aspra e indifferente dei tropici girò alcune delle sue scene più iconiche.
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento




