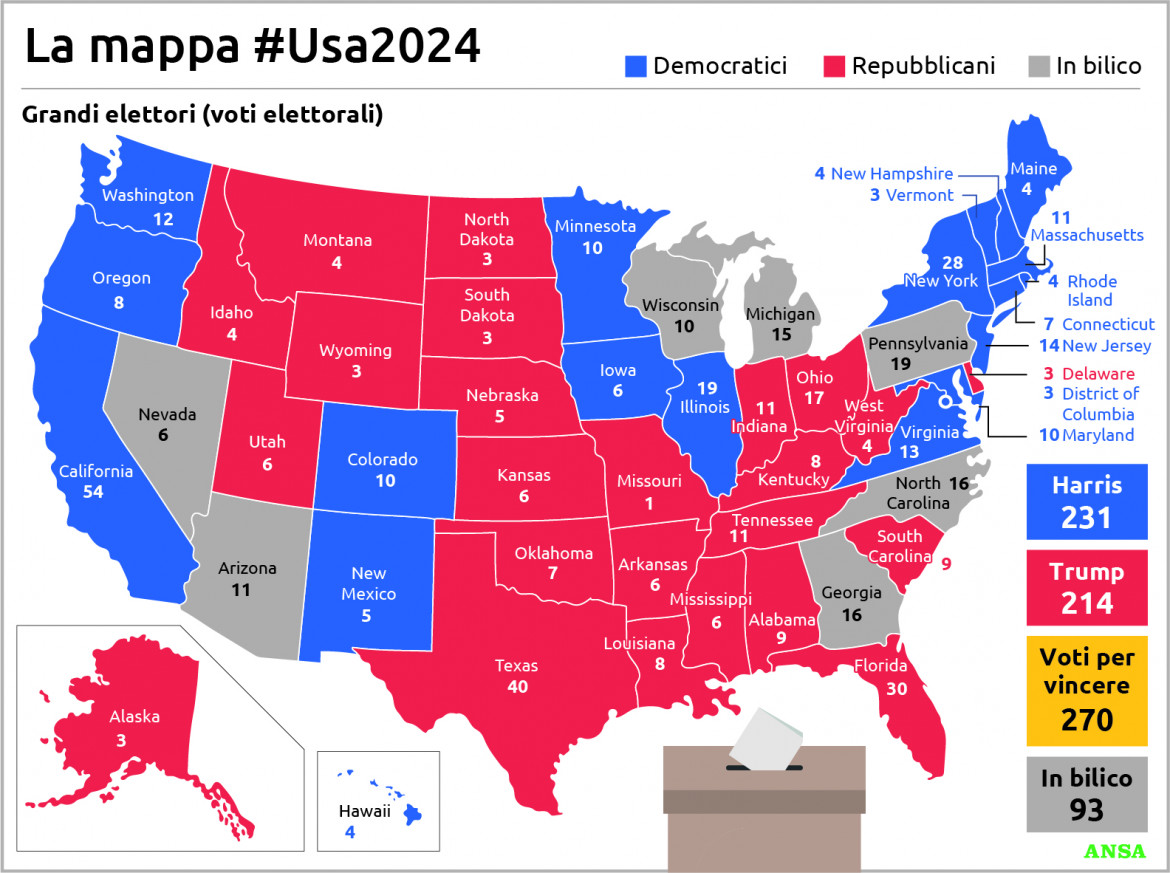L’ultimo enigma di Louise Glück
Poesia statunitense A un mese dalla sua scomparsa, una biografia intellettuale della poetessa americana, il cui ultimo libro, «Marigold e Rose», è un grazioso racconto che contrasta con l’asprezza consueta
 Alice Neel, «Le gemelle De Vegh», 1975
Alice Neel, «Le gemelle De Vegh», 1975Poesia statunitense A un mese dalla sua scomparsa, una biografia intellettuale della poetessa americana, il cui ultimo libro, «Marigold e Rose», è un grazioso racconto che contrasta con l’asprezza consueta
Nel 2020, quando a Louise Glück, scomparsa lo scorso 13 ottobre 2023 (era nata a New York nel 1943 da una famiglia ebraica di origini russe e ungheresi) venne dato il Nobel per le letteratura, un quotidiano la definì «la regina dei ghiacci della poesia americana». Chi le diede quel titolo forse ricordava I bambini annegati (The Drowned Children) una terrificante poesia inclusa in Descending Figure (1980) che le meritò l’accusa di odiare i bambini: «Lo vedi, non hanno giudizio. / Per forza poi annegano, / prima il ghiaccio che li porta sotto / e poi, per tutto l’inverno, le sciarpe di lana / che gli ondeggiano dietro mentre affondano / finché infine se ne stanno quieti. / E lo stagno li solleva nelle sue molte, nere braccia». Quello stesso anno fu il fuoco, non il ghiaccio, a prendersi la sua casa nel Vermont e quasi tutto quello che aveva. La reazione ai vari incidenti della sua vita, dall’anoressia nervosa che le costò sette anni di terapia fino all’incendio distruttore, fu una produzione poetica che sfidava ogni aspettativa: ci fu chi pensò di avere a che fare con un poeta confessionale, ma se poi vi cercava il ben noto pathos del confessionalismo non lo trovava. In Filadelfo (Mock Orange), inclusa in The Triumph of Achilles (1985), la raccolta che le diede un nome, un innocuo fiore da giardino è pretesto per una perentoria dichiarazione di anti-amore: «Te lo dico, non è la luna. / Sono questi fiori / che illuminano il giardino. // Li odio. / Li odio come odio il sesso, / la bocca dell’uomo / che sigilla la mia bocca, il corpo / dell’uomo che mi paralizza – // e il grido che esce sempre, / l’infima, umiliante // premessa dell’unione».
Considerati un classico della poesia femminista, sono i versi più antologizzati di Louise Glück. Che cosa vi dobbiamo leggere? Forse solo il puro, assoluto desiderio, ostile ad ogni altro coinvolgimento, di stare «tutta sola con la lingua inglese», come diceva Gertrude Stein a Parigi. Peraltro, chi oggi le diagnosticasse sessuofobia o androfobia (qualche voce in merito si era levata) si esporrebbe a sua volta all’accusa di essere «asefobico» (fobico verso gli asessuali). I tempi sono cambiati per tutti. In realtà in Louise Glück c’è la mera constatazione del fatto che uomini e donne possono essere uniti solo dalla consapevolezza di ciò che li separa. Basta leggere il seguito per comprendere che alla base del componimento sta una domanda alla quale nessuno, né con l’aiuto del sesso né con il suo rifiuto, può davvero rispondere: «Stanotte, tra me e me / ascolto la domanda e cerco la risposta / fusa in un suono / che sale e sale e poi / si spacca nei vecchi sé, / gli stanchi antagonismi. Vedi? / Ci hanno preso in giro. / E il profumo del filadelfo / entra dalla finestra. // Come faccio a riposare? / Come posso sentirmi soddisfatta / se nel mondo / c’è ancora quell’odore?».
Nel 1992, in contemporanea con la pubblicazione di Wild Iris, il suo libro forse più noto, ci fu un incontro alla Yale University (dove poi Louise Glück avrebbe insegnato «pratica della poesia») in cui le fu chiesto a quale poeta uomo o donna si ispirava e chi l’aveva maggiormente influenzata (questioni cruciali in quegli anni a Yale, sia per chi seguiva le teorie sull’ansia dell’influenza di Harold Bloom, sia per chi le rifiutava abbracciando il testualismo e la decostruzione). Louise Glück rispose: «La prossima domanda, per favore». Al fondo della sua poesia c’è un solo, onnipresente desiderio: quello di tagliare il cordone ombelicale. Di Iris selvatico (tradotto nel 2003 da Massimo Bacigalupo e ripubblicato dal Saggiatore nel 2020) un critico scrisse che l’autrice sembrava avere solo due preoccupazioni: i fiori e suo marito. Dal marito (il secondo) avrebbe divorziato quattro anni dopo. Dai fiori, mai, perché una parte significativa della poesia di Louise Glück consiste appunto nel dare voce ai fiori (nel caso di Iris selvatico, la conversazione si svolge tra i fiori, la giardiniera Glück e Dio stesso). Ma non c’è nulla di arcadico nelle sue predilezioni floreali, così come non c’era nella verzura descritta con precisione botanica da Marianne Moore, la stessa che nella sua celebre Poetry (1919) definì l’arte del verso come la costruzione di «giardini immaginari dotati di rospi autentici» («imaginary gardens with real toads»). Il che potrebbe far pensare, con qualche ragione, che nei giardini molto reali di Louise Glück i rospi siano i mariti.
Il tono scorbutico, a dir poco, l’incredibile durezza, l’ostinazione nel mettere i suoi lettori davanti a uno specchio che riflette solo le brame più inconfessabili, nonché il lavorio del risentimento – tanto interminabile quanto la terapia per uscirne – sono materiali poetici buoni come tutti gli altri, ma non sarebbero bastati a fare di Louise Glück una delle luci, per quanto raggelanti, della poesia contemporanea. Bisognava aspettare Averno del 2006 (anch’esso tradotto da Bacigalupo nel 2019 per Dante&Descartes e ripubblicato dal Saggiatore l’anno dopo) perché l’autrice svelasse quello che, retrospettivamente, si rivela come il suo mito fondatore: Persefone-Proserpina, la giovane rapita alla vita nei mesi invernali e che durante la bella stagione torna a rinverdire il mondo, ma da straniera, perché ormai la sua casa è l’Ade, dove regna da violata sovrana. L’opposizione reiterata tra l’Ade e il Giardino: dell’Eden, ma che non può dimenticare la sua origine infera –, lo sconcertante bipolarismo poetico (si vorrebbe seguire un filo, ma sono sempre almeno due, e sempre attorcigliati) sembrano trovare un respiro nei racconti in versi di A Village Life del 2009, ma non è proprio così. Chi parla è sempre Proserpina, e ciò di cui parla è ancora il gelo. Da Raccolto (Harvest): «E poi viene il gelo; del raccolto è inutile parlare. / Comincia la neve; finisce la finzione della vita (…) Ciò che vive, vive sottoterra. / Ciò che muore, muore senza lotta».
Ogni poeta risolve il proprio enigma con l’ultimo libro che pubblica: nel caso di Louise Glück quel libro è Marigold e Rose (sempre nell’ottima traduzione di Bacigalupo, Il Saggiatore, pp. 88, € 10,00), racconto di due gemelle appena nate, che non sanno ancora né parlare né gattonare ma hanno già un’intensa vita interiore. Fra sé e sé, Marigold legge libri con animali e persone e vuole scriverne uno anche lei, anzi sta già allineando le parole nella mente. Rose è interessata solo alla gente, non agli animali, e non intende scrivere nessun libro. È una bambina ordinata e perfettina, mentre Marigold è un po’ impacciata. Si invidiano a vicenda, ma si amano. Compiono un anno. Prima erano zero, adesso sono uno. Ma erano uno anche prima, quando erano un uovo. Forse lo sono ancora.
Non è un libro per bambini, anche se ai bambini lo si può leggere. Non è nemmeno un libro per adulti. È un libro per chi non ha mai deciso che cosa vuole essere, se adulto o bambino. Come libro, nemmeno decide se vuole essere prosa o poesia. È solo un raccontino grazioso. Ma che sia l’estrema testimonianza di una precoce scoperta della scrittura, questo è certo. Come è anche un dolce commiato, davvero inatteso per chi conosce tutta l’asprezza che lo precede.
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento