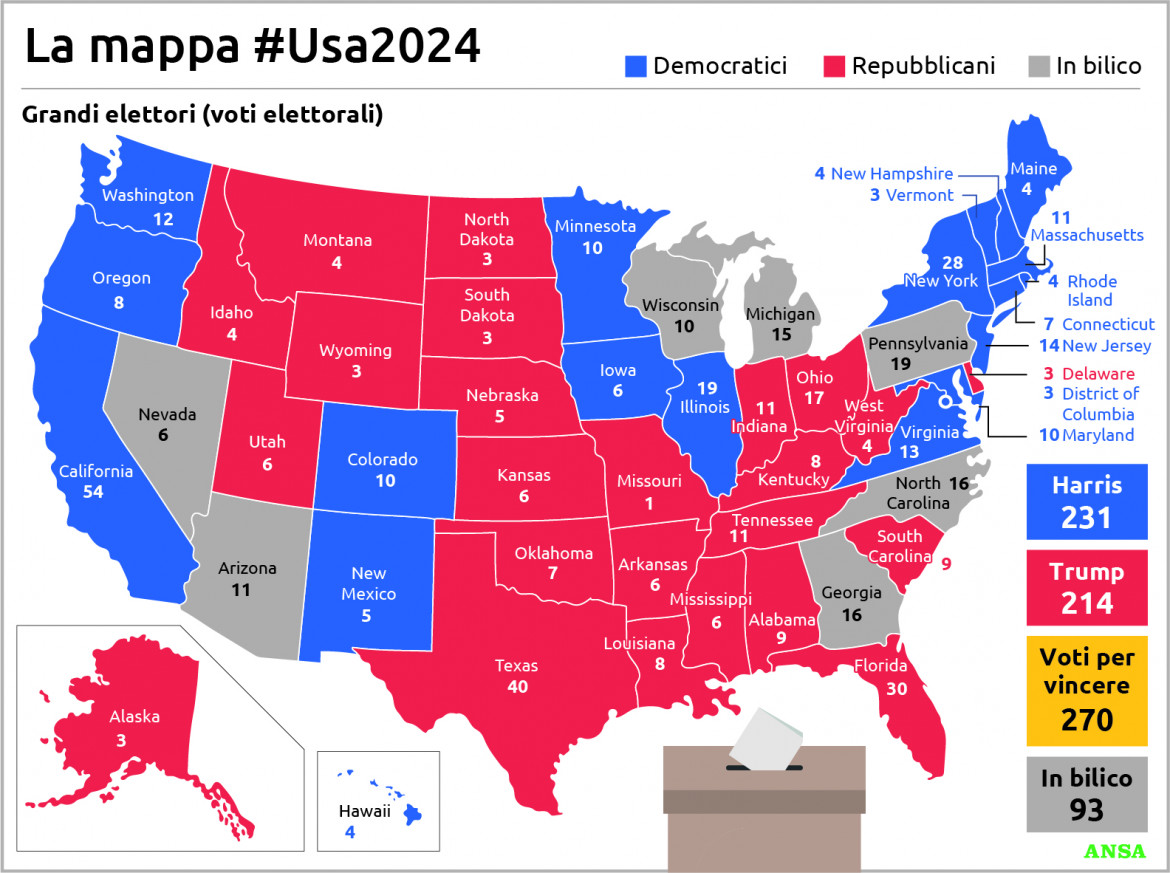Jennifer Pashley, destini liminali in un percorso noir
L'intervista Parla la scrittrice americana che pubblica «Gli osservati» per Carbonio. Identità di frontiera all’ombra della provincia tra povertà e dipendenze, violenza e passione. «Il nome della protagonista, Kateri, significa "colei che cammina a tentoni": un modo affascinante per condurre un’indagine criminale»
 Jenny Saville, «Red Fates», 2018
Jenny Saville, «Red Fates», 2018L'intervista Parla la scrittrice americana che pubblica «Gli osservati» per Carbonio. Identità di frontiera all’ombra della provincia tra povertà e dipendenze, violenza e passione. «Il nome della protagonista, Kateri, significa "colei che cammina a tentoni": un modo affascinante per condurre un’indagine criminale»
Shannon Jenkins è un sopravvissuto. Ma non solo all’incendio che il padre aveva appiccato alla loro casa nel tentativo di uccidere la moglie Pearl quando lui era ancora un bambino, e che gli ha lasciato delle profonde cicatrici sul corpo. È cresciuto con quella madre tossica su cui ha vegliato fin da piccolo e che ora, a 19 anni, non solo mantiene lavorando sottopagato in una caffetteria, ma su cui veglia per impedirle che possa farsi del male o farne, anche involontariamente, alla sorellina piccola che lui stesso ha aiutato a nascere e che non è mai stata registrata all’anagrafe né ha mai fatto un solo giorno di asilo o di scuola. Conforto e protezione, un abbraccio dove potersi finalmente abbandonare dopo aver dovuto assumersi ogni sorta di responsabilità, Shannon li cerca in due uomini, entrambi a loro modo indecifrabili, Baby Jane e Bear, che incontra a Spring Falls, il piccolo centro del nord dello Stato di New York non lontano dal confine canadese dove vive da quando è venuto al mondo. Quando sua madre viene uccisa in circostanze misteriose, ad indagare sulla vita di Shannon e sull’accaduto sarà Kateri Fischer, una giovane agente appena trasferita alla locale stazione di polizia dopo un periodo difficile e dei problemi solo fino ad un certo punto risolti con l’alcol.

Con Gli osservati (Carbonio, traduzione di Anna Mioni, pp. 300, euro 16,50) Jennifer Pashley torna ad indagare con gli strumenti del noir, anche se nel suo caso il riferimento ai codici del genere va inteso più come un mood narrativo che come il rispetto di regole e canoni fissi, sulla parte in ombra della società americana. Con il suo precedente romanzo, Il caravan (Carbonio, 2020) lo scenario era quello del profondo sud mentre in questo caso ci si trova dalle parti di Syracuse, ai piedi dei monti Adirondack, sotto un cielo cupo, tra ghiaccio e neve. In questi, che sono anche i luoghi dove Pashley, che insegna scrittura alla Syracuse University, è nata e cresciuta, la scrittrice vincitrice del premio per la fiction Lgbt della rivista Carve e del Red Hen Prize per la Women’s Prose, racconta di vite che sembrano abbandonate a se stesse, di «poveri bianchi» che tirano avanti ai margini delle comunità in cui vivono, di una ricerca dell’amore e di una qualche forma di protezione che spesso comporta per i protagonisti l’esporsi a rischi terribili. Con una lingua che restituisce tutta la contraddittorietà dei sentimenti, un approccio all’inchiesta criminale che muove da una profonda empatia nei confronti dei personaggi e uno sguardo puntato sui piccoli mondi della provincia, saturi di conflitti spesso inimmaginabili, Jennifer Pashley si conferma ancora una volta come una attenta e coinvolta analista di quanto si muove nelle viscere della società americana. Là dove sopravvivere può apparire talvolta come un lusso che si fatica a potersi permettere.
L’agente Kateri Fisher ha perso la madre, morta per un’overdose di farmaci, che aveva solo 16 anni e ha sofferto a lungo a causa dell’alcolismo. Nel suo lavoro si porta dietro tali ferite e ricordi negativi che l’ambiente difficile in cui dovrà indagare le appare in qualche modo famigliare. Le sue difficoltà emotive finiranno però per rivelarsi paradossalmente come uno strumento in più per risolvere il caso. Come è nata Kateri?
Troppo spesso nelle storie poliziesche chi indaga si trova del tutto all’esterno rispetto alle situazioni orribili nelle quali è costretto a muoversi. Solo che un detective che non conosce il dolore frutto delle dipendenze o della povertà, l’origine stessa del crimine su cui deve far luce, rischia di restare estraneo a quanto si è prodotto, non capire davvero come possono essere andate le cose. Questo però non vale per Kateri che, al contrario, si muove in un ambiente che conosce bene, immersa in un dolore che le è familiare. È questo che le consente anche di stabilire una forte empatia con le vittime, ma talvolta anche con i carnefici. La maggior parte dei detective sono raffigurati come persone analitiche che ricorrono alla logica per risolvere i casi. Al contrario, volevo che Kateri fosse guidata dal cuore.
Anche la scelta del suo nome ha a che fare con questo?
In effetti è così, il nome Kateri deriva dalla prima santa nativa americana, Saint Kateri Tekakwitha. Era stata sfregiata dal vaiolo, si negava qualsiasi conforto fisico e aveva difficoltà a vedere a causa della malattia. Il suo nome significa «colei che cammina a tentoni»: ho pensato che fosse un modo affascinante per condurre un’indagine e che racchiudesse tutte le caratteristiche del personaggio.
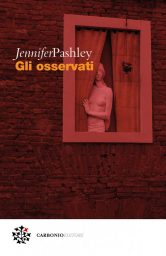
Volevo che il lettore condividesse ciò che gli stava accadendo, vivesse la medesima urgenza: la sua lotta, il suo desiderio, la sua angoscia. Inoltre, in Shannon si intravedono tali ferite che non poteva essere che la sua voce a raccontarle. In Kateri c’è invece qualcosa di più guardingo, i suoi pensieri e le sue emozioni affiorano con più difficoltà e perciò ho scelto che prendesse la parola nel romanzo con un po’ di distanza, attraverso la terza persona.
Interrogato dalla polizia, Shannon descrive così i suoi parenti, su cui, proprio per questo, di non aver mai potuto contare: «Poveri… stupidi, galeotti, tossici». In poche parole ha riassunto meglio che in un trattato di sociologia la condizione di milioni di americani. Cosa vi spinge a indagare questa parte del Paese e allo stesso tempo a restituire dignità e una voce a persone altrimenti dimenticate?
Mi sento vicina alla loro sofferenza. Ho vissuto anch’io dei guai simili ai loro. So bene come nonostante tutti i problemi con la droga, il crimine e le dipendenze siano persone capaci di amare le proprie famiglie e i propri figli. Penso che sia facile, per chi scrive o per la tv mettere in scena la caricatura delle persone povere e emarginate, ma personalmente voglio concedere loro la stessa umanità che viene data agli altri personaggi, perché è così che stanno le cose nella vita reale. E lo stesso vale per i personaggi queer. Il profilo di un personaggio gay non si riassume nel solo fatto che è gay, bensì nella sua storia, le sue lotte, ciò che realmente vuole dalla vita. La«queerness», come la povertà, è solo una parte di un quadro molto più ampio.
Come già per le storie di Khaki e Rayelle nel precedente romanzo, anche ne «Gli osservati» il desiderio, in quel caso tra donne in questo tra uomini, implica un pericolo, come se affidandoci a qualcuno per amore stessimo davvero mettendo la nostra vita nelle sue mani.
In effetti è un tema che mi affascina molto, anche perché credo che sia qualcosa di profondamente innato in tutti noi. Come esseri umani, inseguiamo sempre quella resa completa, anche quando può costarci molto. Ma è inutile forse sottolinearlo, visto che è uno schema che sembriamo programmati per ripetere.
Il noir si muove spesso all’interno di un immaginario etero e ispirato alla classe media. Cosa significa fare propri i meccanismi narrativi del genere con un approccio queer e che guarda agli ultimi?
Sono sempre stata attratta dai dispositivi del noir e dell’aspetto oscuro della suspense, ma in effetti quelle storie sono spesso ambientate tra la middle class, se non proprio tra i ricchi, e con personaggi eterosessuali. Quindi ho cercato di prendere gli elementi della suspense – un’alta posta in gioco, il tradimento, l’omicidio – e collocarli in un ambiente che mi era più familiare. Diciamo che ho lavorato per me stessa. Cercavo di scrivere qualcosa che mi rappresentasse, ma al tempo stesso di offrire la medesima rappresentazione a tutti quei lettori che spesso sono assenti dalle storie che leggono.
Il romanzo è ambientato ai piedi delle montagne. Colpisce che gli elementi naturali possano essere un sogno per i turisti e una specie di trappola per gli abitanti. La natura non è poi così neutrale?
In realtà è neutrale e, oserei dire, lo sono anche la maggior parte degli ambienti, città comprese. Molte persone si sentono intrappolate in zone delle metropoli che però ora vengono gentrificate da chi ha le risorse per poterlo fare. Tutto avviene a spese di chi è nato e cresciuto in quei quartieri. Si potrebbe forse parlare dei capricci della ricchezza che arriva e cambia tutto. Allo stesso modo nel romanzo c’è chi vuol costruire case per vacanze spiazzando chi in quei luoghi ci è sempre vissuto tra mille difficoltà. E anche la natura è a sua volta spiazzata.
Qual è il filo che lega «Il caravan» e «Gli osservati»?
Penso che le storie più interessanti avvengano all’intersezione di luoghi e elementi: queerness e povertà, o sesso e pericolo, o verità e bugie. Quella liminalità è il fondamento di entrambi i libri e il posto in cui mi sento più a mio agio.
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento