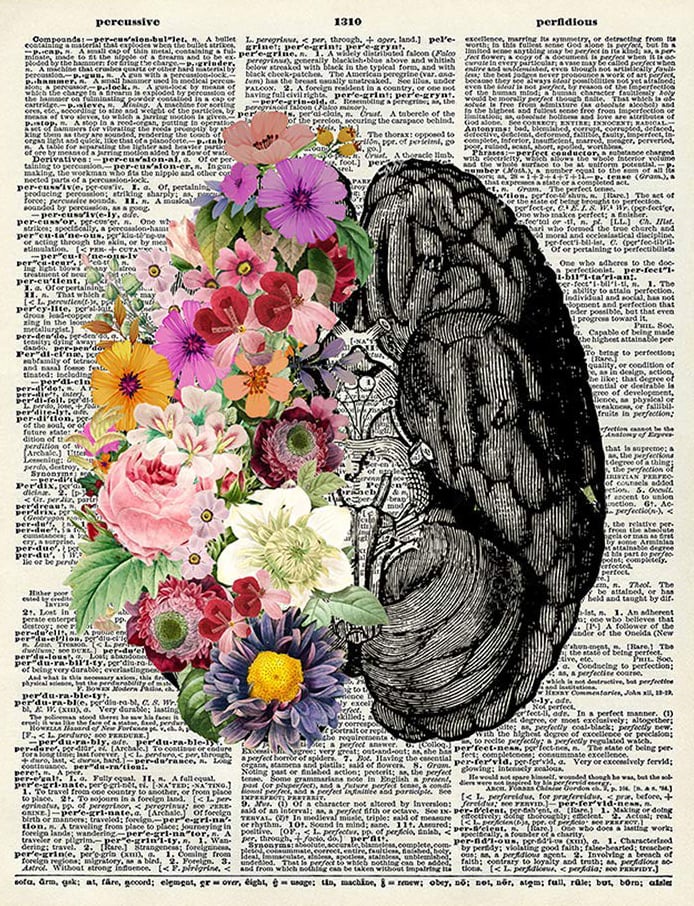In Siria c’è una rivoluzione contagiosa
Rojava Non solo curdi: dal 2012 il modello del confederalismo democratico ha coinvolto le tante comunità etniche e religiose del nord-est del paese. Arabi, turkmeni, siriaci, circassi, ezidi, armeni: «Siamo un popolo unico»
 Siria del nord-est: celebrazioni per il Newroz, la festa di primavera e del nuovo anno, da due millenni imprescindibile tradizione per diversi popoli del Medio Oriente, dai curdi ai persiani. Festa pre-islamica, cade il 21 marzo, equinozio di primavera. Viene tuttora celebrato, tra gli altri, in Iraq, Iran, Afghanistan e Turkmenistan – foto di Bekir Kasim/Anadolu Agency via Getty Images
Siria del nord-est: celebrazioni per il Newroz, la festa di primavera e del nuovo anno, da due millenni imprescindibile tradizione per diversi popoli del Medio Oriente, dai curdi ai persiani. Festa pre-islamica, cade il 21 marzo, equinozio di primavera. Viene tuttora celebrato, tra gli altri, in Iraq, Iran, Afghanistan e Turkmenistan – foto di Bekir Kasim/Anadolu Agency via Getty ImagesRojava Non solo curdi: dal 2012 il modello del confederalismo democratico ha coinvolto le tante comunità etniche e religiose del nord-est del paese. Arabi, turkmeni, siriaci, circassi, ezidi, armeni: «Siamo un popolo unico»
Quanti nomi ha Minbic? Gli arabi la chiamano Manbij, i circassi Mumbuj, i siriaci Mabbuh. Sono i curdi a chiamarla Minbic, ma la città è la stessa. Due millenni di storia, dicono; duemila anni che lo Stato islamico tra il gennaio 2014 e l’agosto 2016 era riuscito a occultare dietro la farsa crudele e sanguinaria di un’identità unica: araba e sunnita. Eppure in quella comunità della Siria del nord-est, a meno di quaranta chilometri dal confine con la Turchia, vivono persone diverse. Diverse etnie e diverse confessioni che nell’agosto di sei anni fa tornarono a colorare – letteralmente – la città liberata dal giogo islamista: l’ingresso delle Forze della Siria democratica (Sdf) segnò la fine dell’occupazione dell’Isis, insieme alle donne che in strada si sfilarono di dosso le lunghe vesti nere che le coprivano da capo a piedi. Sotto quel velo, le singole identità erano state annullate.
«QUELLI ERANO I PRIMI MESI di vita delle Sdf, una forza che oggi conta 100mila combattenti. Il 60% sono curdi; gli altri sono arabi, siriaci, armeni, assiri, turkmeni, circassi. Musulmani, cristiani, aleviti, ezidi». Syaman Ali ha poco più di trent’anni e i capelli imbiancati troppo presto. Siede nel suo ufficio nel quartier generale delle Ypg (unità curde di difesa del popolo) ad Hasakah, estremo oriente del Rojava. Prima della guerra civile siriana, studiava ingegneria meccanica. Oggi è portavoce delle Ypg. Dalla finestra socchiusa entra un refolo di vento caldo. Poco importa, il rito del tè non è negoziabile. Con il bicchiere in mano Syaman traccia i confini di un modello politico rivoluzionario per la storia contemporanea del Medio Oriente: la molteplicità sociale. «Il nostro sistema si basa sulla convivenza tra popoli. Lo abbiamo immaginato perché possa valere per l’intera Siria: una federazione di autonomie. Non è un’utopia: dopo la liberazione di Kobane, nel 2015, la gente tra Siria e Iraq, dal Rojava a Shengal, ha capito che l’Isis poteva essere sconfitto dai popoli. E ha conosciuto il nostro modello, il confederalismo democratico. Ci siamo allargati ad altre regioni: abbiamo liberato città a maggioranza araba come Raqqa e Deir Ezzor, quelle siriache, l’ezida Shengal in Iraq».
FONDATE NELL’AUTUNNO 2015, le Sdf sono l’ombrello sotto il quale si riuniscono le unità popolari di autodifesa della Siria del nord-est. Ci sono quelle curde, le Ypg e Ypj, le più note. Poi, distribuite su tutto il territorio, operano gruppi diversi, espressione delle comunità di appartenenza. Lo aveva detto Salih Muslim, co-presidente del Partito dell’Unione democratica, a marzo 2016, qualche mese prima della liberazione di Manbij: «Questa regione non è un Kurdistan autonomo. È parte di una Siria democratica e si allargherà all’intero paese. Vogliamo una Siria decentralizzata, in cui ognuno goda di pari diritti».
Il passaggio dal nazionalismo curdo al confederalismo democratico è l’humus da cui è sbocciata la rivoluzione del Rojava. Rojava significa «ovest» e indica quel pezzo di Kurdistan che dalla fine della prima guerra mondiale cade dentro i confini della Siria. Ci vivono cinque milioni di persone tra curdi, arabi, assiri, siriaci, armeni, turkmeni, ezidi. Per questo da anni ormai quell’esperienza politica si è rinominata, ribattezzata: Amministrazione autonoma della Siria del nord e dell’est, Aanes. Ha esplicitato, con il linguaggio, il suo obiettivo: la creazione di autonomie confederate dentro le frontiere statali. Alla base sta il processo dialettico promosso dentro il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Pkk), a partire dalla teorizzazione del suo presidente prigioniero, Abdullah Ocalan: la molteplicità etnica e confessionale, tradizionale tratto delle terre mediorientali, non deve tradursi in un moltiplicarsi di rivendicazioni nazionaliste, ma nel superamento dello stato-nazione (gabbia innaturale per il peculiare multi-culturalismo regionale) attraverso forme di democrazia diretta. Il confederalismo democratico, nuovo paradigma politico e sociale, supera il dominio di un popolo su un altro – o peggio, di una minoranza (un’élite politica, un partito, una setta) – e prende forma intorno all’unione volontaria di etnie e confessioni. È la nazione democratica che prende il posto dello stato-nazione, non dissolvendo le identità ma elevandole allo stadio di partecipazione politica, e che dà una soluzione non nazionalista ma egualitaria ai settarismi che negli ultimi decenni hanno costretto il Medio Oriente in guerra perenne.
«IN MEDIO ORIENTE lo stato-nazione esiste da appena cent’anni – ci spiega Dilar Dirik, ricercatrice all’Università di Oxford – I confini sono artificiali, disegnati dagli interessi coloniali britannici e francesi. Non corrispondono alla realtà culturale e sociale dei popoli. Per questo hanno creato conflitti settari tra comunità. I movimenti nazionalisti nella regione hanno usato il genocidio come forma di gestione delle cosiddette minoranze e delle identità esterne al perimetro identitario nazionale, seppur vivessero insieme da secoli. Il risultato è stato di massacri, annientamento, integrazione forzata, migrazione. Il confederalismo democratico nasce come critica a quel modello: lo stato non è la soluzione ma l’origine dei problemi. Creare un’altra entità statale avrebbe perpetrato il problema perché in Kurdistan non vivono solo curdi».
Se sul terreno il progetto di una nuova società prosegue attraverso le strutture del confederalismo democratico – comuni, assemblee, cooperative – molte delle energie sono da anni ostaggio delle minacce esterne, a partire dalle continue operazioni della Turchia contro le varie esperienze territoriali: il Rojava in Siria, Shengal in Iraq, Qandil nel nord iracheno.
A Tel Temer, comunità a maggioranza siriaca cristiana nel nord-est siriano, quella minaccia è fatta di attacchi via terra, tagli dell’elettricità e dell’acqua, campi confiscati. Siamo a qualche manciata di chilometri da Serekenaye, occupata nell’ottobre 2019 insieme a Gire Spi dalle truppe turche e dalle milizie islamiste alleate di Ankara. La linea del fronte, in questa piana color ocra, è plastica: è il fumo grigiastro che si solleva all’orizzonte, indizio dei colpi d’artiglieria turchi. «A Serekaniye i cristiani sono stati cacciati, le chiese svuotate. Hanno uniformi diverse ma sono come l’Isis». Aram Hanna è membro del Consiglio militare siriaco, unità parte delle Sdf. Guarda alla linea del fronte dal terrazzo di una casa: la famiglia che la abitava è fuggita, ora è il quartier generale del gruppo. Aram studiava letteratura inglese all’università quando l’Isis ha occupato la sua terra. «Da Raqqa ad Afrin, popoli diversi condividono lo stesso obiettivo – ci racconta – Siamo tutti siriani, vogliamo vivere qui parlando la nostra lingua e vivendo la nostra cultura. La Repubblica araba siriana, quella del governo Assad, si fonda sull’idea che esista una sola identità. Noi stiamo costruendo un paese libero, che tenga conto di tutte le differenze». «La società ci appoggia. All’inizio, quando arrivavamo in una città a maggioranza araba, ci guardavano con sospetto: pensavano fossimo solo l’ennesima uniforme arrivata a imporre un dominio. Quando hanno conosciuto il confederalismo democratico, città come Raqqa o Deir Ezzor lo hanno abbracciato: hanno visto che si fonda sulla partecipazione politica di tutti e ciascuno».
«L’APPROCCIO AL SISTEMA è stato graduale – continua Dirik – e ha dovuto superare stereotipi e paure del passato. Si è operato mettendo prima in sicurezza i territori liberati dall’Isis e fornendo aiuti umanitari, mentre il movimento delle donne andava letteralmente casa per casa, con gradualità: di fronte aveva donne che avevano vissuto sotto l’Isis, traumatizzate, che avevano perso familiari. Il confederalismo democratico non vuole governare le persone, ma farle partecipare. La gran parte del lavoro è dunque l’educazione politica, con seminari, eventi pubblici, copertura mediatica, per spiegare cos’è questo progetto, senza aspettarsi che le persone lo digeriscano passivamente. In tutte le zone, le persone si sono avvicinate gradualmente, guardando ai risultati del sistema, anche semplicemente ai lavori pubblici. L’alternativa politica è stata pratica, insieme a quella educativa. Persone che non avevano mai ricoperto ruoli politici si sono ritrovate a presiedere assemblee e comitati, superando una storica marginalizzazione di classe».
«Esistono problemi, ostilità, fallimenti del sistema, ma si sta avanzando. È un processo lento, ma solido – conclude Dirik – Non mitizzatelo. Comprendete invece lo sforzo politico ed educativo. È uno sforzo storico. È il significato della rivoluzione: non la lotta all’Isis, che è stata quasi una coincidenza, ma sul lungo termine l’abolizione del patriarcato e del potere dalla mente dei popoli».
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento