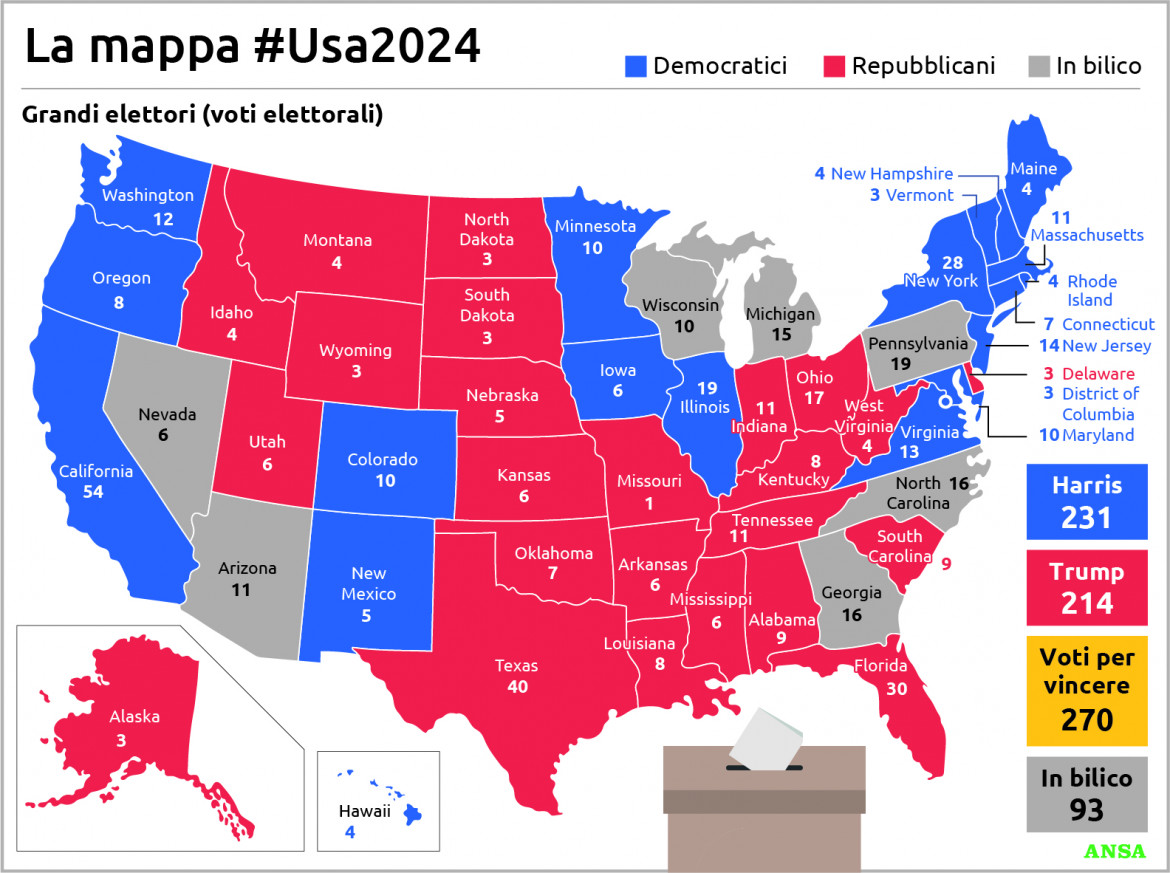Il volto domestico dell’esclusione
Intervista Parla il sociologo di Princeton, Matthew Desmond, autore dell’inchiesta shock «Sfrattati». «Settemila sfratti al giorno, il doppio delle vittime negli incidenti d’auto. La casa è ormai una vera emergenza nazionale negli Stati Uniti»
 Le immagini di uno sfratto nella città di Milwaukee
Le immagini di uno sfratto nella città di MilwaukeeIntervista Parla il sociologo di Princeton, Matthew Desmond, autore dell’inchiesta shock «Sfrattati». «Settemila sfratti al giorno, il doppio delle vittime negli incidenti d’auto. La casa è ormai una vera emergenza nazionale negli Stati Uniti»
Si chiamano Larraine, Arleen, Pam, Ned, Scott, Lamar, Crystal, Vanetta. Perdere la casa in cui vivevano, anche se magari si trattava di una mobile-home piantata nel bel mezzo del nulla, è stato spesso solo l’inizio di una lenta ma inesorabile discesa agli inferi. In altri casi, lo sfratto è arrivato al termine di vicende dolorose, dominate dalla dipendenza da alcol o droga, da violenze domestiche e dal disagio psicologico.
Ma non si deve credere si tratti di storie «estreme»: protagonisti di queste vicende sono sempre la povertà e le mille forme di esclusione che la accompagnano negli Stati Uniti di oggi. Quello della casa rappresenta infatti uno degli indicatori migliori dello «stato dell’unione» dal punto di vista sociale. Nel paese, nell’arco dell’ultimo decennio, oltre 2 milioni di persone hanno perso la propria abitazione in seguito alla crisi dei mutui subprime, circa 12 milioni spendono ogni anno più di metà delle loro entrate in affitti e rate dei mutui, in 20 milioni vivono in «quartieri» fatti di roulotte.
Dopo aver seguito per due anni le vicende di alcune famiglie di Milwaukee che sono state sfrattate per morosità, per problemi con la legge o magari semplicemente perché il padrone di casa non gradiva «il chiasso» dei bambini nell’appartamento, Matthew Desmond, ha tracciato in Sfrattati (La Nave di Teseo, pp. 200, euro 19, traduzione di Alberto Cristofori) un ritratto drammaticamente fedele di una parte della società americana. Professore di Sociologia a Princeton, già autore di importanti studi sul razzismo, per questa indagine, scritta con lo stile palpitante del reportage, Desmond ha vinto il Premio Pulitzer. Lo studioso è stato in questi giorni tra gli ospiti della Milanesiana.
Circa un milione di sfratti l’anno, un’ampia fetta della popolazione per la quale quello della casa è il problema principale. La sua indagine cosa ci dice della società americana?
Che nessuna politica sociale degna di questo nome può prescindere da questo tema. Ogni giorno negli Stati Uniti vengono sfrattate poco meno di 7mila persone: il doppio di coloro che muoiono in incidenti automobilistici. Allo stesso modo, quest’anno si sono registrati circa 63mila decessi per overdose da oppioidi: ebbene, ci sono stati 36 sfratti per ciascuna di queste vittime. Perciò, quello degli sfratti è un problema enorme, una vera emergenza nazionale.
Perché ha scelto proprio Milwaukee per la sua ricerca?
Amo Milwaukee, come tutta la Rust Belt, quella «cintura della ruggine» che ha incarnato tante promesse e che anche per questo oggi costituisce una parte in qualche modo speciale dell’America, dove il dolore, la frustrazione e la povertà sono più acuti e lancinanti. Come il lavoro, anche la casa ha sempre rappresentato una componente dell’immaginario del «sogno americano» che oggi sembra in frantumi. Perciò, se si vuole capire davvero cosa significhi la povertà, città come Milwaukee, Buffalo, Detroit o Gary, nell’Indiana, hanno molte cose da raccontare. Molto più di New York o Los Angeles.
Il moltiplicarsi degli sfratti, il fatto che scelte d’emergenza come vivere nelle «mobile-home» si trasformino in soluzioni definitive, spingono ad interrogarsi sull’esistenza o meno di politiche pubbliche sulla casa. Come stanno le cose?
Bisogna premettere come il problema sia ancora più ampio, nel senso che il picco degli sfratti si sta registrando negli ultimi anni, dopo che dal 2000 i prezzi medi di un contratto di locazione sono saliti del 10% mentre gli stipendi scendevano del 7%, rendendo sempre più difficile per le famiglie sostenere le spese per la casa. Detto questo, certo che esiste un problema di edizia pubblica. Solo un quarto delle famiglie che ne avrebbero diritto, ottiene effettivamente un alloggio e le liste d’attesa nelle città più grandi hanno tempi addirittura decennali. Il risultato è che anche molte famiglie a basso reddito sono costrette a rivolgersi al mercato immobilare con le conseguenze drammatiche che stiamo osservando. Inoltre, non tutti gli sfratti sono causati dal mancato pagamento dell’affitto. In molte città, i proprietari non devono fornire alcuna ragione per sfrattare un inquilino, basta che lo vogliano. Anche se la causa principale dell’aumento degli sfratti è naturalmente prima di tutto la crisi economica. Ci sono casi nei quali gli inquilini hanno smesso di pagare la pigione per poter saldare le rate del riscaldamento.
Nel libro non si respira solo empatia nei confronti delle persone che hanno perso la casa, ma è presente l’idea che la ricerca sociale debba assumersi le proprie responsabilità nei confronti di chi subisce le conseguenze delle disuguaglianze.
Apprezzo molto che si usi la parola «responsabilità» a proposito del mio approccio di lavoro. In genere, sia in ambito accademico che nel giornalismo ci viene ripetuto costantemente che, al contrario, si dovrebbe mettere «una certa distanza» tra sé e le persone al centro della ricerca. Personalmente, invece, non credo si possa capire davvero la condizione di persone come quelle descritte nel libro se non condividendo il più possibile la loro vita quotidiana, ciò che sentono e provano. Ho vissuto per mesi accanto a loro, come loro, e ho letto ai diretti interessati ogni brano che li riguardava prima di inserirlo nel testo. Tra noi si è stabilito così un legame basato sulla chiarezza e sulla fiducia. Il senso di responsabilità è necessario sia al momento dell’incontro che per immaginare un futuro possibile. Un futuro diverso.

Prima di «Sfrattati» lei si è occupato a lungo delle discriminazioni razziali, con testi come «The Racial Order». Quanto pesa questo elemento nella questione abitativa?
Il retaggio del razzismo è parte integrante della storia americana. Perciò è impossibile scindere la povertà, quella odierna ma anche come si è costruita nel corso delle generazioni, dalla sua componente razziale. Così, non deve stupire che gli afroamericani e gli ispanici siano in cima alle statistiche per quanto riguarda gli sfratti. Anche se accanto a loro ci sono molti bianchi poveri. È allo stratificarsi delle discriminazioni razziali, e alle loro conseguenze economiche e sociali, che si è dovuto il formarsi di una sorta di «specifica» classe sociale: i neri poveri che vivono in case in affitto che sono stati i più colpiti dall’aumento dei prezzi in questo settore. E, di conseguenza, i primi a finire per strada. Del resto, se l’esperienza del carcere definisce la vita degli uomini dei quartieri poveri neri, lo sfratto è diventato la sorte che attende spesso le donne di queste stesse zone. I neri poveri li si mette sotto chiave. Le nere, le si mette alla porta.
La sua ricerca è uscita nel 2016 alla vigilia delle elezioni che hanno sancito la vittoria di Trump e più di un osservatore vi ha letto la descrizione di quel senso di abbandono e di frustrazione della working class, elementi spesso indicati tra le cause dell’affermazione del tycoon.
In realtà, buona parte delle persone che ho incontrato per il libro credo si sentissero abbandonate a sé stesse da ogni sorta di istituzione già da molto tempo. Sullo sfondo c’è però ovviamente questo senso di angoscia più generale che ha a che fare con la crisi economica e con la perdita di una prospettiva riguardo al futuro. Qualcosa che per i più poveri non rappresenta una novità, ma che negli ultimi anni si è diffusa tra fette crescenti della popolazione. Ciò detto, rispetto al profilo «sociale» della vittoria di Trump c’è un grande malinteso. Nel senso che anche se è vero che ha avuto il sostegno determinante di zone operaie, o meglio ex operaie, sarebbe sbagliato credere che «gli ultimi» abbiano votato per lui. In base agli studi che sono stati realizzati dopo il voto, la media dei suoi elettori ha un reddito annuo superiore ai 72mila dollari. In questo senso credo che abbiano scelto Trump più per l’inquietudine sull’avvenire, che in base alle loro condizioni sociali attuali. Un elemento strettamente legato alla «razza»: la maggior parte degli americani bianchi, a prescindere dal livello di scolarizzazione come da quello professionale, ha scelto proprio lui. Mi sembra una statistica illuminante per capire come sono andate davvero le cose.
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento