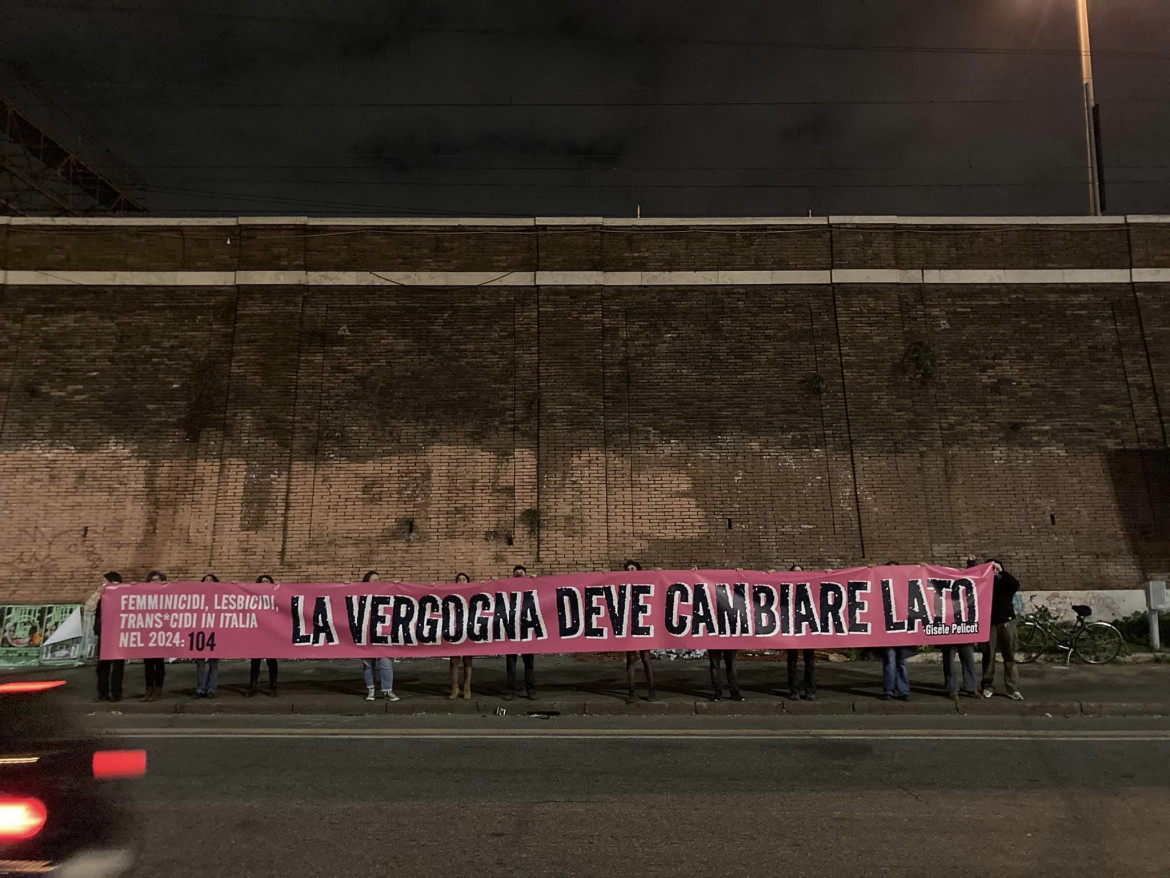Il reddito è di base
Politiche Dopo trent'anni di conflitti, le possibilità di un dibattito attuale più che mai

Politiche Dopo trent'anni di conflitti, le possibilità di un dibattito attuale più che mai
Quando nel 1997 è stato pubblicato il libro La democrazia del reddito universale (manifestolibri, oggi rieditato dalla stessa casa editrice con una nuova introduzione e una postfazione), in Italia l’argomento non era al centro del dibattito politico istituzionale e sindacale. Si trattava, tuttavia, di un argomento assai discusso in alcuni innovativi ambiti di movimento.
Tra questi un ruolo importante è stato svolto da quella parte del movimento femminista italiano che, più di 50 anni fa, è stata capace di mettere a critica la centralità del «salario» e del lavoro produttivo maschile. Siamo in presenza della prima seria ricognizione dei compiti «produttivi» e «riproduttivi» che svela come i secondi siano essenziali per la vita ma non siano affatto riconosciuti economicamente.
POSSIAMO AGGIUNGERE, per completare una rapida genealogia, che nei primi anni Settanta anche Potere Operaio fa circolare la proposta di un «salario politico», intendendo con ciò la necessità di ampliare il concetto di salario ad ambiti non strettamente produttivi. In tutti questi documenti si utilizza ancora il termine «salario» poiché, in quegli anni, è il sistema salariale di matrice fordista a organizzare la distribuzione di reddito.
Si sono poste allora le basi per iniziare una discussione sul significato del reddito di base, del valore e dunque della remunerazione della riproduzione sociale, intesa come un contesto allargato di scambi, azioni, attenzioni dell’essere umano, a cavallo tra sfera emotiva, sfera pulsionale, sfera sociale, sfera economica. Oggi si osservano pienamente le conseguenze dell’interazione tra il lavoro umano-linguistico e i vari dispositivi tecnologici, all’interno delle trasformazioni del paradigma produttivo del capitalismo contemporaneo: nel presente il capitalismo è diventato capace di accumulare profitti senza necessità di mediazioni salariali.
Perciò, dopo oltre mezzo secolo, si può affermare che la parola d’ordine del reddito è diventata centrale nel dibattito politico e che i cambiamenti del linguaggio rispecchiano epocali rivoluzioni del processo di sfruttamento e degli strumenti di lotta di chi si oppone.
La fotografia che andrebbe scattata ora è dunque quella di una società salariale in declino, nella quale il lavoro si ritrova precarizzato, segmentato, svalorizzato mentre le forme dell’accumulazione permangono invariate, con un sovrappiù di diseguaglianza. Non esistono più le forme di distribuzione che il contesto fordista ha comunque garantito per un periodo di tempo – sempre con l’eccezione paradigmatica del lavoro gratuito delle donne, necessaria per l’equilibrio di ogni tipo di sistema.
Le riflessioni sulle nuove forme distributive, a partire da strumenti diversi, come appunto il reddito di base, e sulla natura del Welfare State contemporaneo non possono che partire dalla consapevolezza di questa grande trasformazione e dell’aumento dell’iniquità sociale. Ciò non significa, infatti, che non si lavori più, anzi: il ritmo del lavoro e la durata della giornata lavorativa aumentano, il lavoro è remunerato sempre più poveramente mentre cresce la quota delle attività non pagate.
Ovviamente, a proposito di parole, quando nominiamo l’urgenza di concentrarci sul basic income non vogliamo illuminare solo «ciò che manca» ma le visioni del futuro, connesse alle libertà personali, che si sforzano di reinventare idee di giustizia sociale e di cittadinanza sociale.
Perciò, il testo del 1997 prima citato, è stato basilare per presentare a un pubblico più ampio un argomento allora declinato da un manipolo di anticipatori, connettendo corollari, concetti e tutte le immaginazioni che trascinava con sé.
Sono anni, quelli, in cui la precarietà si fa strada a larghi passi: è chiaro agli autori che parteciparono alla costruzione di quel volume, che ha aperto un campo di discussione diventato amplissimo, che la produzione di ricchezza è strettamente collegata alla accumulazione di sapere e alla cooperazione sociale. Cosicché, la «classe precaria» che fa da sfondo a quel momento è fragile ma cosciente del proprio ruolo nevralgico e per questo verrà sottoposta a crescenti dispositivi di controllo, di ricatto e di espulsione.
NEL PRESENTE, il reddito è di certo sulla bocca di tutti ma ci ritroviamo in un contesto che sconta una grande confusione concettuale e terminologica, oltre che in presenza di denigrazioni, di distorsioni, di polemiche ed equivoci. La definizione più comune «Reddito di cittadinanza» (usata nella proposta di legge del I governo Conte) è anche quella più ambigua. Inizialmente il termine «Reddito di cittadinanza» (RdC) viene usato come semplice traduzione della locuzione inglese basic income con l’intento di promuovere una misura di inclusione sociale verso il riconoscimento, appunto, di un diritto universale di cittadinanza. Oggi, tale concetto viene declinato in termini strettamente giuridici, facendo esplicito riferimento ai cittadini italiani, quindi in modo ristretto e selettivo. Per tale motivo sarebbe opportuno usare il termine reddito di base, liberandoci anche di tutte le altre dizioni che lo hanno accompagnato (dall’inclusione, all’esistenza, alla quarantena, passando per artisti, cura, ecc.). Mentre la precarizzazione del lavoro è del tutto esplosa, generalizzandosi e allargandosi dentro la vita, la parola d’ordine del reddito di base ha in sé tutto il potenziale per riuscire a ricomporre ciò che l’organizzazione attuale volutamente frammenta per creare dumping sociale e condizionare la capacità contrattuale del lavoro.
Non solo è necessario andare nella direzione opposta, ovvero quella di unificare e armonizzare i diversi strumenti di ammortizzazione sociale oggi esistenti (sussidio di disoccupazione, cassa integrazione, Aspi, Naspi, Discoll, ecc.) ma soprattutto quello di superare la logica assistenziale e sempre condizionata all’inserimento lavorativo dei «cattivi soggetti» (fannulloni, choosy, divanisti, truffatori).
Tale disegno ha prevalso per fomentare competizione sociale e individualismo tra gli stessi lavoratori e smontare ogni afflato di eguaglianza universalista. Nel suo ultimo testo, L’odio dei poveri (Ponte alle Grazie 2023, pp. 320, euro 18), Roberto Ciccarelli nomina il Workfare come «strumento bicefalo» antinomico al Welfare: il Workfare nega il Welfare iscrivendosi sul fronte del capitalismo neoliberale, è un dispositivo politico sociale che garantisce offerta di manodopera nelle fasce più basse del mercato del lavoro.
Insomma, in opposizione all’apparato coercitivo del Workfare, è necessario pensare al reddito di base incondizionato come strumento welfaristico di liberazione, in grado di potenziare il diritto di scelta e l’autodeterminazione degli esseri umani. Questo abbiamo imparato da quel testo del 1997.
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento