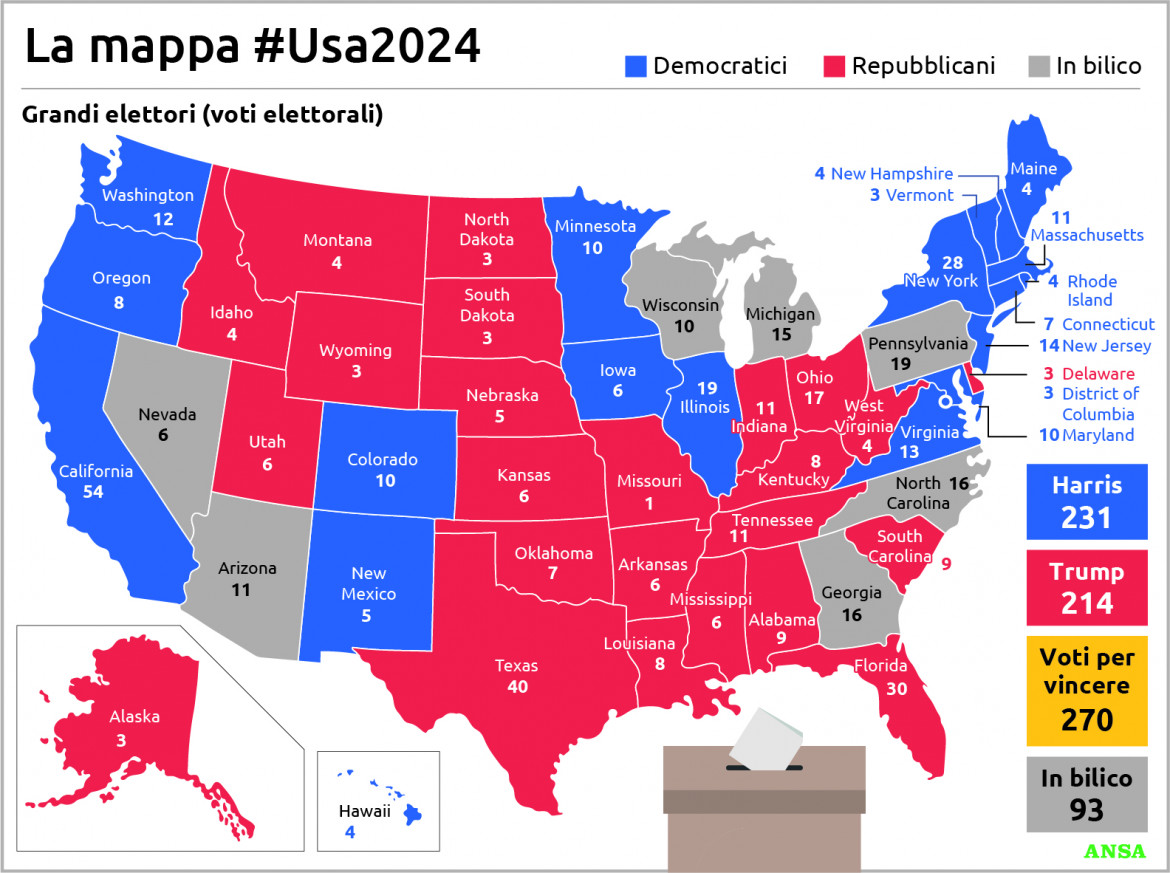George Floyd, la vita e la morte d’America
Geografie L’inchiesta di Robert Samuels e Toluse Olorunnipa per La nave di Teseo. La storia del 46enne nero ucciso nel 2020 a Minneapolis da un agente bianco che ha cambiato gli Stati Uniti. Una biografia che rappresenta allo stesso tempo un viaggio all’interno del razzismo che definisce le traiettorie esistenziali di milioni di persone solo in base al colore della pelle. Il risultato è una sorta di ripresa «in soggettiva» che parte dalla vicenda dell’ucciso e della sua famiglia per illuminare via via l’intera traiettoria dei neri nella società
 Un murales dedicato all'uccisione di George Floyd – Foto Ap
Un murales dedicato all'uccisione di George Floyd – Foto ApGeografie L’inchiesta di Robert Samuels e Toluse Olorunnipa per La nave di Teseo. La storia del 46enne nero ucciso nel 2020 a Minneapolis da un agente bianco che ha cambiato gli Stati Uniti. Una biografia che rappresenta allo stesso tempo un viaggio all’interno del razzismo che definisce le traiettorie esistenziali di milioni di persone solo in base al colore della pelle. Il risultato è una sorta di ripresa «in soggettiva» che parte dalla vicenda dell’ucciso e della sua famiglia per illuminare via via l’intera traiettoria dei neri nella società
L’«attimo fatale» per George Floyd è durato ben otto minuti. Quelli necessari perché «la presa» dell’agente che lo bloccava a terra, con un ginocchio sul collo, lo uccidesse. Nel frattempo, lui ripeteva, almeno venti volte secondo alcune testimonianze, «I can’t breathe», non respiro. Parole destinate a trasformarsi in un grido di rabbia, in una richiesta di giustizia, nell’urlo lancinante di una parte della società americana che continua a sentirsi negata e dei molti che, pur non subendo nulla di simile, sono decisi a tentare di cambiare definitivamente il proprio Paese.
PERCHÉ LA MORTE del 46enne afroamericano per mano di un agente di polizia bianco il 25 maggio del 2020 a Minneapolis non ha solo segnato la storia recente degli Stati Uniti, ma ha forse contribuito a mettere in moto un processo di cambiamento i cui esiti si vedranno in futuro. Come segnala fin dal nome che si è dato il nuovo movimento antirazzista che ha riempito le strade d’America nell’ultimo decennio proprio per dire «basta» allo stillicidio di morti violente di uomini neri per mano di chi dovrebbe invece garantire le legge e la giustizia, Black Lives Matter, letteralmente «le vite nere contano», proprio la storia di George Floyd indica come questa fine atroce ci spinga ad interrogarci su quanto è avvenuto prima: su cosa questa morte ci dice della vita cui ha posto termine e, in altre parole, non di come vengono uccisi gli afroamericani, quanto piuttosto di come possano essere le loro esistenze negli odierni Stati Uniti.
È da questa dolorosa consapevolezza, che contiene però anche una sfida implicita a quanti sembrano accorgersi di quanto non va nel Paese solo quando gli Stati Uniti si trasformano nel teatro di un nuovo dramma, in genere largamente prevedibile, che muove il libro di due dei più noti reporter del Washington Post, Robert Samuels e Toluse Olorunnipa, Il suo nome è George Floyd. La vita di un uomo in lotta per la giustizia, appena uscito per La nave di Teseo (traduzione di Alberto Cristofori, pp. 528, euro 22). Non si tratta soltanto di una brillante inchiesta, di quelle cui il giornalismo statunitense ci ha abituato fin dai tempi della guerra del Vietnam e dello scandalo Watergate, ma di un testo che vibra esplicitamente di consapevolezza e denuncia.
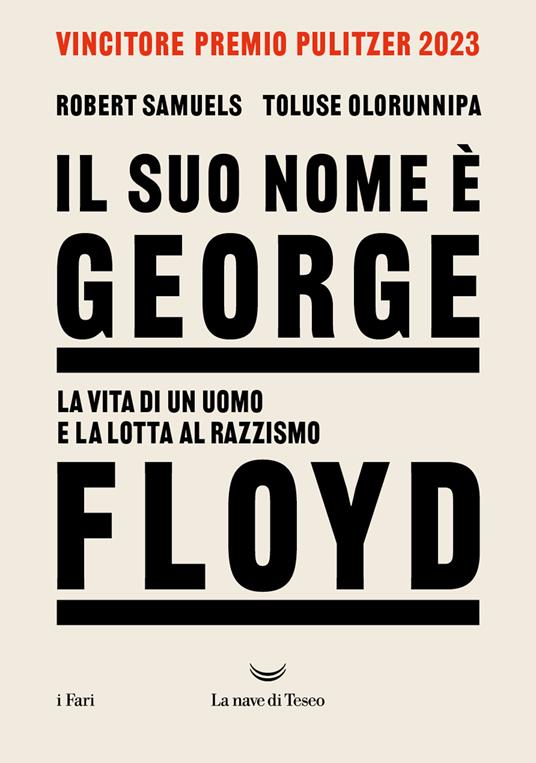
INCONTRIAMO COSÌ prima il trisnonno di Floyd, nato schiavo nel 1857 e che aveva passato buona parte della sua gioventù a lavorare, per conto dei bianchi, nei campi del Nord Carolina. Gli acri di terra di cui era riuscito ad entrare in possesso gli sarebbero stati sottratti alla fine del secolo, quando, al termine della cosiddetta Ricostruzione che fece seguito alla Guerra civile, le truppe federali abbandonarono gli Stati meridionali, facendo venir meno la protezione che avevano garantito agli afroamericani. Seguiamo quindi le tracce della famiglia di Floyd in un quartiere segregato della città texana di Houston dove l’uomo, che era nato nel 1973 a Fayetteville in Nord Carolina, all’inizio degli anni ’90 stava emergendo come una promessa del football locale, sebbene la scuola che frequentava godesse raramente del sostegno economico delle istituzioni locali.
Al razzismo esplicito si era infatti andato sostituendo l’abbandono degli interventi pubblici in scuole e quartieri a maggioranza nera, dopo che i white flight avevano visto l’abbandono di intere aree metropolitane da parte del ceto medio bianco. Nelle zone urbane «abbandonate» alle minoranze cresceva intanto la marginalità, la droga e il crimine. E le forze dell’ordine facevano la loro comparsa spesso solo per arrestare dei ragazzini. Lo stesso George Floyd sarebbe stato arrestato oltre venti volte, finendo per trascorrere oltre un terzo della sua vita adulta dietro le sbarre. L’itinerario di rifiuto e violenza che avrebbe condotto l’uomo verso la sua tragica fine era iniziato molti anni prima e, come lui, aveva coinvolto molti altri giovani uomini neri. Non a caso, al termine della loro inchiesta, Samuels e Olorunnipa sottolineano come non si trattasse di sottrarre Floyd alla responsabilità delle proprie azioni precedenti – i problemi di droga, i rapporti con il piccolo crimine -, quanto piuttosto di «collocare le sue esperienze nel contesto delle innumerevoli forze che sono intervenute sullo sfondo durante i suoi quarantasei anni di vita».
IL SISTEMA RAZZIALE che continua a definire la società americana, e che ne ha plasmato lo sviluppo storico, ha segnato così profondamente la vita di George Floyd da fare della sua tragica fine quasi un destino annunciato, un epilogo possibile in base alle sofferenze già patite in precedenza. Eppure, proprio per questo raccontarne la vita, fa di Floyd un simbolo non tanto di ciò che è andato perduto, ma di quello che ancora, incredibilmente, resta da conquistare. Del resto, concludono i reporter del Post, il quadro che emerge al termine della loro inchiesta, «è quello di un uomo che affronta una lotta straordinaria con speranza e ottimismo, un uomo che è riuscito a fare nella morte quello che voleva così disperatamente ottenere in vita: cambiare il mondo».
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento