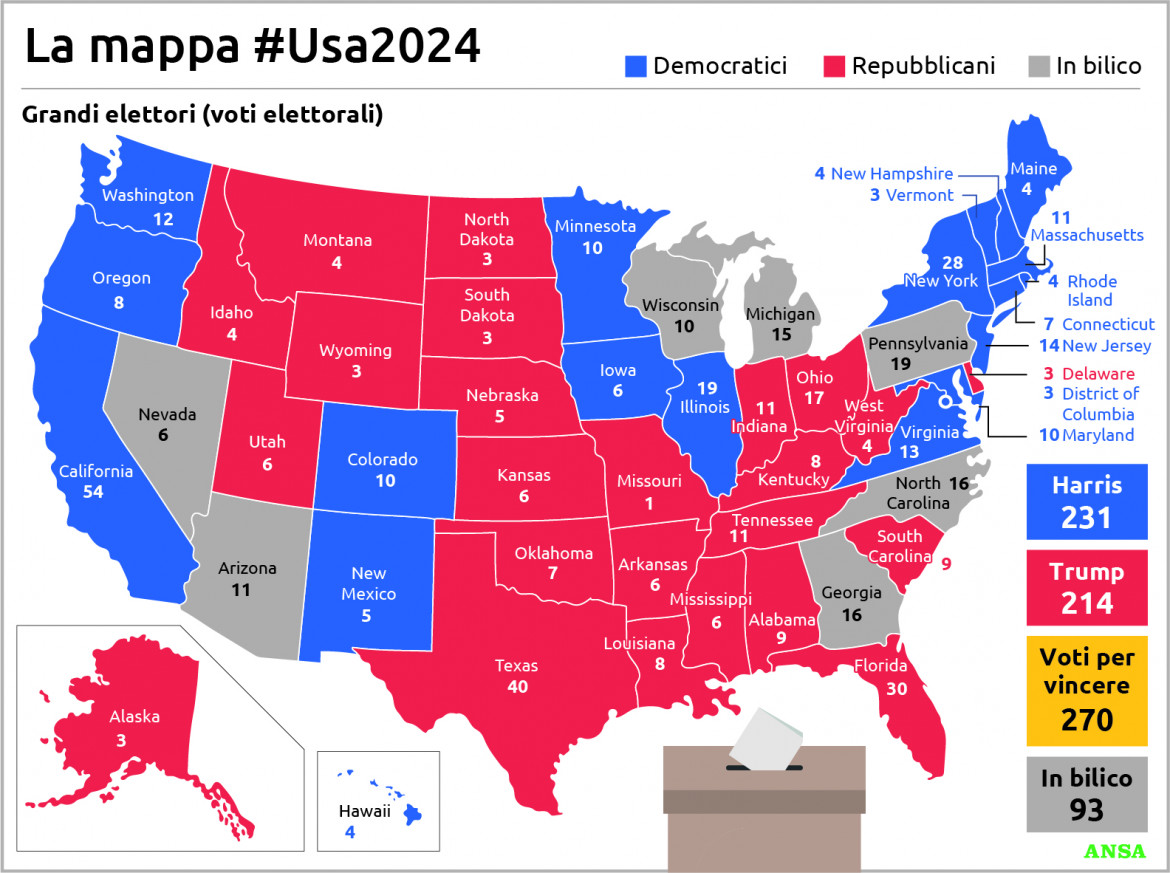Gary Shteyngart, nell’Eden posticcio, trionfo di vanità per uomini soli
La dialettica di successo e fallimento sembra stare particolarmente a cuore a Gary Shteyngart, almeno stando al titolo del suo libro di memorie del 2014, Little Failure – ovvero, «piccolo fallito», soprannome datogli dalla sua poco amorevole madre; ma una sorta di lotta spesso picaresca per la propria affermazione caratterizza anche la sua produzione romanzesca, sempre diretta da un autobiografismo più o meno evidente.
Shteyngart si è affermato come una delle più importanti e riconoscibili voci della letteratura ebraico-statunitense contemporanea. O meglio, russo-ebraico-statunitense, visto che l’identità sovietica dello scrittore è fermamente al centro della sua riflessione letteraria, e affrontata in una serie di opere marcate da un umorismo surreale nelle quali lo scontro tra la cultura russa e l’attualità della società statunitense fa da canovaccio per trame tragicomiche e avventurose.
Attraverso i suoi protagonisti male in arnese, di frequente alle prese con situazioni ben più grandi di loro nelle quali si barcamenano a malapena, Shteyngart interroga con insistenza il processo di costruzione identitaria transnazionale. La Russia dell’infanzia, conservata nei modi antiquati dei padri e nella lingua familiare che rifiuta ostinatamente di cedere alle pressioni dell’inglese americano, è tanto una realtà quanto un’idea. Un’immagine reale e allo stesso tempo rarefatta da pulsioni ambivalenti, in perenne conflitto tra le certezze polverose del vecchio mondo, punto di riferimento esistenziale ma anche tormentato luogo psichico fatto di traumi e incomprensione, e l’incertezza dell’affermazione nell’America del presente.
L’ultimo romanzo dell’autore, La casa sulla collina (traduzione di Katia Bagnoli, Guanda, pp. 395, € 19,80) affronta il rapporto complesso con l’identità russa da un punto di vista diegetico ma anche più sottilmente metanarrativo e intertestuale. Infatti, l’ispirazione principale del romanzo, più volte apertamente citata nel testo, viene dall’opera di Anton Chechov, e in particolare dal dramma Zio Vanja, che è messo in scena dai protagonisti nella lunga sequenza onirica in chiusura della storia. Tema fondamentale del teatro checoviano è il passaggio implacabile del tempo, colto con dolorosa acutezza soprattutto nei cambiamenti sociali che caratterizzarono la Russia al passaggio del secolo scorso, portati in scena da una classe media volgare e materialista e da un’aristocrazia decadente.
Shteyngart replica i temi e la struttura in quattro atti tipica del venerando predecessore, adattandovi un romanzo dalla forte vocazione scenica che rispetta fedelmente il canone drammaturgico di derivazione aristotelica per il quale il racconto «compiuto e perfetto» è quello connotato da una solida unità di tempo, luogo e azione.
Ebreo-russo-americano
Siamo nella tenuta di campagna dello scrittore ebreo-russo-americano Alexander «Sasha» Senderovsky, uomo di mezz’età ma già in declino artistico e umano che, durante la pandemia in corso, decide di riunire un pugno di fedelissimi amici sulla sua proprietà per affrontare il virus insieme e in isolamento dal resto del mondo. Una scelta dettata dalla nostalgia per l’infanzia passata nell’atmosfera stagnante ma in definitiva rassicurante delle colonie destinate ai bambini russo-americani come lui; ma anche dai ricordi di una brillante giovinezza di eccessi spensierati, spesso inconsciamente mistificati dal contrasto mortificante con il presente. Il linguaggio di Shteyngart è diretto, la voce autoriale ironicamente distaccata dagli eventi.
Intento denigratorio
Senderovsky e i suoi amici vengono descritti con una serie di rapide pennellate, nello stile delle dramatis personae, rivelando un intento autoriale apertamente denigratorio, palese nel cinismo nero dello scrittore e ulteriormente rafforzato da una tendenza evidente all’autocommiserazione per procura.
Il risultato è una galleria di personaggi generalmente sgradevoli quando non del tutto abietti, intenti a mantenere una serie di rapporti umani che diventano in breve tempo insopportabili nella loro ipocrisia conclamata.
Tutto si svolge sottovoce: il dramma di questi individui interrotti, incompleti e portati a rivivere ciecamente il passato nel tentativo di dimenticare il presente viene articolato quasi esclusivamente nell’aridità del denaro e nella vacuità della fama, rimanendo sempre sulla superficie delle cose. Asserragliati in un posticcio giardino dell’Eden, i protagonisti del romanzo rappresentano le piccole ansie dell’America liberal e ostentatamente multiculturale, le cui pretese vengono minacciate dalle psicosi legate al Covid-19 e dalla xenofobia imperante dell’era Trump, in agguato appena al di fuori dei confini della tenuta.
La casa sulla collina è un amaro trionfo della futilità borghese: un piccolo dramma talvolta grottesco, in cui le vite da poco di un pugno di presunti eletti vengono sistematicamente decostruite dall’occhio impietoso di Shteyngart nella piattezza ottusa di giornate indistinguibili. Fino alla tragedia finale, subito accantonata nel desiderio di riconquistare una normalità di mediocri tristezze e piccole ma persistenti malinconie.
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento