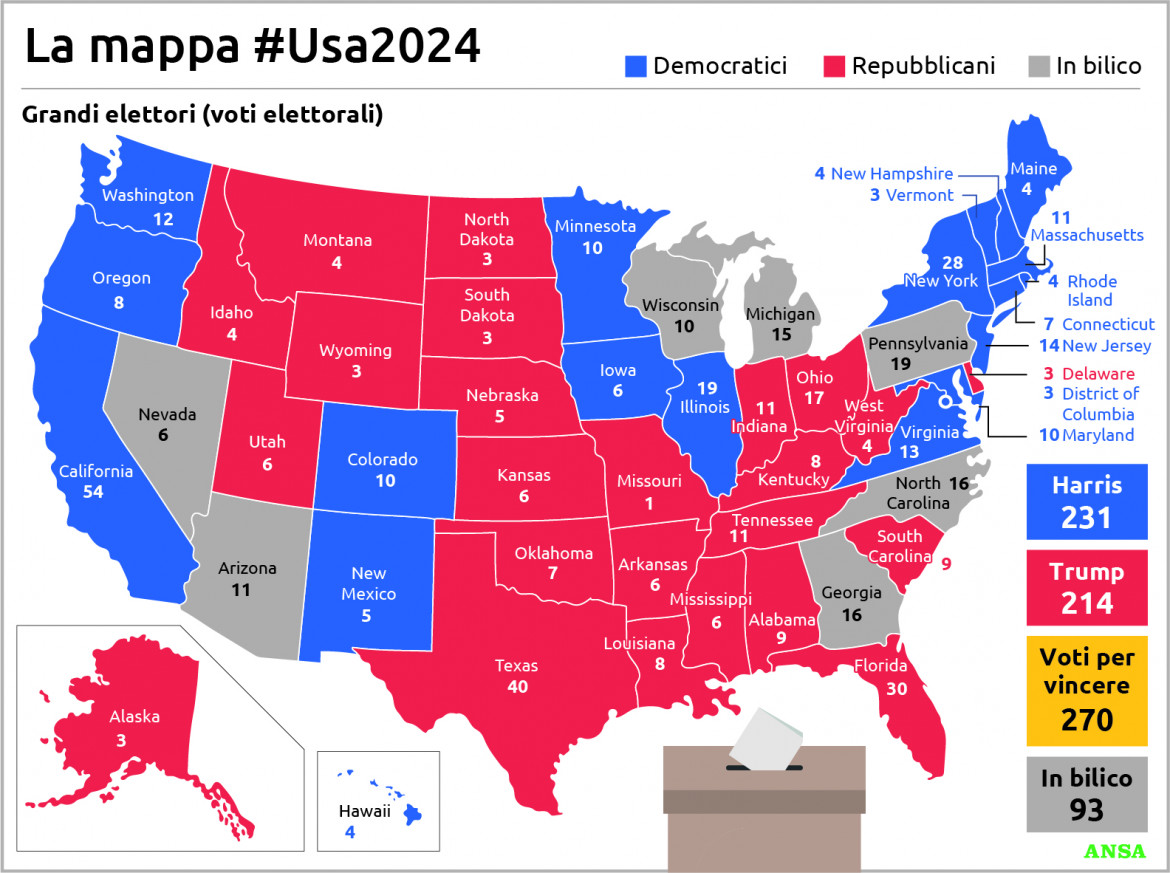Faulkner, la razza, anzi il Sud, trascesi in un uomo
Scrittori statunitensi A Jefferson c'è un nero che non si comporta da negro, e questo è tutto: «Non si fruga nella polvere», una storia debole su una idea forte, ossia che la giustizia parla da sola: ritradotto da Adelphi
 Ben Shahn, «Sunday in Scotts Run, West Virginia, 1935»
Ben Shahn, «Sunday in Scotts Run, West Virginia, 1935»Scrittori statunitensi A Jefferson c'è un nero che non si comporta da negro, e questo è tutto: «Non si fruga nella polvere», una storia debole su una idea forte, ossia che la giustizia parla da sola: ritradotto da Adelphi
Ennesimo colpo di sonda nell’anima del Sud degli Stati Uniti, Non si fruga nella polvere (ottimamente ritradotto da Roberto Serrai, Adelphi, pp.235 € 19,00) uscì nel1948, dopo sei anni di relativo silenzio e un anno prima del Nobel: è l’unico romanzo di indagine criminale che Faulkner abbia mai scritto, e tutto sembra appeso a una questione di settanta centesimi buttati per terra. Ricapitoliamo la storia, ma sia ben chiaro che quanto segue non si trova all’inizio del romanzo.
Un ragazzo di nome Charles Allison, detto Chick, rischia di annegare in un fiume gelato mentre va a caccia di conigli. Si salva grazie a un uomo che compare sulla riva del torrente e del quale Chick vede, all’inizio, solo gli stivali. Lentamente, lo sguardo gli risale fino a mostrare il volto di un nero, ben noto in città, di nome Lucas Beauchamp. Quello sguardo non si ferma al colore della pelle, anzi, è come se lo trascendesse. Sarà per via del pericolo in cui si è trovato o dei vestiti ghiacciati, fatto sta che Chick non vede un nero, vede un uomo la cui pigmentazione semplicemente non conta. È l’impressione di un momento, ma è un fatto che Lucas Beauchamp non è un nero «come gli altri». Ha il suo appezzamento di terreno, una casa e una famiglia. Si veste bene, ostenta una pistola infilata in una fondina che porta ai fianchi, ben visibile e che ha acquisito legalmente, nonché uno stuzzicadenti d’oro dal quale non si separa mai. Ha un portamento austero, i bianchi non lo potrebbero mai chiamare «boy» come fanno con gli altri neri. Di fatto, Lucas è il cruccio degli abitanti di Jefferson, Mississippi, parte dell’immaginaria contea faulkneriana di Yoknapatawpha: lo è perché non si comporta come un «negro».
Chik Allison tutto ciò non lo sa bene, ma capisce di essere in debito con Lucas e questo, per un bianco, non è previsto. Lucas lo invita a casa sua, gli fa asciugare i vestiti e gli dà da mangiare: se lui non si comporta da nero, Chick vorrebbe almeno comportarsi da bianco, ma davanti a Lucas non sa come si fa. Goffamente, cerca di pagargli il pranzo con settanta centesimi che ha in tasca. Lucas non li vuole e Chick, frustrato oltre ogni dire, li scaglia per terra. L’altro non si scompone, li fa raccogliere dai suoi figli e li rimette in mano a Chick.
L’incidente sembra chiuso, non ci sono testimoni e Chick spera che Lucas si dimentichi di lui e di quel conto rimasto in sospeso. Ha ragione di pensare che ci sia un conto in sospeso, perché anni dopo sarà proprio Lucas, accusato di avere ucciso un bianco di nome Vinson Gowrie, a rivolgersi a Chick per chiedergli di andare a chiamare suo zio, l’avvocato Gavin Stevens.
Faulkner non racconta storie, non dispone una scacchiera narrativa sulla quale i personaggi si muovono in maniera comprensibile. Ci fa entrare nelle pieghe della vicenda fino al punto di diventare noi stessi una piega, capaci solo intravedere o di venire a sapere dell’esistenza di altre pieghe, senza poterle spianare. Il lettore è lì, insieme agli altri personaggi, ma non vede le stesse cose che vedono loro, non sente tutto quello che dicono loro, è sempre un passo avanti o un passo indietro, non «legge» ciò che accade, piuttosto ne è testimone, ma al prezzo di non poter afferrare le ramificazioni degli eventi. Viene immerso in un flusso di parole-tempo, in un fiume alla cui fonte non si può risalire, testimone di una realtà non testimoniabile. Se riesce a lasciarsi andare al ritmo delle lunghissime frasi che si accumulano come onde lutulente prima o poi giungerà alla conclusione della storia, ma non potrà veramente dire: adesso ho capito, è andata proprio così.
Perché sì, è andata così, ma questo non significa niente. Le ragioni per cui Lucas ha fatto o non ha fatto quel che tutti pensano che abbia fatto, le ragioni per cui è colpevole o innocente della morte di Vinson Gowrie non possono veramente essere comprese dai bianchi di Jefferson. Entrano solo a far parte di un destino. È intollerabile che in Lucas ci sia qualcosa che trascende la sua razza, ma l’avvocato Stevens – portavoce di Faulkner o più probabilmente un portavoce distorto dalla necessità di essere un personaggio – sostiene non si tratti di odio razziale. Gli stessi che ritengono un dovere il linciaggio di Lucas sarebbero poi i primi a mandare un sussidio alla sua famiglia. La forza che li spinge è più impersonale e per questo ancora più pericolosa. Perché l’odio in fondo è un sentimento umano, ma linciare Lucas (Faulkner non lo dice, ma è essenziale capirlo) è un atto esclusivamente politico, compiuto da chi la politica non sa nemmeno cosa sia. A Jefferson c’è un nero che non si comporta da negro, e questo è tutto. Nessuno ha visto Lucas uccidere Vinson Gowrie; nessuno si chiede che motivazione potesse avere. Non ce n’è bisogno. Uccidersi è un fatto della vita, ma è anche un privilegio, come i primi posti sugli autobus o ai tavoli dei ristoranti affacciati su Main Street, e come tale non può essere esteso ai neri.
S’intende che Stevens non parla così, anche se Faulkner gli regala veri e propri sermoni che delineano una impossibile filosofia del Sud: sappiamo tutti che il sistema è sbagliato; lo sanno anche quelli che sono là fuori con i bidoni di benzina aspettando di bruciare la prigione, ma nessuno deve venircelo a dire. Dobbiamo capirlo da soli, e metterci il tempo che ci vorrà. La «strategia meridionale», che sarà poi di Goldwater e di Nixon, prende già forma qui. Voi del Nord siete un paese straniero: non ve lo dimenticate, perché noi non lo dimentichiamo.
Stevens accetta di difendere Lucas, ma non gli importa sapere se Lucas è innocente. Monta la difesa senza nemmeno starlo a sentire, ed è per questo che Lucas ha bisogno di Chick, per via di quei settanta centesimi che ancora li legano. D’altra parte, Lucas non si dichiara mai innocente. Vuole che i fatti parlino per lui, che ci sia un’indagine vera. E l’indagine, che è la vera «storia» del libro, è anche la sua parte più debole, con una strana virata verso il «romanzo per ragazzi» in cui un coraggioso sedicenne con l’aiuto di un’intrepida vecchietta si intestardisce a scoprire «la verità», andando incontro ai prevedibili guai. Ma ciò che salva il libro, se non la storia, è che Lucas, con la sua fede nei fatti, è l’unico personaggio veramente moderno. Più che la sua razza, Lucas trascende l’intero Sud. Crede nella razionalità dell’analisi forense più di tutti gli avvocati e sceriffi del Mississippi messi assieme.
Faulkner era certamente a conoscenza dei progressi dell’indagine criminale, che avevano fatto un balzo in avanti da quando, nel 1936, una volta istituito l’Fbi, le impronte digitali erano diventate un patrimonio federale e non erano più, come in precedenza, custodite dalle polizie delle singole contee che tra di loro non se le scambiavano. E lo sapeva perché suo fratello Murry «Jack» Falkner (la vera grafia del nome di famiglia) era stato uno dei primi agenti dell’ Fbi, parte della squadra che agli ordini di Hoover aveva dato la caccia a John Dillinger, il «nemico pubblico numero uno». Lucas Beauchamp, che sarebbe poi stato splendidamente interpretato dal nero portoricano Juano Hernández nel film tratto dal romanzo, diretto da Clarence Brown nel 1949, è un nero che vuole giustizia, ma non la vuole in quanto nero. La vuole perché è convinto che la giustizia possa parlare da sola, posto che la si lasci parlare. Non si appella a Dio o alla pietà. Non voleva essere pagato da Chick, ma personalmente è uno che paga il conto e lo fa fino alla fine, fino all’ultima splendida battuta, in chiusura del libro.
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento