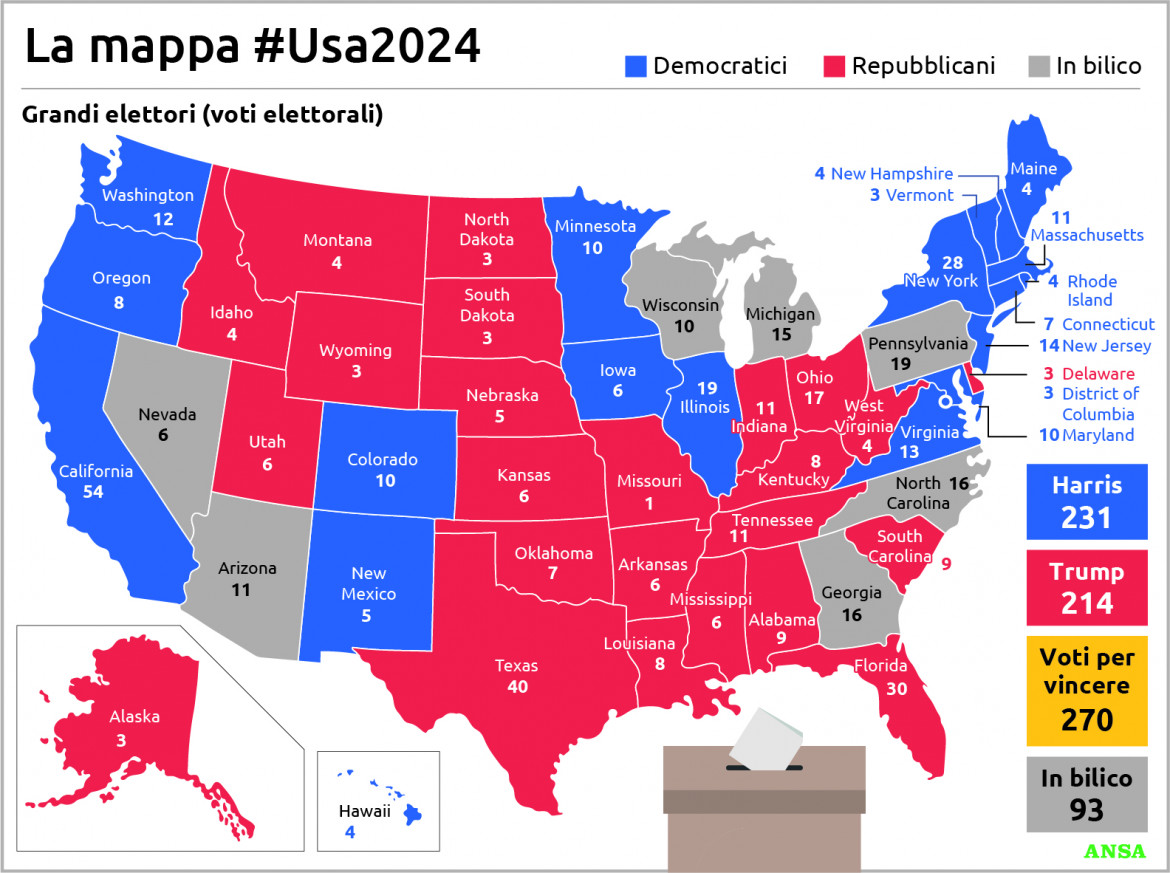Charles Wright, sulle rive della lingua
Poeti statunitensi In uno stile largo, pittorico, senza concessioni all'ermetismo né all’avanguardia, Wright attinge sia alla tradizione pastorale sia a quella del country: «Littlefoot», da Crocetti
Se si dovesse stabilire quale sia l’ultimo poeta modernista americano, un ultimo erede di quella scuola di tessitori di arazzi che inizia con T.S. Eliot, Hart Crane, Ezra Pound, William Carlos Williams, ed è continuata poi in mille figure epigonali, Charles Wright potrebbe forse aspirare al titolo. Come Pound, ma anche come Allen Mandelbaum, nella sua opera ha riservato uno spazio di assoluto rilievo alla poesia, all’arte e al paesaggio italiani. Non soltanto ha tradotto i versi di Montale e di Campana, ma di fatto ha cercato di sovrapporre, come se fossero fogli trasparenti, le colline del Veneto a quelle del Tennessee, dove è nato, o della Virginia, dove ancora vive. Più ancora, ha tentato di tradurre l’Italia: se nomina l’Adige è per farlo seguire dal fiume Holston, che attraversa la sua parte d’America; se evoca la Piazza delle Erbe di Verona è perché poco dopo farà apparire un riferimento a Knoxville, nel Tennessee, dove ha passato l’infanzia.
In America, il poeta turista è un’istituzione. Non si contano gli autori ai quali basta un breve soggiorno di ricerca e la visita a qualche museo per produrre, al ritorno, un libro di poesie di viaggio sulle bellezze artistiche d’oltre Atlantico. Spesso sono versi in cui non c’è nessuno, non si avverte né l’impronta di una presenza urgente né una motivazione esistenziale; l’occhio ispeziona un quadro mentre la mente cerca di terminare la pagina con un’acuta battuta finale. Wright non fa parte di quella schiera. Quando menziona il Beato Angelico o Giorgio Morandi, o anche quando riscrive a suo modo passi di Dante («nel fine del cammin» – di nostra vita, s’intende) o di Ungaretti («Mi svuoto nella luce / finché diventa mattino»), che non sono nemmeno citazioni ma frammenti di memoria collettiva, non appare mai frettoloso, né scrive per giustificare l’erogazione di un grant universitario.
Tra il 1957 e il 1961, per conto dell’esercito degli Stati Uniti, Wright fece parte dell’unità di controspionaggio di stanza a Verona. La sua guida all’Italia erano i versi di Ezra Pound, dai quali risalì ai paesaggi italiani che li avevano ispirati. Tornato in Italia dal 1963 al 1965 con una borsa di studio Fulbright, questa volta senza doveri verso l’Intelligence, si dedicò a tradurre La bufera e altro. Sebbene la passione per la poesia italiana (e per quella classica cinese, anch’essa mediata da Pound) non lo abbia mai abbandonato, non ha mai cercato di imitarla, quanto piuttosto di incastonarla nella sua personale architettura poetica. Fin dagli esordi, Wright ha elaborato un suo stile cadenzato e largo, pittorico e senza concessioni né all’ermetismo né all’avanguardia. Ciò non toglie che nelle poesie degli anni sessanta e settanta, quando racconta degli incontri con Ugo Mulas al Bar Giamaica (la fotografia è un altro dei suoi interessi), nella dovizia diaristica di nomi e situazioni dei libri che produce in quei tempi sembra di trovare in filigrana il Sanguineti di Postkarten, del quale sono però assenti l’amara ironia e il disincanto assoluto, nonché la cattiveria. Charles Wright è un poeta della bellezza della creazione, della metamorfosi che sfugge alla morte e della morte che pone fine alle metamorfosi umane, della fede (l’unica che ha) nella natura, negli animali, nell’aria, nella pioggia e nella certezza che gli elementi tutti continueranno a ricombinarsi in forme e paesaggi infiniti, anche senza l’occhio umano a contemplarli.
L’occhio della poesia, però, li vede ancora. È questa la speranza di Wright, e al tempo stesso la sua scommessa. Wright è un poeta bucolico-sapienziale. Da quando i suoi versi si sono staccati dal paesaggio cittadino, si è fatto erede a pieno titolo della tendenza pastorale di molta poesia americana. Eccede nell’idillio campestre, collinoso e fluviale, sempre sorretto all’occorrenza da qualche citazione spaziante nei secoli, da Tao-chi a Camus, ma è anche mai sazio di precisione descrittiva come di un artigianato di aforismi che non intendono sorprendere il lettore bensì condurlo per mano lungo le strade della Virginia o del Montana, dove è solito passare le estati. La natura, in Wright, non è mai qualcosa che sta davanti all’essere umano come un’impossibilità della ragione, come un esaltante o terrificante «sublime americano». È fatta di uccelli qualunque, di fiori di peonia e di scoiattoli quasi addomesticati. È fatta di Monte, il cavallo di sua moglie, e di Littlefoot, il puledro un po’ zoppo, che – pur essendo nominato una volta sola, e verso la fine del libro – dà il titolo al poema appena uscito da Crocetti nella bellissima traduzione di Antonella Francini (pp. 228, € 18,00), corredata da un’introduzione che è un vero e proprio studio critico, e di notevole spessore.
La saggezza di cui Wright è generoso, a volte anche troppo, si traduce in versi incastonati nel paesaggio, che se venissero isolati si presterebbero a un breviario: «Certe canzoni vanno cantate sull’altra riva della lingua». «Non si è poi così poveri, pensiamo, a vivere nel mondo metafisico». «Un eremita dovrebbe evitare l’assoluto». «Amore dell’assenza d’amore è sempre amore». «Un bravo scrittore è come un vento sull’erba del prato». Pur nella semplicità del dettato, che richiede una lettura quieta e lettori altrettanto quieti, la volontà di canto è dichiarata, e non a caso nel 1982 Wright intitolò Country Music (la musica nata sulle pendici dei monti Appalachi e lungo le Blue Ridge Mountains), la riproposta delle sue poesie giovanili. Il country ritorna in Littlefoot attraverso la citazione di brani celebri come Precious Memories e altri, tratti soprattutto dal repertorio della Carter Family e posti a conclusione di questa o quella sezione. Del resto, la poetica dell’intero libro, e forse di tutto Wright, si riconosce nelle parole di A.P. Carter, «Caro mio, è tutta musica, non lo sai?». S’intende la musica delle nuvole, del paesaggio, del mondo animale e soprattutto del tempo che passa: suona dunque giusto che l’ultima sezione del libro, la n. 35, si risolva nella pura trascrizione di Will You Miss Me When I’m Gone? (Ti mancherò quando non ci sarò più?), una canzone ricavata da varie fonti anonime e incisa dalla Carter Family nel 1928, circolata in mille forme e il cui titolo riaffiora dovunque, nel country come nel blues. A parte Bob Dylan, Charles Wright è forse l’unico poeta laureato americano ad aver reso omaggio alla poesia del country.
Nato nel 1935 a Pickwick Dam, nel Tennessee, Charles Wright ha cominciato a pensare seriamente alla sua mortalità intorno al 2005, quando stava per compiere settant’anni. Littlefoot, che è uscito nel 2007, è il risultato di queste sue meditazioni. Avrebbe potuto tardare ancora un po’ nel prefigurare l’inevitabile transitorietà, sua e di tutte le cose. Dopo Littlefoot, infatti, Wright ha pubblicato altri due libri (Sestets nel 2009 e Caribou nel 2014), finché nel 2019 ha curato Oblivion Banjo, un’ampia selezione di tutta la sua opera poetica, e solo a quel punto ha deciso di non pubblicare più nulla. Il che non vuol dire che abbia smesso di scrivere.
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento