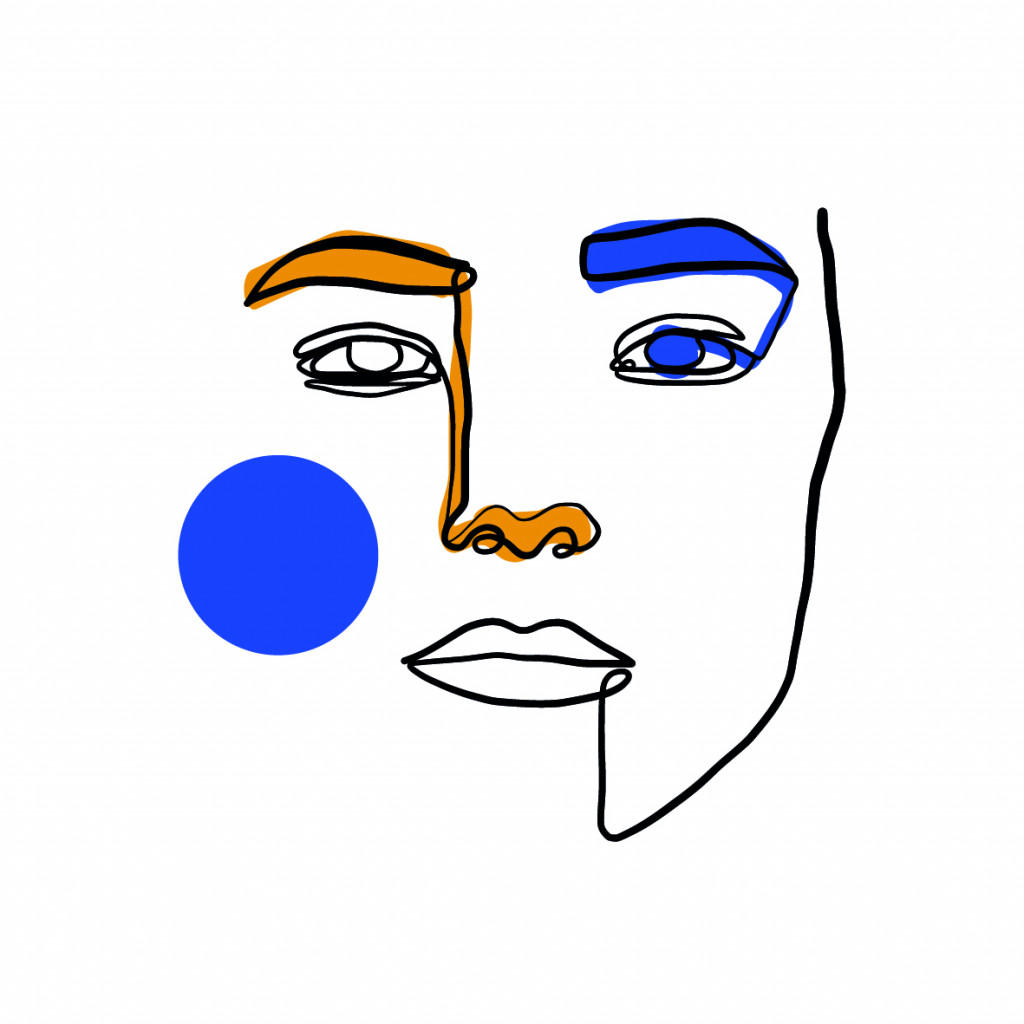Quando sarà il momento brillerà
Narrazioni/8 Alla scoperta della selvaticità di un quartiere e dei nuovi ritmi, sulla scia di pagine letterarie e dei propri occhi
 Foto Emilia Giorgi
Foto Emilia GiorgiNarrazioni/8 Alla scoperta della selvaticità di un quartiere e dei nuovi ritmi, sulla scia di pagine letterarie e dei propri occhi
Da principio ho studiato «il mio angolo». Ho trascorso il primo mese di lockdown a studiare tassello dopo tassello il paesaggio che circonda la mia abitazione a Roma. L’ho fatto perché non avevo altro da fare, per noia, per paura, per sfuggire al pensiero fisso del virus. Mi sono resa conto che quell’angolo non lo conoscevo poi così bene, sempre presa da spostamenti verso il resto della città, verso altre città. Osservando il microcosmo attorno, ho iniziato a scoprire ogni giorno nuovi dettagli. Ogni dettaglio una storia. E in ogni storia un modo inedito di interpretare la nozione stessa di spazio pubblico. Quanto porteremo con noi di questa esperienza?
Di fronte casa, c’è un grande albero ricoperto da un fitto rampicante. A marzo era già pieno di uccellini, come ogni anno. Ma, in assenza di traffico, il loro cinguettio frenetico era l’unico suono percepibile. Ho iniziato ad osservarlo, come fosse una grande struttura abitata. L’albero si trova all’interno di un fazzoletto di terra pubblico, il cui accesso è interdetto da un privato. Ecco perché questo piccolo giardino ha assunto caratteri di selvaticità inconsueti, all’interno di un quartiere fortemente cementificato. Quel brulicare di vita così incalzante, mi ha fatto pensare al libro Cipì, celebre esperimento letterario collettivo promosso nel 1972 da Mario Lodi, insieme ai suoi alunni della scuola di Vho di Piadena. Costretta in casa durante l’emergenza sanitaria, il libretto di Lodi che tratta di una comunità di passerotti e dell’importanza di agire in senso collettivo, mi riportava alla mente il ruolo fondante dei bambini e delle bambine che «non finiranno mai di sorprenderci» (Mario Lodi, 2010) e la necessità di ripartire dalle loro attitudini e qualità creative, per ripensare quella «normalità» che a molti di noi sta ormai tanto stretta. «Cipì e Passerì – così si chiude il testo – conobbero la felicità e ebbero tanti figli a cui insegnarono le cose imparate nella vita: ad essere laboriosi per mantenersi onesti, ad essere buoni per poter essere amati, ad aprire bene gli occhi per distinguere il vero dal falso, ad essere coraggiosi per difendere la libertà».

La «documentazione del mio angolo» – ricordate il film Smoke di Wayne Wang? – mi porta a girare un poco lo sgaardo per osservare la via che costeggia l’edificio in cui abito. Un tratto di strada quasi cieco che confluisce in un’area artigianale. Un breve percorso, un po’ defilato, che in quel periodo inconsueto, si trasformava furtivamente e occasionalmente in un’area giochi, per bici e monopattini dei bambini che abitano le poche case del circondario. La strada, senza veicoli, smetteva il suo ruolo deputato alla circolazione, per diventare campo libero di azione e svago.
Vado oltre, mi addentro nella zona degli artigiani. Solitamente una sorta di agorà informale. Spesso ascolto i discorsi degli operai su attualità, politica: le loro parole entrano nella mia casa. Ma in questo periodo vengono poco e a intermittenza. Al loro posto, compare un giovane uomo mai visto. Con pochi gesti e due semplici tavole di legno, ogni giorno monta e smonta il suo rifugio per la notte. La strada diviene abitazione veloce e discreta. Lo spazio pubblico diventa intimo, privato. Luogo per dormire, nelle ore notturne, leggere e pregare, durante le ore diurne, nel periodo di Ramadan. Luogo del sacro e del profano. Un caso perfetto per il Soft Home Diary, una minuta e preziosa ricerca che Federica Verona compila su instagram per raccontare «come le persone usano la strada per farla diventare casa, utilizzando semplici oggetti, organizzando il proprio spazio, decorandone alcune parti con cura e attenzione».
Lo spazio pubblico, anche durante il lockdown, non era scomparso, acquisiva nuovi aspetti, qualità e utilizzi, fino a diventare riparo, casa. E nel frattempo le case, quelle chiuse da quattro mura, diventavano porose, si aprivano verso l’esterno. Le finestre si facevano soglie per nuove forme di comunicazione a distanza. La stanza, luogo del privato, si fondeva con la strada. Poteva diventare persino immaginario luogo di spostamento, viaggio o fuga. Penso a Planisferoom, progetto estemporaneo di Francesco Careri che ha aperto tutte le sue mappe per rivestire una stanza, in ogni sua piccola superficie, e dare vita a una chambre à voyager. Un progetto aperto a tutti, attraverso l’hashtag #planisferoom. In un periodo di continuo vociare – tra dirette facebook, instagram e youtube – una silenziosa ma potente opera, fatta di rotte, tracciati, strade, corsi d’acqua e boschi. Mi riporta alla mente Il viaggio del giorno in ottanta mondi che il suo autore Cortázar così descrive: «Un viaggio intorno al mondo, come quello di Phileas Fogg, ma senza muovermi dalla mia scrivania. Un libro pazzo, da fuori di testa, fatto di ritagli e avanzi, come un grande collage».
Nel frattempo il viaggio concesso dal minuscolo virus – alla scoperta di un nuovo ritmo determinato da tempi lenti, vuoti e piccoli passi – procede verso nuove fasi, sembra lasciare il posto alla frenesia della vita precedente, dimenticando quella necessaria trasformazione che in parte abbiamo vissuto e di cui tanto si è parlato. Ma, c’è un ma. “Tutto sembra essere tornato come prima, ma in realtà tutto è cambiato» ci ricorda Christian Caliandro su Artribune. «Nonostante tutti gli sforzi e i tentativi, il tempo non torna quello di prima. Il vecchio tempo è stato sostituito»
*Titolo tratto da Colle der Fomento, “Storia di una lunga guerra”, album “Adversus”, 2018
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento