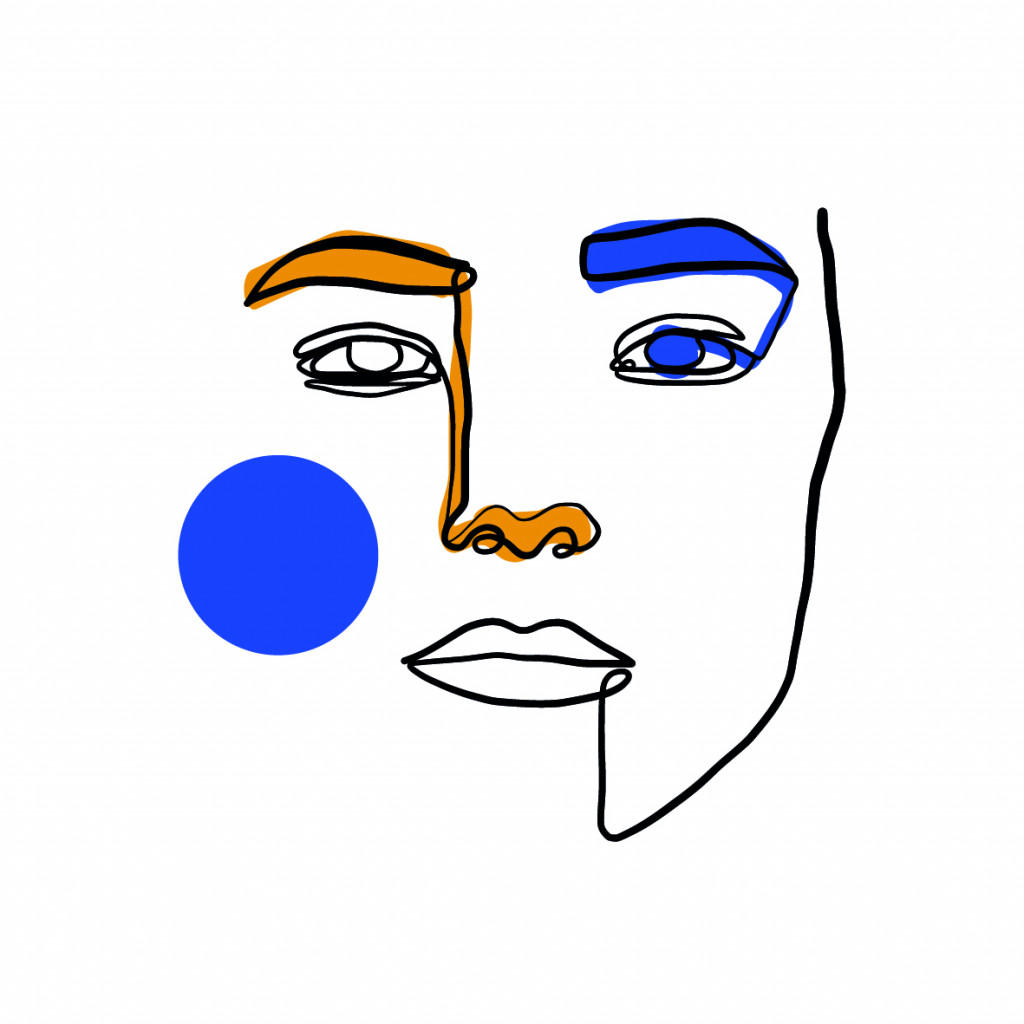Com’è cominciato tutto? Mito greco e patriarcato
Già, com’è cominciato tutto? Quando si è strutturata una gerarchia dei sessi che ha imposto il dominio del maschile sul femminile dando via alla teorizzazione della superiorità degli uomini sulle donne e della complementarità di due generi fortemente distinti? Perché la società ha naturalizzato una diseguaglianza che nulla ha di naturale, accettandola per secoli, con il suo portato di infelicità, come un’evidenza o come un destino?
Sono domande fondamentali sull’origine di quello che, a partire dall’Ottocento, si definisce patriarcato. E sono domande del tutto legittime, che danno voce al nostro bisogno di determinare il «principio» per vederci chiaro nelle dinamiche che hanno portato a un’oppressione storica sempre operante.
Risaliamo dunque a un possibile «principio», cioè al mito greco, o meglio alla mitologia, da intendersi come l’insieme dei racconti «intorno a dèi, esseri divini, eroi e discese nell’aldilà» – secondo la definizione che ne dà Platone, Repubblica, 392 a – trasmessa dalla Grecia alla civiltà romana, in seguito accolta dall’Umanesimo ed entrata poi a far parte della cultura e dell’immaginario occidentale. Nel suo tentativo di farsi racconto totale del mondo, il materiale del mito greco – o meglio dei miti, più in generale, mediterranei – può fornirci qualche dato importante su cui ragionare.
Innanzitutto, però, vorrei fare una considerazione sul metodo di osservazione. La domanda circa i fondamenti patriarcali del mito proviene da una lotta politica del presente che, per essere condotta con efficacia, non dovrebbe, a mio parere, soprapporre la propria sensibilità e le proprie tematiche a fenomeni storici e culturali lontanissimi. In altre parole, credo sia sempre necessario evitare di appiattire i fenomeni del passato sui bisogni del presente. Il rischio è di indebolire le nostre posizioni, cadendo dall’errore di metodo a errori nel merito, perché finiamo col privarci degli strumenti più affilati per decostruire l’oggetto della nostra analisi.
Come fare allora a condurre una riflessione sulle origini del patriarcato? Rivolgiamoci a una disciplina concreta come l’archeologia, che insegna a vedere i fenomeni nei loro nessi con la materialità, e proviamo a fare un breve discorso di tipo «archeomitologico», per usare un termine coniato da Marija Gimbutas, archeologa e linguista lituana. Ragioniamo non tanto sul principio dell’ordine patriarcale, quanto sui processi di formazione di questo stesso ordine. Nello stesso tempo, cerchiamo anche di capire fin dove riesce ad arrivare il nostro sguardo su tutto l’apparato patriarcale.
Risaliamo più indietro possibile, alla preistoria, termine di per sé molto ampio che definisce quella fase della vita umana sulla Terra precedente all’invenzione della scrittura e divisa in Paleolitico, Mesolitico, Neolitico, Età del rame, Età del bronzo ed Età del ferro. Per farci un’idea delle oscillazioni nello sviluppo delle società umane, ricordiamo, per esempio, che nel III millennio a. C. noi eravamo ancora nella preistoria ma nel sud della Mesopotamia si era già dentro la storia con le prime forme di scrittura e letteratura. E non a caso dalla Mesopotamia ci arrivano, attraverso il Mediterraneo, i primissimi miti, come l’epopea di Gilgamesh.
In ogni caso, nemmeno gli strati più antichi dei miti mediterranei sono sovrapponibili a questi primordi dell’umanità, che sono ben più antichi. Se immaginiamo di fare un ideale scavo stratigrafico del mito, possiamo forse arrivare al Neolitico. Pensiamo al miti agrari egiziani, legati alle inondazioni del Nilo, che narrano della morte di Osiride, smembrato da Seth e ricomposto da Iside, che avrà da lui il figlio Horus, suo vendicatore.
Così, a partire dalle poche tracce iconografiche dell’arte paleolitica, dai resti di sepolture con i loro corredi funerari – cioè da uno 0,0001% di quella civiltà sopravvissuto al tempo – non possiamo darci una risposta certa sull’origine del patriarcato. La stessa rappresentazione schematica di un’umanità primitiva divisa in uomini consacrati alla caccia, da una parte, e in donne dedite alla raccolta, dall’altra, è già pura ideologia. In realtà, da quanto ricaviamo dai dati a nostra disposizione, esisteva una cooperazione tra i sessi nelle attività della vita quotidiana e non una ripartizione dei compiti in base a una pretesa “natura” propria a ciascun sesso.
Sul Neolitico, invece, disponiamo di un maggior numero di dati. Possiamo così affermare che la privatizzazione della terra e la concentrazione dei beni nelle mani di un potere centrale – e quindi l’avvento di una società gerarchizzata in quelle che, con termine moderno, possiamo definire classi – deve aver rappresentato un passo verso il patriarcato. Questo passaggio avviene nel quadro dell’organizzazione socio-economica detta «palaziale», poiché il centro del potere era rappresentato da un palazzo, dove venivano raccolte e accumulate le ricchezze della comunità. Il palazzo faceva capo a una figura regale o anche sacerdotale, come il mitico re Minosse, con la sua reggia, il labirinto, il Minotauro e tutti i racconti annessi.
Sappiamo anche che, ad un certo punto, si fanno strada miti in cui una divinità femminile intronizza un uomo mortale. Soffermiamoci un momento su queste investiture, veri e propri passaggi di potere in forma di ierogamie, cioè unioni erotico-amorose di divinità e mortali.
La più antica versione di queste storie riguarda la dea mesopotamica Inanna/Ishtar e il pastore Tammuz/Dumuzi. Testi sumerici (la più antica letteratura che ci è nota) raccontano la storia della dea Inanna che si innamora del pastore Tammuz, conferendogli lo statuto di re della sua comunità. La popolazione accadica recupera il mito cambiando i nomi dei protagonista in Ishtar e Dumuzi. Ex oriente lux: nell’Età del bronzo l’archetipo arriva in Fenicia e poi in Grecia – dove Dumuzi diventa Adone, nome a noi più famigliare – e da là si propaga in Occidente attraverso le colonie greche, da una parte, e l’Etruria dall’altra. Dal mondo etrusco esso penetra a Roma: pensiamo al mito di Servio Tullio che si unisce sessualmente con la dea Fortuna mentre è addormentato nel tempio e diventa in seguito niente meno che re di Roma.
Inanna/Ishtar è la dea dell’eros come strumento di conoscenza (e non del sesso normato dal matrimonio) e delle contraddizioni dell’essere, presiede alla guerra, ai cicli della natura, incarna la giustizia e la bellezza. Tra le sue avventure, si annovera una discesa nell’oltretomba, nel regno della sorella Ereskigal. Lo scopo di questa catabasi è niente meno che il tentativo di abolire la morte dalla faccia della terra. Per passare le sette porte degli inferi, però, Inanna/Ishtar deve spogliarsi di sette elementi, vesti e gioielli che ornano e proteggono il suo corpo, tutti lussi propri del suo regno e non ammessi nel reame del nulla. La nudità con cui, alla fine, si presenta di fronte alla sorella infera è una spogliazione dei suoi poteri e, insieme, una rivelazione: vita e morte, divino e umano, sono sfere separate e inconciliabili. Sconfitta, per uscire dal mondo sotterraneo del nulla, la dea dell’essere deve trovare un sostituto che muoia per lei. Sarà lo sposo mortale, Tammuz-Dumuzi, a prendere il suo posto e a morire.
In questi antichissimi miti mesopotamici risulta evidente sia la preminenza della divinità femminile, di cui il maschio prescelto è solo un paredro – letteralmente «colui che siede accanto» – sia il passaggio pacifico di potere da un genere all’altro mediante la scelta amorosa, nel segno non della violenza ma di un eros vitale e condiviso.
Il materiale mitologico di cui disponiamo – in tutte le sue complesse diramazioni, dalla Mesopotamia fino al nostro Occidente, attraverso le onde del Mediterraneo – si intreccia verosimilmente con quella che Gimbutas definì «la vecchia Europa», cioè la cultura pre-indoeuropea del Neolitico, e svolge questa funzione: raccontarci per immagini e avventure di divinità e mortali le faglie e le contraddizioni di un sistema, quello patriarcale, che a poco a poco si impone ma che non smette di confrontarsi con un altro possibile ordine del mondo, a “trazione femminile” e non improntato a rapporti di dominazione. Non uso la categoria di matriarcato, per due ragioni: da una parte, per non cadere in una forzatura, applicando un concetto moderno a fenomeni remotissimi, da osservare nella loro alterità rispetto ai nostri schemi mentali; dall’altra, per non suggerire che si sia passati semplicemente dalla stropotere di un sesso a quello di un altro. I dati ci dicono che le cose fossero ben più complesse di così. Ammettere il nostro limite conoscitivo non deve fare paura; al contrario, questo limite ha un valore euristico enorme perché ci permette veramente di uscire da noi stesse e di immaginare mondi impensabili, impensati, inattesi, eppure possibili e forse anche esistiti.
Questo mondo a trazione femminile, dunque, era forse egemone più di 5000 anni fa, ovvero prima dell’arrivo in Europa delle popolazioni dette indoeuropee, nomadi e guerriere, provenienti dall’Asia centrale, organizzate in società di tipo patriarcale.
Accanto ai miti mesopotamici, anche il mito greco, così come lo conosciamo mediante i testi più antichi della nostra tradizione letteraria – l’Iliade e Odissea di Omero – offre alla nostra fantasia e riflessione figure femminili sfaccettate che tradiscono un antico potere, ben più grande di quello che sembrano avere nella società di impronta patriarcale in cui si muovono. Pensiamo all’Oceanina Teti, in apparenza una dea marina minore, nota soprattutto per essere la madre di Achille. In realtà, Teti è capace di piegare lo stesso Zeus alla sua volontà in nome di antichissimi favori politici. Quando gli dei dell’Olimpo avevano cercato di rovesciare il potere di Zeus, alleandosi contro di lui, Teti era intervenuta dalla sua parte, salvandolo dalla destituzione. Pensiamo anche a Elena, regina di Sparta, divina per metà, in quanto figlia di Zeus e della mortale Leda. Su di lei sappiamo tutto e il suo contrario: fu rapita, scelse deliberatamente di lasciare il marito, amava Paride, non lo amava ma si conformava semplicemente al volere degli dei, fu a Troia, non ci andò mai perché in realtà si fermò in Egitto, mentre a Troia tutti vedevano un fantasma…Quante incongruenze e scarti, di fatto, demoliscono ogni possibile banalizzazione e aprono mille scenari sul destino di Eva prima di Eva, perché questo fu Elena nel mondo antico. Inoltre, Elena è la donna più bella del mondo ma non è certo un soprammobile. Come Medea, è una medica e somministra farmaci capaci di placare il dolore e curare l’ira. Insomma, le personagge del mito non sono certo figurine sottomesse e bidimensionali. Non ho qui lo spazio per raccontare tutte le loro storie, tutte le deviazioni che prendono, con coraggio, per ribellarsi, con l’azione, con il discorso, al patriarcato egemone.
Nelle Nozze di Cadmo e Armonia Roberto Calasso si chiede, come noi: «Ma com’era cominciato tutto? Se si vuole storia, è storia della discordia. E la discordia nasce dal ratto di una fanciulla, o dal sacrificio di una fanciulla». In effetti, il mito ci racconta che tutto il danno che patiamo e che ci infliggiamo da sempre nasce da rapporti di dominazione, dalla violenza fatta a una donna. Così, il rapimento di Europa, principessa di Tiro, da parte di Zeus trasformato in toro, è piuttosto lo stupro di un dio maschio su una mortale per soddisfare un impulso sessuale che è insieme esercizio di potere. Niente scelta amorosa reciproca, niente eros condiviso nella gioia, come i testi mesopotamici ci raccontano. Così, la principessa Ifigenia viene condotta con l’inganno – la promessa del matrimonio con Achille – sull’altare dove sarà sacrificata per colpa (e volontà) di suo padre, il re Agamennone. Il sacrificio umano della figlia è l’unico modo per rabbonire la dea Artemide, contrariata dall’uccisione di una sua cerva sacra da parte dello stesso re, e permettere così alle navi greche di andare a seminare morte e distruzione nella ricchissima città di Troia. Di violenza in violenza.
È chiaro che i miti greci ci raccontano (anche) di rapporti di dominazione e di violenza, di un (dis)ordine del mondo che è discordia e dolore moltiplicabili all’infinito. È bene mettere le parole giuste sulle cose, senza eufemismi; decostruire, per esempio, le ragioni per cui invece di «stupro» sentiamo parlare di «rapimento» o, più aulicamente, di «ratto», per Europa o Proserpina, o ancora le donne Sabine.
Il mito greco però non racconta solo questo ma, soprattutto, non coincide ideologicamente e automaticamente con questa barbarie. Al contrario, rappresentandola e interrogandola, ce la offre come materiale vivo, magmatico, pieno di contraddizioni e vie d’uscita dalla violenza, dal male, dal non senso dell’esistenza; non certo come dato “di natura”, dogma intoccabile di un’aurea tradizione. D’altra parte, se abbiamo paralizzato gli antichi in icone neoclassiche da venerare dietro a un vetro, sacre e intoccabili, il problema è nostro, non loro. Lo stesso vale per i padri del pensiero occidentale, da Platone e Aristotele in poi.
Per concludere, emanciparci dall’idea che ci sia un inizio partenogenetico di qualunque cosa ci aiuta a comprendere lo svolgersi dei fenomeni, che è poi l’essenza dei fenomeni stessi: phainómena, letteralmente «ciò che si manifesta», attraversa lo spazio-tempo e non è mai fisso. Io credo fortemente che il compito del nostro tempo sia la grande decostruzione delle sistematizzazioni del passato, passateci come buone e giuste e “naturali” dall’autorità dei padri della nostra civiltà. Ma dopo aver decostruito, contestualizzando storicamente, archeologicamente, filosoficamente, non buttiamo via i pezzi. Dopo aver capito come funziona l’ingranaggio delle grandi narrazioni a lungo prese per buone, facciamone tesoro di conoscenza e di consapevolezza, per capire da dove veniamo, quanto cammino abbiamo fatto e quanto ne resta da fare per emanciparci davvero. E per andare avanti abbiamo bisogno di tutta la nostra intelligenza, dice Gramsci invitandoci a studiare, a istruirci.
*
Francesca Sensini è professoressa associata di Italianistica presso la facoltà di Lingue e letterature straniere dell’Université de Nice–Sophia Antipolis, dottoressa di ricerca dell’Università Paris IV Sorbonne e dell’Università degli Studi di Genova. Comparatista di formazione, dedica le sue ricerche alle riletture e all’ermeneutica dell’antichità classica tra il XVIII e l’inizio del XX secolo in Italia e in Europa, nonché alle rappresentazioni letterarie e più generalmente culturali legate al genere. Tra i suoi ultimi libri: La lingua degli Dei. L’amore per il greco antico e moderno (Il Nuovo Melangolo 2021); Pascoli maledetto (Il Nuovo Melangolo 2020).
*
Cenni bibliografici
John Boardman, Archeologia della nostalgia, Milano, Mondadori, 2004
Jean Bottéro [a cura di], L’Oriente antico. Dai Sumeri alla Bibbia, Bari, Edizioni Dedalo, 1994
Roberto Calasso, Le nozze di Cadmo e Armonia, Milano, Adelphi, 2009
Marja Gimbutas, La civiltà della Dea, Stampa alternativa, 2013
Eadem, Kurgan. Le origini della cultura europea, Medusa edizioni, 2010
Eadem, Il linguaggio della Dea, Venexia, 2008
Eadem, Le dee viventi, Medusa edizioni 2005
Furio Jesi, Letteratura e mito, Torino, Einaudi, 2002
Jean-Pierre Vernant, Mito e pensiero presso i greci. Studi di psicologia storica, Torino, Einaudi, 2001
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento