Narcisismo maschile e gender gap
SCIENZA L’autopromozione dei lavori scientifici non è la stessa per donne e uomini. Uno studio pubblicato sul «British Medical Journal» evidenzia come i ricercatori, nei propri articoli scientifici, si lodino e autoincensino di più. Le colleghe meno. L’ipotesi è che vi sia una relazione con la scarsità numerica delle donne in ruoli apicali accademici

SCIENZA L’autopromozione dei lavori scientifici non è la stessa per donne e uomini. Uno studio pubblicato sul «British Medical Journal» evidenzia come i ricercatori, nei propri articoli scientifici, si lodino e autoincensino di più. Le colleghe meno. L’ipotesi è che vi sia una relazione con la scarsità numerica delle donne in ruoli apicali accademici
Inedita. Promettente. Innovativa. Unica. Eccellente. Chi si occupa di giornalismo scientifico, questi aggettivi riferiti a una nuova ricerca li incontra tutti i giorni. D’altra parte, in un mondo in cui le pubblicazioni scientifiche sono passate da meno di 300mila all’anno (all’inizio degli anni 80) fino a più di un milione e duecentomila nel 2017 – e parliamo solo dell’ambito biomedico – è inevitabile dover ricorrere all’autopromozione per farsi notare. E questo vale non solo per le reti sociali, ma anche per titoli e abstract (i brevi riassunti di presentazione che precedono l’articolo scientifico vero e proprio) delle stesse pubblicazioni. È lì che ricercatori e ricercatrici tentano disperatamente di attrarre l’attenzione dei colleghi sul proprio granellino di sabbia che apportano al castello delle conoscenze comuni, quello che in qualche modo la comunità scientifica nel suo congiunto cerca di costruire.
MA NON TUTTI si lodano allo stesso modo. Chi si loda di più, i ricercatori o le ricercatrici? Se lo sono chiesto Marc Lerchenmueller, Olav Sorenson e Anupam Jena, tre ricercatori (uomini) che lavorano ad Harvard, Yale (Stati Uniti) e Mannheim, in Germania, in un articolo sul British Medical Journal (Bmj). Per studiarlo hanno analizzato più di 101mila articoli di ricerca clinica e la ragguardevole cifra di 6 milioni e 200mila articoli di scienze della vita pubblicati fra il 2002 e il 2017 e indicizzati su PubMed, l’archivio digitale della ricerca biomedica più conosciuto al mondo. L’impresa è meno banale di quel che sembra. Primo, perché non sempre è ovvio dedurre dal nome di una persona il suo sesso. Per questo hanno usato Genderize, un database che indica l’incidenza di maschi e femmine associati a un nome. Per attribuire un nome al genere femminile, nel database almeno il 90% di chi portava il nome doveva essere donna.
Secondo, i ricercatori hanno preselezionato 25 aggettivi, fra i quali quelli elencati all’inizio, che poi hanno cercato all’interno degli articoli scientifici. Ma il livello di novità e importanza di ciascuno dei temi di ricerca era differente: magari certe scoperte erano davvero più «innovative» o «inedite» di altre. Per cui i tre scienziati hanno confrontato articoli di livello di novità analogo (secondo le parole chiave indicate nelle stesse pubblicazioni), nonché in riviste di analogo fattore di impatto (l’impact factor è un numero associato a ciascuna rivista che, in qualche senso, ne indica il prestigio). Il tutto per verificare la coerenza dei loro risultati.
Infine la difficoltà più importante: la scienza è quasi sempre un lavoro di squadra.
Come identificare chi ha scritto un articolo fra quattro, cinque o dieci autori? Per prassi, nel campo biomedico, il primo autore dell’articolo è sempre il ricercatore o la ricercatrice più giovane, e l’ultimo è il supervisore. Sono questi gli autori su cui si sono concentrati Lerchenmueller, Sorenson e Jena.
Se entrambi erano ricercatrici, c’era ben il 21% di probabilità in meno di usare aggettivi positivi per definire la propria ricerca pubblicata su riviste di alto impatto (quelle che contano di più ai fini della carriera) che se almeno uno dei due autori principali era un uomo. In generale, per tutte le riviste, la percentuale era del 12% in meno. In particolare, la parola «novel» (nuovo, innovatore) era usata il 59% più spesso da ricercatori che da ricercatrici. Sia uomini che donne, naturalmente, usano termini positivi per descrivere la propria ricerca, ma le donne lo fanno meno frequentemente.
E C’È DI PIÙ. Gli articoli venduti meglio, cioè con un uso più consistente di aggettivi autoelogiativi, sono anche quelli che vengono citati con maggiore frequenza dai colleghi. Segnatamente, un 9% in più (che arriva fino al 13% nelle riviste di alto impatto). In sostanza, i ricercatori tendono a lodare di più i propri risultati scientifici, e quanto più lo fanno, maggiore è la probabilità che i loro articoli vengano citati. Il che a sua volta fa che abbiano maggiori chance di miglioramenti di carriera.
E la disparità esiste nei fatti. Nel mondo, le donne ricercatrici sono meno degli uomini, in particolare nelle posizioni apicali. Secondo i recenti dati di Youtrend, le donne in Italia rappresentano il 38% del corpo accademico (sono la maggioranza solo in scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche e in scienze biologiche), ma sono solo il 24% dei professori associati e il 39% delle associate, mentre sono quasi la metà dei ricercatori, lo scalino più basso della carriera accademica. I risultati della ricerca del Bmj non sono affatto sorprendenti. Una volta la scrittrice Sarah Hagi lo ha riassunto efficacemente: «Signore, dammi la fiducia in me stessa di un uomo bianco mediocre», una frase che ormai viene stampata persino sulle magliette.
NON C’È SOLO un gender gap e un salary gap (disparità di genere e di salario): c’è anche un confidence gap, una disparità di fiducia in se stesse. Le scienziate si muovono nella stessa società in cui vivono tutte le altre donne, una società patriarcale che costruisce aspettative sulle donne diverse da quelle per gli uomini. Decine di studi dimostrano che le donne tendono a sentirsi meno sicure e a sottovalutare le proprie competenze quando, alla prova dei fatti, sono equivalenti a quelli dei loro colleghi uomini. L’autopromozione, la sicurezza in se stesse, l’assertività sono qualità che tendono a essere stigmatizzate se sono donne a mostrarle, e lodate se a esibirle sono uomini. Forse le donne devono imparare a «vendersi» meglio e a lodarsi di più? Certamente gli uomini devono imparare a contenersi. Ma tutta la società – e gli editori delle riviste scientifiche in particolare – devono essere consapevoli di questa disparità. E combatterla.
*
SCHEDE
Il terzo umano geneticamente modificato
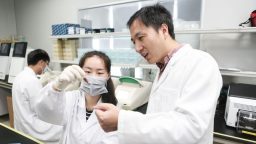
***
L’intelligenza artificiale contro il cancro

***
«Science»: un errore da premio Nobel

I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento