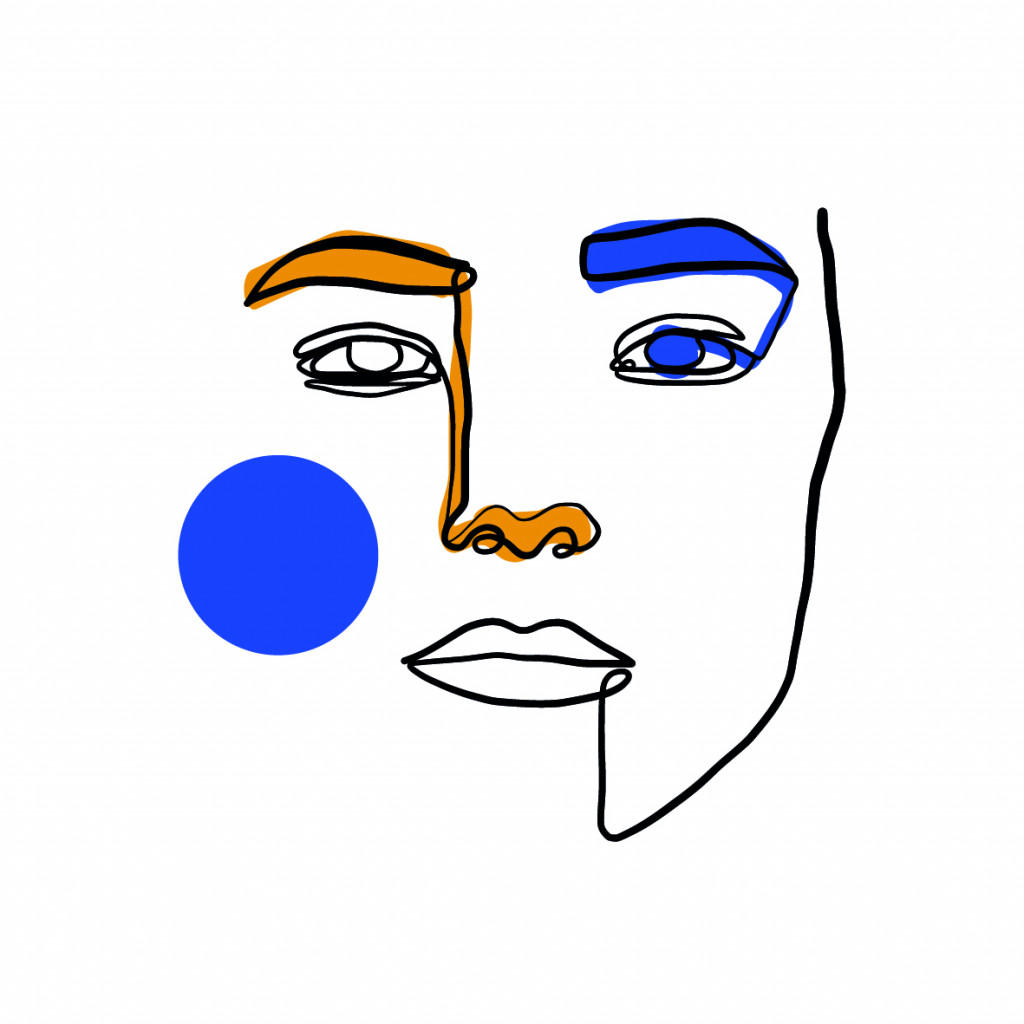La complessità di un tempo sospeso
#donne&lavoro/ 32 «Da quando le misure anti-Covid hanno reso popolare lo smart working, grazie a un’indicazione neanche così precisa del governo, ho cominciato a mettere da parte tutti gli articoli che sono passati sotto i miei occhi. Mi occupo di lavoro da casa da un po’. L’ho fatto in anni non sospetti quando la precarietà spingeva molti e molte di noi ad attrezzare una parte della casa ad ambiente di lavoro»
 Viso di donna in dissolvenza, tecnica di costruzione con mattoncini di lego, Shutterstock Inc.
Viso di donna in dissolvenza, tecnica di costruzione con mattoncini di lego, Shutterstock Inc.#donne&lavoro/ 32 «Da quando le misure anti-Covid hanno reso popolare lo smart working, grazie a un’indicazione neanche così precisa del governo, ho cominciato a mettere da parte tutti gli articoli che sono passati sotto i miei occhi. Mi occupo di lavoro da casa da un po’. L’ho fatto in anni non sospetti quando la precarietà spingeva molti e molte di noi ad attrezzare una parte della casa ad ambiente di lavoro»
«Se si smaterializza il lavoro, mi smaterializzo anche io». Dopo aver passato qualche giorno a riaprire e mettere in ordine una casa di famiglia in cui non andava più nessuno da anni, un’amica ha deciso di andare incontro, così, alle incertezze del futuro che ci aspetta, smaterializzandosi anche lei. Non è la sola che conosco a prepararsi con l’invenzione di cambiamenti possibili alle decisioni, per ora insondabili, che governi e istituzioni varie prenderanno nei prossimi mesi. Quando sono entrata nella casa che sarà, forse, la sua possibile postazione di smart working sono rimasta abbagliata da quello che vedrà dalla finestra, campagna e poi mare a perdita d’occhio, ma non ho potuto fare a meno di pensare che quell’isola, in cui i nonni dei suoi nonni avevano una casetta, è stata nel tempo terra di confino e sede di una colonia penale. Solo recentemente il turismo ha fatto di quei luoghi terra di approdo per chi cerca una vacanza. Per quanto io mi sia già prenotata per qualche giorno di settembre o ottobre, sarà bellissimo, resto inquieta pensando al movimento con cui alcune di noi stanno progettando e hanno progettato in questi mesi vie di fuga e smaterializzazioni di varia natura.
Saremo capaci di metterci una lontana dall’altra continuando a inventare legami, affetti, pensieri, politica? Stiamo cercando modi per non tornare alla normalità («perché quello era il problema» dice lo slogan) o stiamo lasciando libero lo spazio di decisioni che saranno prese anche per noi che ci stiamo – potendo – smaterializzando, lasciando, come alcune stanno facendo anche per passione ecologista, le città per le campagne e gli uffici per i luoghi scelti di confino?
Questa estate è il vero «tempo sospeso», più dei mesi della quarantena questi mesi estivi sembrano in bilico fra la libertà ritrovata e l’inevitabile uso anarchico che ne stiamo facendo e la preoccupazione che il virus – o le decisioni che servono per limitare i contagi – ci costringano di nuovo in case troppo piene, troppo piccole, da cui non è possibile uscire senza il sacchetto dei rifiuti in una mano e la spesa nell’altra. In questo lungo periodo gravido di eventi impensati, di dolore, di polemiche ma anche della messa a valore di semi per il futuro, forme di consapevolezza che temevamo di non poter cogliere mai per il carattere della società cui siamo immersi – la vulnerabilità dei nostri corpi, la dipendenza reciproca, il bisogno di cura – non siamo riusciti a dare un’altra forma al tempo, a modificarne la percezione, la scansione, la durata. Abbiamo corso, sempre, anche da fermi, anche nello spazio chiuso delle nostre case. «Sto correndo, io ti vedo ferma, e io ti dico che sto correndo» recitava un verso di Claudia Bruno in esergo a un saggio sul lavorare da casa che abbiamo scritto insieme qualche anno fa. È servita l’estate, la chiusura delle scuole già chiuse, la riapertura esitante dei luoghi di ritrovo (spiagge sì, teatri no) e quella incongrua dei luoghi di produzione (fra ferie, smart working e fabbriche che sono tornate a funzionare come se niente fosse), per darci il senso di un tempo in attesa, verso quell’autunno in cui non sappiamo ancora cosa succederà.
Nel frattempo ci prepariamo a ripensare i nostri luoghi privati e ad attrezzarli per lavorare. Abbiamo imparato a fare le riunioni on line, a passare più tempo di fronte ai nostri schermi, a ignorare quel disagio strisciante che ci procura l’essere a distanza, il non poter condividere lo spazio o allestirlo, senza accorgercene, con il nostro modo di muoverci, di guardare, di entrare in relazione con gli altri. Abbiamo imparato a non soffrirne troppo, a volte siamo state anche contente di poter non essere nella solita stanza, con i soliti colleghi, obbligate a una presenza inutile, a un quotidiano faticoso spostamento. Abbiamo imparato a concentrarci tenendo testa a un doppio brusìo, quello di casa e quello che esce dalle tante, troppe, piattaforme che abbiamo frequentato in quarantena e che restano lì, una in fila all’altra nei nostri computer e telefoni, con i vari account in cui siamo diventate plurimamente reperibili e che squillano, notificano e reclamano la loro versione di presenza.
Da quando le misure anti-Covid hanno reso popolare lo smart working, grazie a un’indicazione neanche così precisa del governo, ho cominciato a mettere da parte tutti gli articoli che sono passati sotto i miei occhi. Mi occupo di lavoro da casa da un po’. L’ho fatto in anni non sospetti quando la precarietà spingeva molti e molte di noi ad attrezzare una parte della casa ad ambiente di lavoro. Mi è interessata la capacità dello spazio di misurarsi con i bisogni più vari e soprattutto mi è interessata la capacità che ho visto all’opera di far giocare una dimensione rappresentativa, anche immaginaria, nel far sì che lo spazio domestico mantenga una doppia funzione, che rimanga «casa» mentre diventa «laboratorio» o «ufficio». Mi sono appassionata a descrivere e analizzare le immagini e le metafore con cui nel corso delle mie ormai antiche interviste sul lavorare da/a casa, donne di varie generazioni raccontavano il corpo a corpo con le dimensioni versatili e sottilmente alienanti di ambienti sovraccarichi di funzioni, sentendosi sempre a rischio di perdere valore, di non essere riconosciute per il loro fare molteplice fra lavoro professionale e lavoro di cura. Ho raccolto la fatica di adattamenti creativi, organizzazioni a scacchiera fra un tempo dedicato al lavoro e uno che funziona apparentemente in automatico, coperto dai gesti che compongono la vita quotidiana, fatto anch’esso di lavoro ma di un lavoro naturalizzato ed eternamente mal distribuito fra i generi e le generazioni.
Quello che nel frattempo della crisi è successo rende questi pensieri inattuali. La sperimentazione degli scorsi mesi, dalle dimensioni inimmaginabili (oltre otto milioni di persone), ha spinto verso l’innovazione dei sistemi tecnologici, gli aggiustamenti burocratici, gli adeguamenti d’emergenza. Nella mia personale rassegna stampa osservo, andando indietro, articoli che inneggiano alla «rivoluzione» e danno indicazioni a singoli e imprese per affrontare il cambiamento e sfruttare al meglio il potenziale di un modello che sgancia l’organizzazione del lavoro dalle misure ordinarie di tempo e spazio per ricalibrarle su compiti e obiettivi, altri più cauti che ne mostrano rischi e vantaggi, altri ancora che suonano l’allarme per il definitivo riconfigurarsi del lavoro a fatto individuale, sorretto da accordi di natura privata.
I prossimi mesi saranno dirimenti. La scommessa è quella di sperimentare modelli organizzativi mobili senza che la distanza li trasformi in un allentamento progressivo di diritti esigibili, che la smaterializzazione a cui punta la mia amica non le renda impossibile tornare indietro verso il suo tavolo di lavoro, se lo vuole, lei che un tavolo e un posto di lavoro ce l’ha.
Hannah Arendt diceva che «un vivere insieme nel mondo significa essenzialmente che esiste un mondo di cose tra coloro che lo hanno in comune, come un tavolo è posto tra quelli che vi siedono intorno; il mondo, come ogni in-fra (in-between), mette in relazione e separa gli esseri umani nello stesso tempo».
Avremo un bel po’ da fare per far sì che smaterializzandosi il lavoro resti parte del mondo che abbiamo in comune. «La sfera pubblica – continua Arendt – in quanto mondo in comune, ci riunisce insieme e tuttavia ci impedisce, per così dire, di caderci addosso a vicenda».
*
Sandra Burchi, Ricercatrice indipendente collabora con il Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università di Pisa e con vari enti No Profit. Si occupa di trasformazioni sociali e cambiamenti del lavoro, con una particolare passione per le teorie e gli studi femministi. Ha pubblicato: Come un paesaggio. Pensieri e pratiche fra lavoro e non lavoro, con Teresa Di Martino (Iacobelli editore 2013) e Ripartire da casa. Lavori e reti dallo spazio domestico (Franco Angeli 2014).
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento