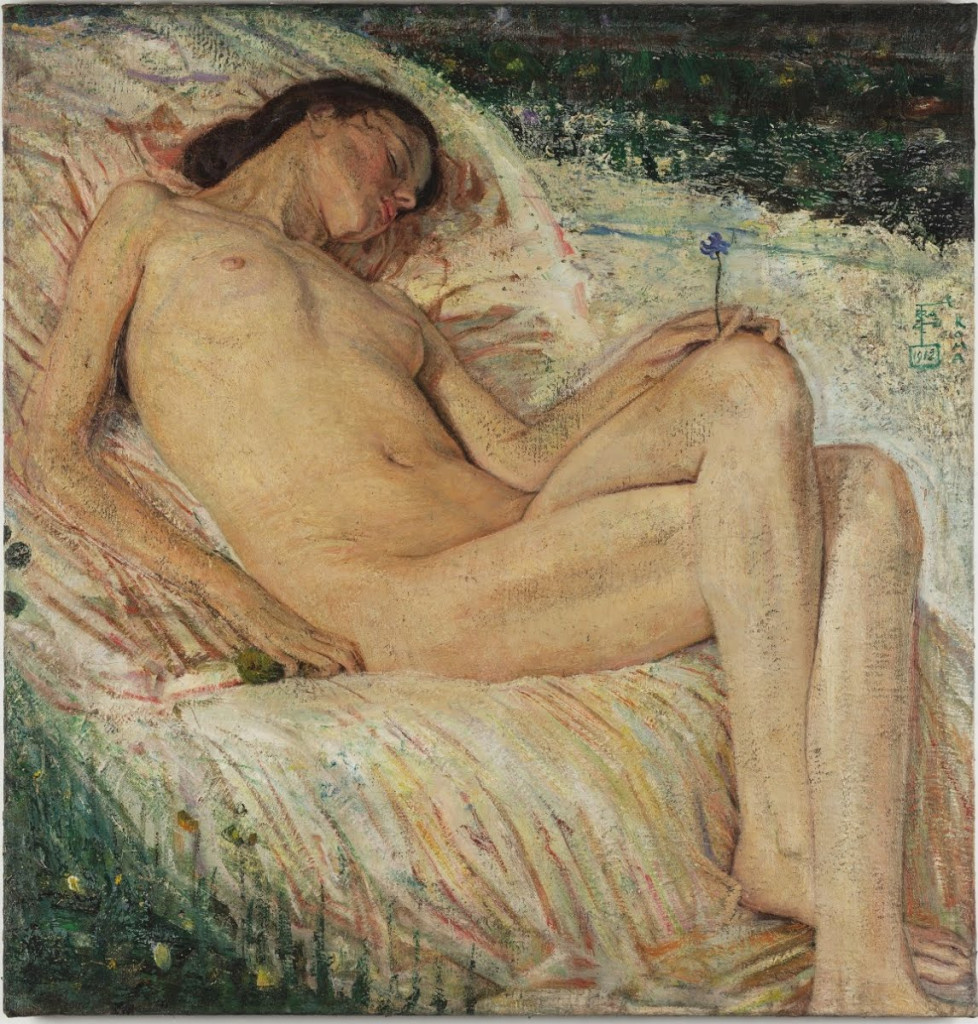
Un ragazzo struggente all’alba del Novecento
Si può dire che l’esile mito di Sergio Corazzini preceda la morte del poeta appena ventunenne, sopraggiunta per tisi il 17 giugno 1907 a Roma in via dei Sediari, per fiorire con la sua sola foto che rimanga, la stessa che ritrae un adolescente dagli occhi neri, i capelli corvini, pallido e paffuto, con tanto di cravatta e solino inamidato: persino fatale, questa è la silhouette che più si addice a chi ha scritto, a mezzo fra l’insegna esistenziale e la dichiarazione di poetica, la Desolazione del povero poeta sentimentale, che resiste da un secolo nei programmi scolastici dove si legge fin dall’incipit «Perché tu mi dici: poeta? / Io non sono un poeta. / Io non sono che un piccolo fanciullo che piange». Tant’è che a Corazzini si attaglia più che ad ogni altro l’etichetta (in sé generica e coniata da Borgese) di crepuscolare, molto più che all’ironico e sardonico Guido Gozzano, più che a Marino Moretti (la cui provincia romagnola sa di Pascoli, di sussiego piccoloborghese) e più che all’amico Aldo Palazzeschi i cui estri sono multiformi e comprendono quelli di un futurista in pectore.
Perché Corazzini, se vogliamo, è crepuscolare sia in quanto utilizza il repertorio sconsolato del breguinage tipico dei maestri della periferia simbolista, i Rodenbach, Jammes e Maeterlinck (corsie d’ospedale, chiese spettrali, organetti di Barberia, domeniche vuote e piovose), sia in quanto annuncia il crepuscolo del semidio ovvero – l’espressione, celeberrima, è di Eugenio Montale – l’attraversamento del deserto procurato d’Annunzio, autentico sterilizzatore di una generazione giusto dalla sua invadenza condannata al silenzio o all’epigonismo del «falso evangelista», come scrisse Gozzano in persona.
Corazzini è l’autore di un libro solo che non vide mai stampato, il volume postumo delle Liriche uscito da Ricciardi nel ’22 a cura degli amici più intimi (fra i quali Alberto Tarchiani, Fausto Maria Martini, Corrado Govoni) e riproposto fino al ’59 quando torna con un saggio introduttivo di Sergio Solmi che fornisce un ritratto compiuto del poeta rilevandone «la musica sfatta ed esangue di parole e di immagini che ne è lo stesso respiro, la vibrazione più spontanea e adeguata» di qualcuno – aggiunge Solmi – le cui caratteristiche sono una «precoce vocazione alla malattia mortale, l’adolescente sensualità un po’ morbida, la intensa pietà religiosa derivatagli dalla madre nella speciale accezione languida e materialistica del cattolicesimo controriformista e barocco».
Il libro di Corazzini è in realtà la collazione di ben sei plaquettes (stampate a spese del poeta fra il 1904 e il 1906 nella Tipografia operaia romana) dai titoli vagamente liberty, ad esempio Dolcezze, L’amaro calice, Piccolo libro inutile, Libro per la sera della domenica. Fissato una volta per sempre nello stereotipo crepuscolare, la sua bibliografia critica è poverissima se si eccettua la monografia dedicatagli nel 1963 per Mursia da Stefano Jacomuzzi, il filologo cui si deve la curatela delle Poesie edite e inedite (Einaudi ’68), che se non corrisponde ufficialmente a un’edizione critica tuttavia è la base di tutte le successive fra cui spicca, per la ricchezza del commento di Idolina Landolfi, l’edizione Bur del 2007. (Sempre utile resta la biografia di Filippo Donini, Vita e poesia di Sergio Corazzini, De Silva 1949, introdotta da un ricordo affettuoso di Aldo Palazzeschi: si tratta di un lavoro che adduce documenti e testimonianze di prima mano e però è meno attendibile sotto il punto di vista critico perché sottrae il poeta alla marginalità letteraria che fu sua per ipotizzarne una centralità che invece non conobbe).
Rimane il fatto che, a cadenza, il poeta romano viene riproposto nella freschezza rediviva del suo piccolo canzoniere, come attesta da ultimo l’uscita di due antologie, Io non sono un poeta (a cura di Alessandro Melia, IinternoPoesia, pp. 156, € 12,00) e Dolcezze, L’amaro calice, Piccolo libro inutile e altre tristezze (con un saggio introduttivo di Mario Musella, Diana Edizioni, pp. 136, € 14,00). Data l’esiguità dei testi complessivi, le due scelte antologiche sono relativamente sovrapposte ma mostrano entrambe una tale disparità polimetrica da rendere evidente quel che di solito è ignorato o trascurato, vale a dire la sapienza metrica di un poeta che agli stampi tradizionali (esordendo quindicenne sui fogli dell’Urbe in sonetti romaneschi alla Cesare Pascarella) sa alternare composizioni in versi liberi, perciò con una scelta anteriore al battesimo ufficiale che in Italia cade solo nel 1908 e corrisponde al Verso libero di Gian Pietro Lucini.
Corazzini scarnifica i suoi testi, ne castiga la retorica e più che mai l’eloquenza: non rinuncia del tutto alle rime chiuse ma va sempre in cerca di una musica in sordina, modulata in grigio, struggente prima che patetica, una musica che davvero richiami gli organetti di Barberia cui rende omaggio esplicito evocando le domeniche derelitte della povera gente, i piaceri di un attimo, i fiori fatalmente appassiti e presto putrefatti, come nel primo quadro in settenari di Per organo di Barberia: «Elemosina triste / di vecchie arie sperdute, / vanità di un’offerta / che nessuno raccoglie! / Primavera di foglie / in una via deserta! / Poveri ritornelli / che passano e ripassano / e sono come uccelli / di un cielo musicale! / Ariette d’ospedale / che ci sembra domandino / un’eco in elemosina».
A un altro grande critico che anteponeva la sua freschezza alle artificiosità gozzaniane, Luigi Baldacci, capitò di dire che Corazzini è arrivato dove altri cominciano e ciò significa che il pianto di Corazzini, i suoi malati languori, le sue preghiere sottovoce e sussurrate nel chiasso della piena avventura dannunziana, in realtà fanno l’effetto di una tabula rasa paradossalmente più letale delle esibite ritorsioni e delle mirate aggressioni di un’avanguardia, per così dire, militarizzata. Ed è ovvio, altrettanto, che nell’atto di finire Corazzini apre una partita che non è in grado giocare perché la giocheranno altri, non lui ma i riconosciuti fondatori del nostro Novecento.
Il poeta romano, pallida erma bifronte, rimane in bilico fra l’interminabile Ottocento e i tumulti che annunciano il Secolo Breve, se una settimana prima di morire scrive qualcosa di premonitorio, un testo che sa di Novecento già avanzato, paludato di orifiamme e di tenebre, La morte di Tantalo, i cui versi finali richiamano un insospettabile lettore di Rainer Maria Rilke: «O dolce mio amore, / confessa al viandante / che non abbiamo saputo morire / negandoci il frutto saporoso / e l’acqua d’oro, come la luna //. E aggiungi che non morremo più / e che andremo per la vita / errando per sempre».
Peraltro il lascito di Corazzini al Novecento non è tangibile se non a momenti e per effetti di ricaduta periferica e pulviscolare. Per lo più sono echi, frammenti ricevuti con ironia ovvero incorporati con vistose cromature patetiche come in alcuni passaggi di penombra provinciale nell’Allergia (1963) di Massimo Ferretti o in certe partiture urbane (fra ludiche intemperanze e lazzi da morituro) a firma di Valentino Zeichen. Perché fra i paradossi di Sergio Corazzini, l’adolescente che non ebbe il tempo di diventare adulto, c’è anche quello rilevato da Aldo Palazzeschi, nella introduzione alla biografia di Donini, secondo cui è proprio la poesia ad avere insegnato a morire a questo ventenne. E non viceversa.
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento
