Tutta la prosa nascosta in un riff
Tempi presenti Bandita dalle piazze per la pandemia, la musica si prende la rivincita nei romanzi tra hippie, punk e altre diavolerie. Un percorso di lettura tra la Swinging London e i deserti californiani. Storie che pagano un tributo narrativo a un’epopea sgangherata ma che prima di tutto sono pensate, scritte e «suonate» come altrettanti brani o album
 Dani Gal’s Historical Records Archive. Istanbul Biennial for Contemporary Art, 2011
Dani Gal’s Historical Records Archive. Istanbul Biennial for Contemporary Art, 2011Tempi presenti Bandita dalle piazze per la pandemia, la musica si prende la rivincita nei romanzi tra hippie, punk e altre diavolerie. Un percorso di lettura tra la Swinging London e i deserti californiani. Storie che pagano un tributo narrativo a un’epopea sgangherata ma che prima di tutto sono pensate, scritte e «suonate» come altrettanti brani o album
«È la notte in cui la musica torna a casa. Una coda animata di adolescenti si snoda lungo il perimetro dell’edificio, i corpi appiccicati l’uno all’altro come a segnare il proprio territorio. Tutti sognano una serata in grado di scardinare e trasformare le loro desolate realtà. E la serata è questa». Quando Jeff Jackson, scrittore, drammaturgo e musicista apprezzato tra gli altri da Don DeLillo e Dennis Cooper, ha composto queste frasi, non immaginava potessero finire per racchiudere lo spirito che intorno alla musica si è andato depositando lungo questo anno di pandemia. Privata degli spazi pubblici, bandita necessariamente dalla socialità, orfana di concerti, happening e perfino dei busker nelle strade ormai deserte, «la musica torna a casa» in forma di desiderio frustrato, di struggente sentimento dell’assenza, di un bisogno che i social, la rete, e ancora meno la tv, possono soddisfare.
A RIEMPIRE QUESTO VUOTO, destinato certamente a prolungarsi, si candidano ora un pugno di romanzi nei quali in particolare il rock sembra consumare la propria vendetta, in un trionfo di live show, club fumosi e vita spericolata. Storie che pagano un tributo narrativo a un’epopea sgangherata e contraddittoria di sudore e droghe sintetiche, scoperta dei corpi e business, sogni collettivi e incubi metropolitani, ma che prima di tutto sono pensate, scritte e «suonate» come altrettanti brani o album.
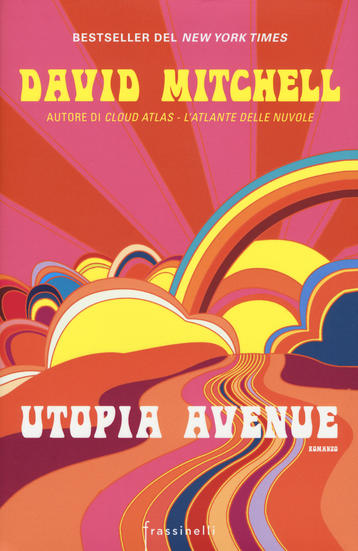
TUTTO È NUOVO, inedito, da scoprire. Londra è un museo a cielo aperto di una generazione che si inventa, costruendo i propri stili e creando i propri consumi. In città si marcia per sostenere la Campagna per il disarmo nucleare, più tardi sarà il «no» alla guerra del Vietnam, ma per i giovani protagonisti la rivolta si è spesso già consumata nella scoperta del sesso, lasciandosi crescere i capelli o abbandonando le famiglie e la provincia per dormire sul divano di un amico o studiare arte nella capitale: una delle fucine per generazioni di musicisti.
IL TITOLO DEL LIBRO, che è anche il nome del gruppo formato dai protagonisti, parla di un orizzonte aperto e pieno di promesse, malgrado l’eroina stia già rimpiazzando lo speed e poi gli acidi nella «scena» londinese. Ma la musica è una promessa di liberazione e la città il suo tempio. «Il Marquee di Wardour Street era un sotterraneo in cui, come in un serbatoio, si riversava una folla di sei o settecento persone. Se qualcuno fosse morto lì dentro, sarebbe rimasto dritto in piedi per via della folla fin dopo mezzanotte. Elf era stata sul punto di vomitare per la paura che l’attanagliava. Gli Utopia Avenue erano i secondi a esibirsi in una serata intitolata “Tutto può succedere”».
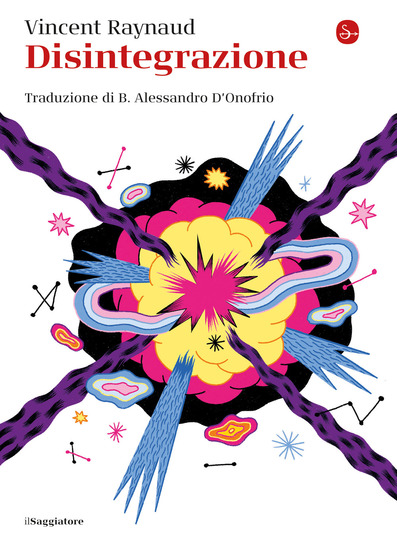
Dieci anni più tardi, a Parigi, della stagione dell’utopia resta ben poco. Tristan, il protagonista di Disintegrazione di Vincent Raynaud (il Saggiatore, pp. 368, euro 24, traduzione di B. Alessandro D’Onofrio) scopre il rock all’insegna del «No Future» del punk. Una famiglia borghese, mezzo tedesca e mezzo veneta, una bella casa al Quartiere Latino, nell’arco di pochi mesi il ragazzo passa dal Conservatorio a suonare la batteria negli scantinati.
L’APPRENDISTATO alla «nuova musica» che arriva, ancora una volta, da Londra, in questo romanzo di formazione punk scritto tutto d’un fiato, passa per i vinili rubati insieme ad un amico alla Fnac di Montparnasse e ascoltati compulsivamente senza quasi lasciare che la puntina abbia il tempo di fermarsi quando a casa non c’è nessuno. Il debutto vero e proprio arriva però con un concerto parigino dei newyorkesi Television, bella musica, un po’ freddina che fa già immaginare cosa verrà dopo: il «post» della generazione senza futuro.
A loro, il protagonista preferisce i Téléphone, una band locale, più sporca e arrabbiata. In ogni caso, l’effetto è determinante per quanto verrà dopo. «Tristan non è altro che due occhi che passano in rassegna il palco per vedere tutto, due orecchie che assorbono con voracità ogni nota, ogni suono, e un corpo che si lascia attraversare da un flusso continuo, non distingue le canzoni, è una corrente che lo trascina e cui non oppone resistenza, riconosce passaggi, serie di accordi, attacchi di fraseggi, un lungo assolo che si innalza come un’onda e s’infrange in un’apoteosi del frastuono». Inutile aggiungere che «non ha mai provato niente del genere». La strada è segnata, e anche per lui arriverà una carriera da rocker di tutto rispetto, riassunta alla fine del romanzo in una discografia (falsa) che si intreccia con quella (vera) dei rimandi impliciti a decine di brani presenti nel testo: da Iggy Pop a Nick Cave.
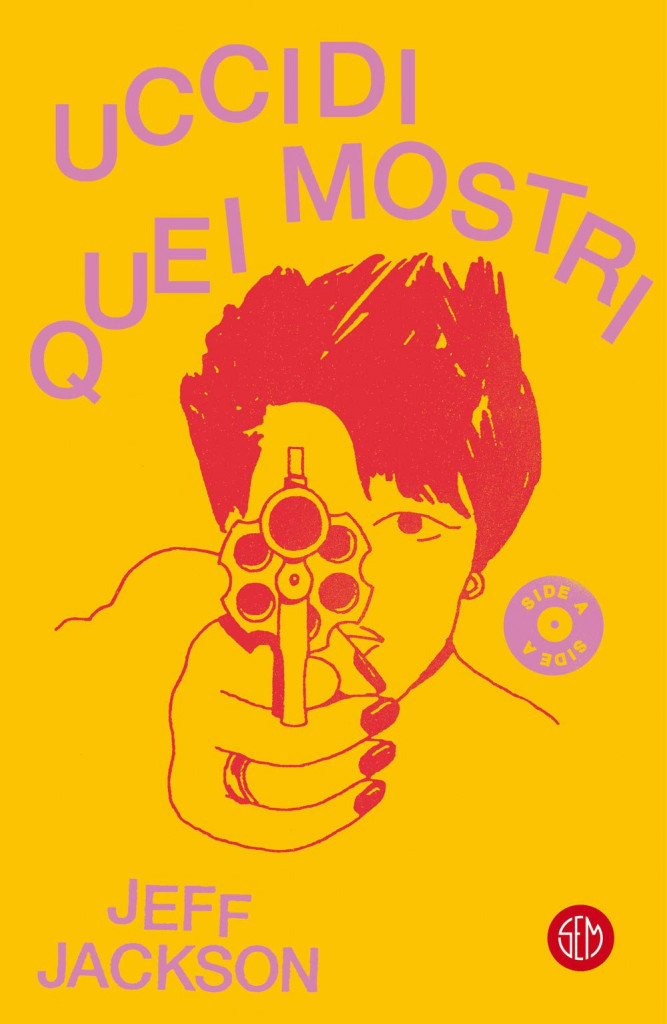
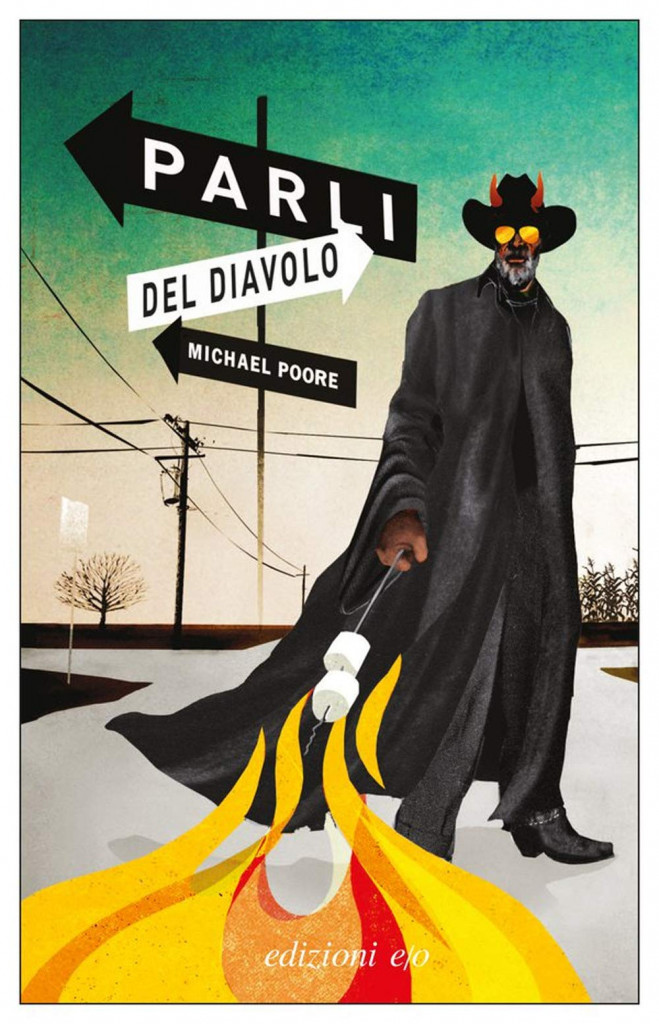
Venduta l’anima (al mercato?) e azzerati stili e tendenze in nome di un unico suono mainstream, la musica sembra tornare così nel territorio del diavolo. Lo sa bene John Scratch, che di professione fa proprio questo: il Diavolo. Dopo aver trovato nell’«esperimento americano» il suo laboratorio privilegiato, seminando invidia e ossessioni tra i Padri Pellegrini, già di loro propensi al fondamentalismo, il protagonista di Parli del Diavolo di Michael Poore (e/o, pp. 410, euro 18, traduzione di Gianluca Fondriest), già autore di Reincarnation Blues (e/o) si comporta come una stella del rock ruffiana e baldanzosa nel tentativo di sedurre Memory, giovane hippie che insegue la gloria come cantante che lui tenterà di condurre con sé in un viaggio che dal deserto californiano muove attraverso gli spazi e i tempi della storia americana.
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento