Tra i poeti milanesi, dove governa la musa Baltramina
Nel parlato milanese La dialettica tra lingua e vernacolo, che non fu mai serrato in un localismo refrattario ai contatti con l’esterno, nei 2 volumi della «Letteratura milanese», curati da Silvia Morgana per Salerno
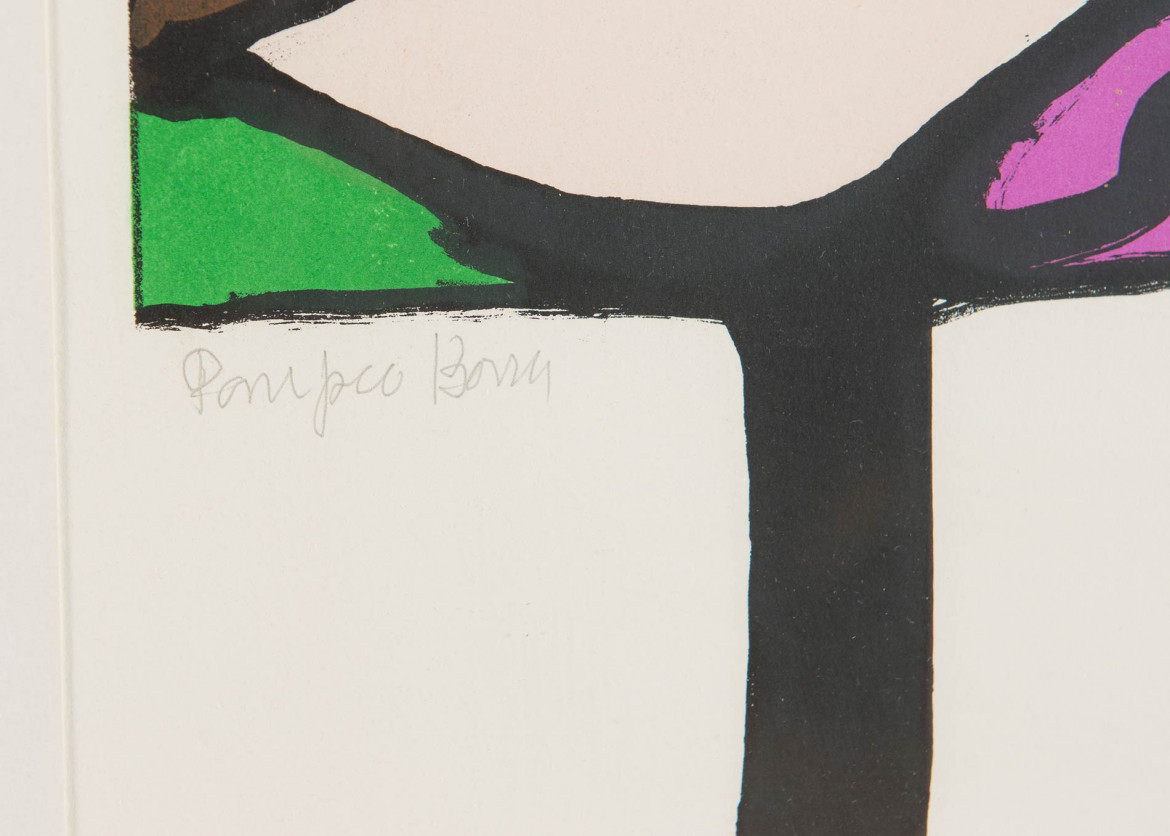 Pompeo Borra, «Composizione»
Pompeo Borra, «Composizione»Nel parlato milanese La dialettica tra lingua e vernacolo, che non fu mai serrato in un localismo refrattario ai contatti con l’esterno, nei 2 volumi della «Letteratura milanese», curati da Silvia Morgana per Salerno
Esiste in quel di Milano una Musa particolare, la musa Baltramina, evocata da Carlo Maria Maggi sul finire del Seicento e ispiratrice di tanti suoi successori, che si diverte a far risuonare l’Elicona di accenti ed espressioni vernacole del capoluogo lombardo. Questa generosa dispensatrice di ispirazione ha fatto fiorire, nei secoli, una ricca e varia letteratura, in prosa ed in poesia, e nei generi più diversi, di cui purtroppo oggi solo pochi, perfino tra gli stessi milanesi, sono consapevoli. Un ampio e approfondito sguardo su questa produzione viene oggi proposto dai due volumi di Letteratura milanese – storia e testi, a cura di Silvia Morgana (Salerno, pp. LXXXIV + 1512, € 250), che abbracciano tutte le fasi di questa importante componente della nostra storia letteraria, antologizzando e illustrando puntualmente nel contesto storico e letterario decine di autori e di opere, a partire dalle prime espressioni di un volgare lombardo fino alle canzoni d’autore del nostro tempo.
Contrariamente al luogo comune che vorrebbe la letteratura in dialetto chiusa in un localismo refrattario ai contatti con l’esterno, emerge dalla lunga introduzione e dalla scelta e disposizione dei brani antologizzati il fatto che la letteratura milanese è sempre stata in rapporto con le correnti letterarie del resto d’Italia e all’occorrenza anche d’oltralpe.
Nel medioevo, le prime opere vernacole si inseriscono nel solco della letteratura religiosa, al cui interno, pur riservando al latino i generi più «alti», assolvevano il compito di divulgare, in una lingua prossima a quella parlata, episodi evangelici, ammonimenti morali, leggende di santi, «contrasti» e racconti edificanti. Emblematica la produzione nelle due lingue di Bonvesin da la Riva: la vivida descrizione dei regni dell’aldilà nel suo Libro delle Tre scritture, (Scrigiura negra, Scrigiura rossa, Scrigiura dorada) sperimenta l’uso del volgare per quel genere «umile» per il quale Dante consacrerà, qualche decennio dopo, il termine «commedia».
Quando poi fiorirono le Accademie, anche Milano ebbe la sua Arcadia, trasposta nella valle (oggi svizzera) di Blenio («Bregn»), e i pastori in cui si identificavano Paolo Lomazzo e gli altri membri della sua Accademia erano gli umili facchini originari di quella vallata.
Grazie alla ricchezza delle note introduttive a ogni sezione di questo autentico corso di storia della letteratura è possibile seguire il rapporto dialettico tra lingua e vernacolo sviluppatosi col progressivo affermarsi del volgare toscano come lingua letteraria della Penisola e destinato ad attraversare, in filigrana, gran parte della produzione letteraria milanese. Questa dicotomia, le cui prime avvisaglie emergono già ai primi del Seicento nelle due opere gemelle del Varon e del Prissian («Varrone» e «Prisciano»), conoscerà fasi di acuta contrapposizione come la «polemica brandana» del 1760 e quella classicista di Pietro Giordani del 1816, ma spesso genererà anche incontri e una feconda emulazione. È noto che Belli intraprese la sua attività dialettale dopo il contatto con le opere di Porta; e d’altra parte le traduzioni e i rifacimenti di opere in lingua sono una costante da parte degli autori milanesi, ora con l’intento esplicito di mettere alla prova le potenzialità del codice linguistico vernacolo, come nel caso della Gerusalemme Liberata «travestita in dialetto milanese» da Domenico Balestrieri, ora invece con intenti bonariamente parodistici, caratterizzati però sempre da una ricerca stilistica che rifugge dalla sguaiataggine del lazzo fine a se stesso. Un esempio per tutti, «i fior, i erb, i piant, i ond, i sass» di Grossi, che rimanda, con eleganza, ai «fior’, frondi, herbe, ombre, antri, onde, aure soavi» di Petrarca.
Di tutta questa letteratura, oggigiorno i non specialisti conoscono perlopiù solo gli esponenti più famosi, Carlo Porta, Tommaso Grossi, Delio Tessa, e forse qualcuno degli «omenoni proppi de spallera» che per Porta costituiscono, insieme al Varon, le vette della letteratura milanese prima di lui: Carlo Maria Maggi, Domenico Balestrieri, Carl’Antonio Tanzi e Giuseppe Parini.
Ma tutto il Settecento e l’Ottocento videro un fiorire di «letterati». Non c’era milanese di buona cultura che non avesse nel cassetto almeno qualche composizione nel suo dialetto. Ora, questa raccolta rende accessibili molte figure poco note, e mai antologizzate, dando anche rilievo a quel genere prettamente milanese che sono le «bosinate», sia anonime, sia d’autore. L’unica voce femminile, quella di Francesca Manzoni, arcade e cofondatrice dei Trasformati, sarebbe stata meno isolata in compagnia di Rosa Massara De Capitani, compresa invece in altre raccolte, ma questa non è l’unica assenza che si noti. La ricchezza della letteratura milanese viene fuori anche dalla qualità degli autori che, pur meritevoli di figurare in un’antologia, hanno dovuto essere sacrificati per ragioni di spazio, nonostante la vastità impressionante dell’opera. E così, per esempio, non ha trovato spazio la voce di Averardo Buschi, autore, tra lo scapigliato e il goliardico, né quella di un «classico» come «La tegnoeura» e di una serie di gustose composizioni in un linguaggio caricaturalmente rustico il cui eroe, «ol Pidrin» è stato poi ripreso da alcuni epigoni tra cui Gaetano Crespi. Per la prosa, relativamente meno rappresentata, vengono in mente le novelle popolari raccolte da Vittorio Imbriani (La novellaja milanese, 1872) o i bozzetti di vita milanese che Camillo Brambilla, caporedattore de La Notte, scrisse negli anni settanta, con lo pseudonimo di Carlo Finestra. Anche nell’innovativo capitolo sulle canzoni d’autore (D’Anzi, Strehler, Fo, Jannacci), non avrebbe sfigurato «la Rita dell’Ortiga» o qualche altro adattamento dei testi di Brassens ad opera di Nanni Svampa. Ma, c’è tempo, come conclude la curatrice, per «un’altra storia, e, forse, una nuova antologia».
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento