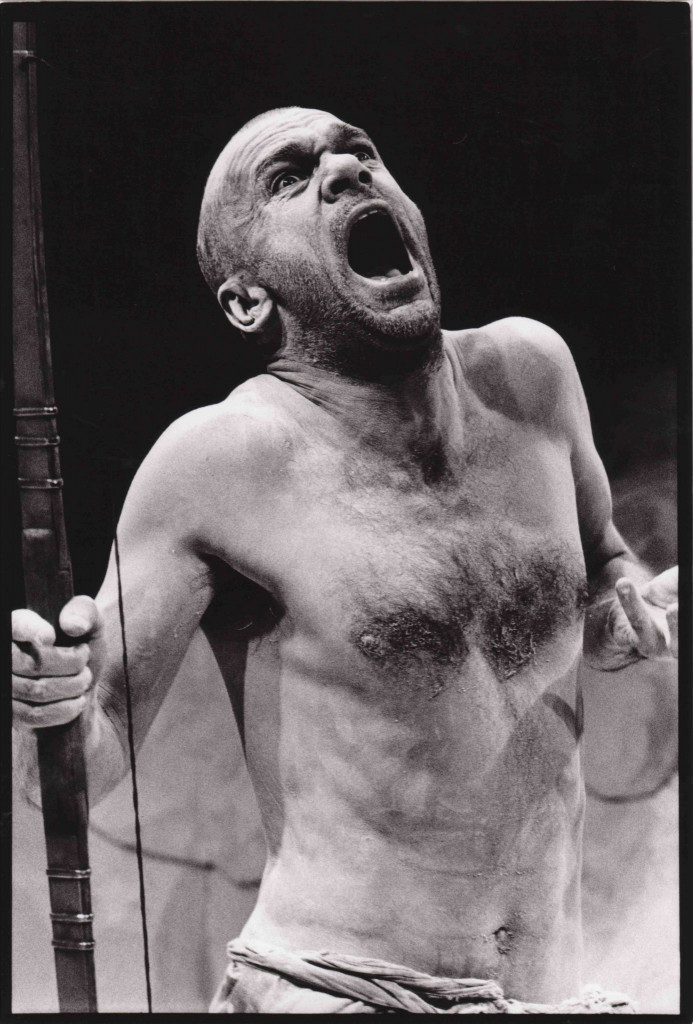
Seamus Heaney traduttore biologico di Sofocle
«L’opera tradotta è intensificata», scrive George Steiner, riflettendo su ciò che accade all’originale dopo la traduzione. Questa affermazione non sarà probabilmente confermata dal filologo, non dalla persona colta che legge con il testo a fronte, non dal lettore che, preso dal suo romanzo russo, è indifferente al fatto di leggerlo in italiano. Un ritorno dialettico all’originale è piuttosto propiziato dalla traduzione letteraria che si presenta nella forma della riscrittura, ma di una riscrittura che non è entrata ancora nella dimensione della libera rielaborazione, proprio come accadeva alle origini di questa pratica, con il vertere dei poeti latini, o più tardi nella lunga stagione dei volgarizzamenti italiani, in particolare in quelli cinquecenteschi, di cui «L’ Eneide di Virgilio del Commendatore Annibal Caro» o «Le Trasformationi di M. Lodovico Dolce» offrono esempi emblematici.
Rientrano in questa tipologia, in buona misura, le traduzioni integrali o parziali che Seamus Heaney ha dato di alcuni testi sofoclei, in un arco di tempo che va dal 1990 al 2004. Ai drammi tradotti integralmente (Filottete; Antigone) è stato imposto un nuovo titolo (The Cure at Troy: A Version of Sophocles’Philoktetes; The Burial at Thebes); agli estratti (dall’Edipo a Colono, vv. 1586-1666; dall’Aiace, vv. 285-330) ne è stato assegnato uno (What Passed at Colonus; Testimony: The Ajax Incident). In tutti questi casi il testo è evidentemente una «versione di» e nel primo lo è anzi in modo dichiarato, anche se proprio qui la libertà nel riscrivere l’originale è massima, per poi progressivamente diminuire negli esperimenti successivi.
Certamente il vertere dei latini, i volgarizzamenti rinascimentali, le traduzioni heaneyane rispondono a domande culturali, di gusto e di mercato, politiche ed etiche sentite come urgenti nei contesti che le hanno generate.
Questo multiforme magnetismo dell’attualità, d’altra parte, basta a spiegare la libertà della traduzione-riscrittura solo se quest’ultima è un’opera caduca, insieme priva di una sua autonomia letteraria e della capacità di riferirsi all’originale, come scrive Steiner, intensificandolo. Nel noto, irresistibile libro-intervista di Dennis O’Driscoll, Stepping Stones («Pietre di guado»), del 2008, Heaney parla con l’arguzia che gli è propria del rischio corso in The Cure at Troy, quando, in un’ode corale senza corrispettivo nel testo di Sofocle, fece comparire il riferimento a scioperi della fame, vedove di poliziotti, cittadini innocenti dietro le sbarre – tutte cose che, dette per filo e per segno per bocca del Coro, facevano un effetto di paternalismo e che tuttavia si lasciavano dimenticare – continua Heaney – perché per fortuna, subito dopo, l’altamente memorabile «hope and history line» si prendeva tutta l’attenzione del pubblico.
Questo verso (l. 1598 «And hope and story rhyme»), che in effetti si è impresso nella mente di alcuni presidenti degli Stati Uniti e di intellettuali e artisti di fama mondiale, ha ispirato il titolo di un volume da poco uscito: Seamus Heaney, Speranza e Storia Le quattro versioni sofoclee (Il Convivio Editore, pp. 187, euro 20,00), a cura di Leonardo Guzzo, Rossella Pretto, Marco Sonzogni e Marcella Zanetti, con una prefazione di Andrea Rodighiero, un’introduzione di Emanuela Zirzotti, una nota all’edizione dello stesso Marco Sonzogni e una postfazione di Rossella Pretto.
Questa complessità è appropriata. La Prefazione e l’Introduzione, tra loro complementari, offrono, la prima, un quadro chiaro e raffinato di ciò che Sofocle ha rappresentato per la mente moderna e la seconda una puntuale, aggiornatissima esposizione critica del percorso di Heaney come poeta-traduttore, in generale e specificamente come traduttore di Sofocle. Viene così consegnato al lettore un senso esatto del modo in cui Heaney ha trovato un punto di equilibrio tra il rispetto dell’originale e l’autonomia poetica di questi testi, dotandoli – per usare una sua nota locuzione – del «diritto biologico a vivere».
Vivere, tra l’altro, come opere che fanno vivere altre opere: per la sua stessa poesia Heaney accetta il principio secondo cui «un’opera originale esiste non per essere perfetta ma per rigenerarsi di continuo in nuove traduzioni».
La Nota di Sonzogni racconta la genesi del volume, momento di un coraggioso progetto che ha gettato luce, in modo sistematico, sulle 101 traduzioni da 14 lingue diverse ora raccolte a sua cura, con introduzione e (preziosissimo) commento, in The Translations of Seamus Heaney, Faber, London (pp. XVIII-685, £ 35).
In Speranza e Storia la mancanza di testo a fronte, è vero, può essere sentita come un difetto; ma se la versione originale fosse stata fornita avrebbe fatto sentire la mancanza di un altro originale, quello greco (e forse anche di un’altra traduzione); inoltre la qualità della versione italiana premia la lettura continua e compiuta del testo. Si tratta, in effetti, di traduzioni pensate più per un pubblico di lettori che di spettatori (al contrario dei testi inglesi), con scelta intelligente, che rinuncia a rendere sistematicamente il colore locale del modello e compensa questa perdita con altri guadagni.
Eccone un esempio. La traduzione del Filottete è dedicata al poeta-traduttore Robert Fitzgerald, che Heaney chiama, in un suo sonetto, «Harvard Nestor», con ciò alludendo al fatto che Fitzgerald gli aveva fatto da mentore in quella università e al ruolo che il ragionare sul testo di Omero aveva avuto nella loro amicizia. Come Miłosz, che Heaney aveva incontrato a Berkeley anni prima, e che l’avrebbe guidato idealmente a tradurre i versi dell’Edipo a Colono, Fitzgerald è per lui una sorta di padre spirituale. Un effetto delle loro conversazioni fu la prefazione che Heaney scrisse nel 1992 all’Odissea tradotta dall’amico; un’altra traccia ben visibile di questa intesa resta nella poesia «In memoriam: Robert Fitzgerald» (in La lanterna di biancospino) dove è evocata la gara con l’arco nel XXI libro, e l’immagine della freccia che attraversa l’anello delle scuri tendendo inesorabilmente verso un centro invisibile prende un significato poetologico.
In The Cure at Troy Odisseo pronuncia un’ampia battuta in cui accetta di rinunciare a condurre a Troia Filottete, che fa resistenza, perché ciò che conta è l’arco e non l’arciere. Nella versione italiana egli si autodescrive così: «ogni volta ho cercato di compiere il mio dovere / adattandomi (…) Il mio primo pensiero è volgere le cose / per il verso giusto» (resa di «My aim has always been to get things done / By being adaptable (…) My main concern is to keep things moving on / In the right direction», ll. 1231-2, 1234-5). Ben più del testo inglese la traduzione italiana induce il lettore che abbia qualche familiarità con l’epica antica a ricordare quell’epiteto di Odisseo, polýtropos, oggetto di discussione già in antico e che Livio Andronico, nella sua traduzione in latino dell’Odissea, rese con versutus.
Poco più avanti si incontra l’accenno di Odisseo alle proprie capacità come arciere (ll. 1240-2), in un passaggio dove la variazione heaneyana del luogo sofocleo si realizza in una inversione dell’ordine delle frasi che incoraggia il ricordo della gara con l’arco. I traduttori italiani hanno dunque incrementato la coerenza interna della versione inglese, intensificandone la risonanza colta («adattandomi… volgere… verso giusto») e consolidando il raccordo del testo con la figura del suo dedicatario.
Ma la figura di maggior interesse per Heaney è Neottolemo. Il dilemma che si pone quando l’appartenenza a una comunità e la fedeltà a se stessi entrano in tensione è un tema senza tempo. Heaney fece la sua scelta mentre si trovava a Berkeley all’inizio degli anni settanta e poteva guardare all’Ulster da lontano; lasciò Belfast, l’università, si spostò in Irlanda, a Glanmore, cominciò così la sua carriera di traduttore e di poeta bucolico.
Questa esperienza personale, vissuta in profondo, assecondando anzitutto l’imperativo della libertà artistica, fece sì, come scrive un critico, che già in The Cure at Troy il piatto della bilancia pendesse dalla parte dell’universale. Questa tendenza, come detto, si incrementa nelle traduzioni successive. Commentando in più di una circostanza la genesi di The Burial at Thebes, Heaney afferma che il tema gli si chiarì quando la protesta di Antigone gli apparve come un gesto di significato antropologico tanto quanto politico; e ci offre un affaccio prezioso sul momento in cui il testo nacque, simultaneamente come traduzione e opera autonoma. Gli era stata richiesta una versione di un dramma classico per il centenario dell’Abbey Theater di Dublino. Non trovava l’intonazione per mettere in parole l’atmosfera di amore e panico del prologo. Mentre era sul punto di scoraggiarsi gli sovvenne l’attacco di un poema irlandese di fine XVIII secolo, «Il lamento per Art O’Leary», un keen che una donna leva sul corpo del marito, ucciso e lasciato insepolto dai soldati inglesi. Nel tempo di un respiro, dice Heaney, ecco i primi tre versi della nuova voce di Antigone, i quali non sortirono da ore al tavolino sul testo di Sofocle ma dall’inatteso insinuarsi nell’udito interiore di parole e ritmi di un’altra opera, moderna e atavica insieme. Trovato così il suono del senso, tutto il progetto prende forma, con l’aiuto di tre traduzioni affidabili, sulla base delle quali soltanto nulla sarebbe nato.
Saggiamente i traduttori italiani rinunciano a riprodurre il ritmo giambico (a partire dai trimetri di Antigone, germinati come detto da quelli di «Caoineadh Airt Uí Laoghaire») che aveva dato a Heaney la sensazione benedetta, sperimentata altre volte, di trovarsi «sul binario giusto». Anche a questo testo, come alla versione del Filottete, egli diede un titolo proprio e narrativo, The Burial at Thebes; e della sua scelta parlò distesamente in una conferenza pronunciata a Harvard nel 2004, intitolata «Title Deeds (“Atti di proprietà”): Translating a Classic».
Le traduzioni che si leggono in Speranza e Storia dimostrano una intelligenza esperta di Heaney e del suo lavoro anzitutto trovando, in un’altra lingua, l’intonazione che dà unità all’insieme; la fluidità e l’organicità stilistica che ne sono derivate hanno prodotto un risultato che il testo a fronte in genere non favorisce, e cioè a lettura ininterrotta, quasi la messa in scena mentale, per poco più di un’ora nel caso del testo più lungo, dell’opera nella sua integrità. Queste traduzioni di traduzioni, d’altra parte, ridanno presenza alla parola di Sofocle. Difficile non essere presi dalla voglia di ritornare a quell’origine; difficile anche che essa ci si ripresenti come era prima.
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento