Perché non possiamo scavalcare le teorie
SCIENZA Big Data e algoritmi ci illudono di poter capire tutto, ma non è così facile. Il «trattamento di dati» alla ricerca di fenomeni ricorrenti non può essere considerato un paradigma
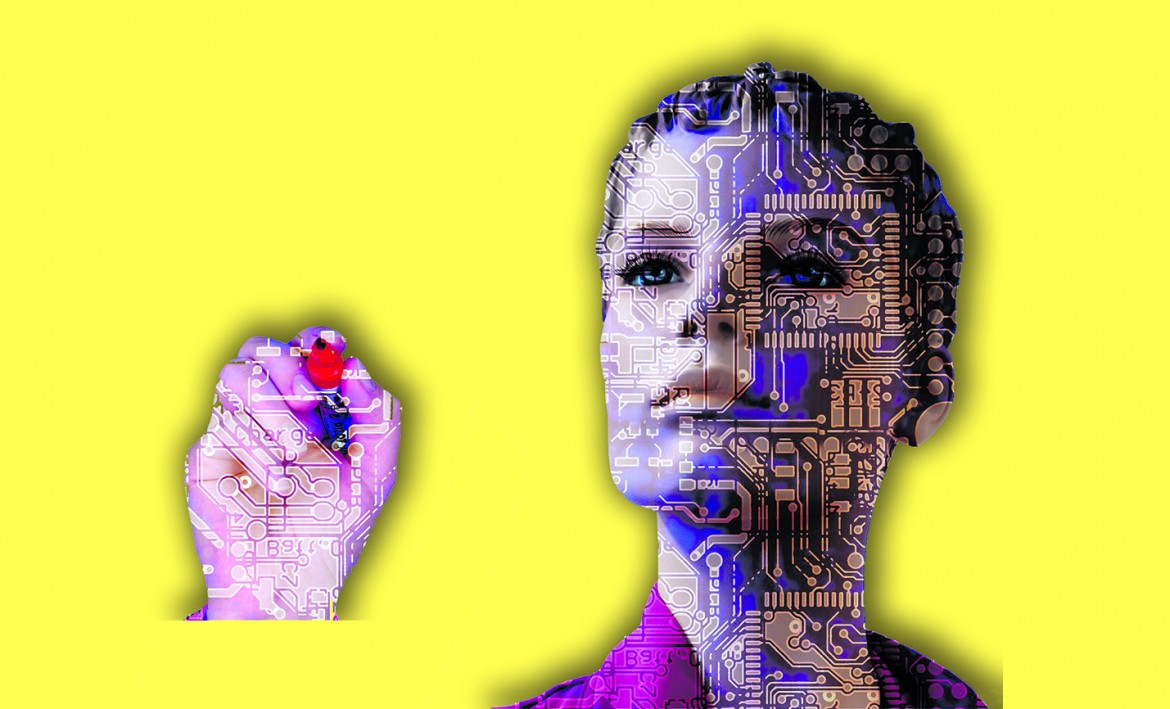
SCIENZA Big Data e algoritmi ci illudono di poter capire tutto, ma non è così facile. Il «trattamento di dati» alla ricerca di fenomeni ricorrenti non può essere considerato un paradigma
Da anni ci sentiamo ripetere che siamo nell’era dei «Big Data» e che quest’abbondanza di informazioni, insieme alla disponibilità di intelligenza artificiale e algoritmi, non potrà che essere una risorsa fondamentale. Sicuramente avere a disposizione una grande mole di informazioni può essere utile: più dati sull’influenza permettono una migliore prevenzione, ad esempio. Ma Big Data e algoritmi fanno nascere una serie di delicati problemi: chi è il proprietario dei nostri dati sanitari? Quale uso possono farne società di assicurazioni, datori di lavoro, tribunali? Possiamo controllare la procedura usata dagli algoritmi che decidono di aspetti importanti della mia vita?
Nel libro di Cathy O’Neil Armi di distruzione matematica (Bompiani, 2016, qui una recensione del volume) si trova un’attenta analisi dell’uso degli algoritmi in ambito sociale. Un esempio: nella contea di Broward, in Florida, un algoritmo aiuta a decidere se una persona accusata di un reato debba essere rilasciata su cauzione prima del processo. Tra i neri, l’algoritmo classifica «ad alto rischio» un numero sproporzionato di individui che però successivamente non commettono nuovi reati. La società che gestisce l’algoritmo sostiene che la metodologia non abbia pregiudizi e che classifica tutti con la stessa accuratezza. Il problema è che ci sono almeno 20 plausibili definizioni di imparzialità, in molti casi mutualmente esclusive. Inoltre, gli algoritmi istruiti dai dati raggiungono una complessità tale che ormai sfugge agli stessi creatori.
SIAMO TANTO SICURI che una descrizione molto dettagliata sia necessariamente positiva? Borges, nel breve racconto «Funes o della memoria» descrisse un personaggio che, in seguito a un incidente, ricordava tutto sin nei minimi dettagli della più comune delle situazioni. Questo, ben lungi dall’essere un vantaggio, comportava la quasi totale incapacità di un pensiero astratto: «infastidiva Funes che il cane delle tre e quattordici (visto di profilo) avesse lo stesso nome del cane delle tre e un quarto (visto di fronte)».
Naturalmente i Big Data hanno un utilità per la ricerca scientifica e anche la politica ha scoperto le loro potenzialità. Il governo italiano, nell’area milanese dell’ex-Expo, intende avviare il progetto «Human Technopole», centrato in gran parte proprio sul trattamento di grandi quantità di dati. È prevista una spesa pari a una percentuale consistente dell’investimento complessivo in ricerca pubblica, come mostra l’accurata analisi dalla senatrice Elena Cattaneo.
Per alcuni, grazie alla disponibilità di informazioni, saremmo di fronte ad una nuova rivoluzione scientifica, con la creazione di un quarto paradigma accanto alle tre metodologie già esistenti: al metodo sperimentale, a quello teorico-matematico e a quello computazionale, si aggiungerebbe ora un nuovo approccio, consistente nel trattamento di dati alla ricerca di fenomeni ricorrenti. Nel 2008 il guru informatico Chris Anderson è arrivato a sostenere, in un articolo provocatoriamente intitolato «La fine della teoria: il diluvio di dati rende obsoleto il metodo scientifico», che ormai «la correlazione è sufficiente» e possiamo smettere di cercare modelli.
SECONDO ALCUNI, come l’autore di L’algoritmo definitivo (Bollati Boringhieri, 2016, qui la recensione del volume) Pedro Domingos, in breve tempo avremo un super-algoritmo che governerà la politica in modo da far declinare la povertà e farci diventare più longevi, felici e produttivi. Ma che una correlazione tra due quantità non dica granché è cosa nota: si potrebbe citare la correlazione tra il numero di pirati e la temperatura media sulla terra, o tra il numero dei divorzi nel Maine e il consumo di margarina negli Usa per accorgersene. Quando si analizzano le cose più in profondità diventa chiaro che un approccio puramente induttivo, basato solo sui Big Data, non può che fallire se si cerca di fare previsioni.
Infatti, per prevedere l’evoluzione futura di un sistema si potrebbe cercare nel passato una situazione «vicina» a quella di oggi. Se la si trovasse al giorno 25 gennaio 1923, ad esempio, ci si potrebbe aspettare che domani il sistema si comporti in modo simile a quanto fece il 26 gennaio 1923. Sembrerebbe tutto facile, in particolare nell’era dei Big Data, e potremmo non perdere tempo con la teoria. Ma quanto indietro si deve andare per trovare un simile giorno? Secondo un noto risultato matematico dovuto a Henri Poincarè, il tempo dipende esponenzialmente dal numero minimo N di variabili necessarie per descrivere il problema. Se con N=1 per trovare uno stato simile con una certa precisione bastano cento dati, allora per N=2 ne servono diecimila e già per N=6 ce ne vogliono mille miliardi. Questa «maledizione esponenziale» non permette di farsi illusioni se il sistema non è troppo semplice. La filosofia su cui si basa l’approccio Big Data sembra dimenticare il fatto che quasi mai la scienza avanza per accumulo di dati, bensì per la capacità di eliminare gli aspetti secondari (quel «difalcare gli impedimenti» di Galileo). E ovviamente non è così facile.
DUNQUE, non convince la retorica su una presunta rivoluzione di cui finora, nonostante le dichiarazioni enfatiche, almeno nella ricerca di base non c’è traccia. L’idea di usare dati e algoritmi per fondare una scienza senza basi teoriche sembra in linea, in maniera allarmante, con la visione pragmatica ormai imperante negli atenei italiani e stranieri, in cui si privilegiano aspetti con finalità immediatamente pratiche a scapito di una solida formazione di base e soprattutto della possibilità di sviluppare senso critico. Ben vengano i «Big Data» e l’intelligenza artificiale, ma non illudiamoci troppo di fare scienza, almeno quella interessante, in maniera automatica: dobbiamo rassegnarci a studiare e farci venire qualche buona idea.
*
NOTIZIARIO
Baby scienziati

***
Prime passeggiate spaziali tra donne

***
Piantare alberi non è sempre una buona idea

I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento