Norman Manea e la lingua madre della libertà
Intervista La pagina bianca da riempire è un gesto di sfida ai regimi «totalitari» e a chi semina morte in nome di un bene superiore trascendentale. Parla lo scrittore rumeno per l’uscita del libro «Varianti di un autoritratto» (Saggiatore)
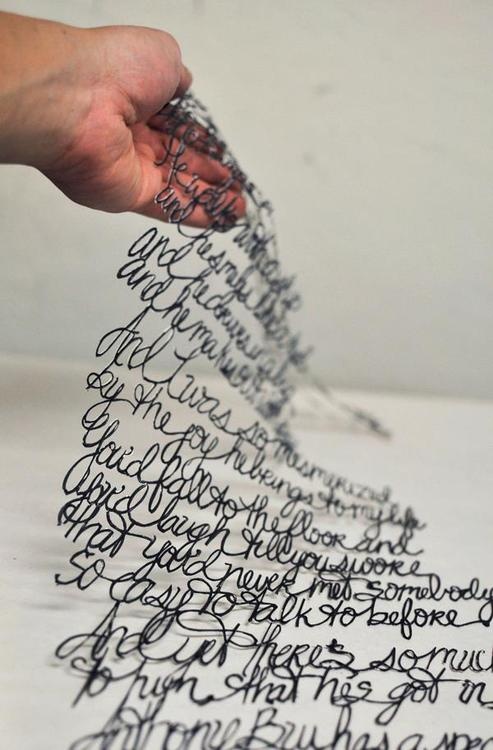 /var/www/ilmanifesto/data/wordpress/wp content/uploads/2015/02/04/05cult55d660829a6bb0dde3f317f4c70c5104 – Archivio manifesto
/var/www/ilmanifesto/data/wordpress/wp content/uploads/2015/02/04/05cult55d660829a6bb0dde3f317f4c70c5104 – Archivio manifestoIntervista La pagina bianca da riempire è un gesto di sfida ai regimi «totalitari» e a chi semina morte in nome di un bene superiore trascendentale. Parla lo scrittore rumeno per l’uscita del libro «Varianti di un autoritratto» (Saggiatore)
«In principio era la parola – ci dicono gli antichi. Per me la parola del principio fu romena». Nato in Bucovina nel 1936, in una regione al tempo fortemente animata dal plurilinguismo (romeno, yiddish, ucraino, polacco, lo slavo dei ruteni e poi il francese dei commerci e il tedesco delle élites), gli anni dell’infanzia – cinque, dall’ottobre del 1941 all’aprile del 1945 – trascorsi in un campo di concentramento in Transnistria, Norman Manea inizia così la propria riflessione su quella che ama chiamare la «lingua nomade», la «lingua domicilio», la «lingua placenta». Questa lingua nomade, domicilio e placenta per lui era e continua a essere il romeno.
Persino oggi che – dopo gli anni durissimi del regime passati tra la scrittura, lo studio notturno e l’attività di ingegnere – vive a New York, dove si è trasferito nel 1988 e insegna in una piccola, ma famosa università privata, il Bard College. Per Manea esiste un’invariante, «qualcosa di insanabile, come fosse il nucleo della propria anima e questo nucleo è la lingua». La lingua romena. In romeno Manea continua a scrivere i suoi romanzi – l’ultimo, Vizuina, apparso nel 2011 per Il Saggiatore, nella traduzione di Marco Cugno, con il titolo Rifugio magico – e i suoi racconti. Proprio un libro di racconti, edito sempre dal Saggiatore e tradotti dallo stesso Cugno e da Anita Natascia Bernacchia, Varianti di un atutoritratto (pp. 282, euro 19), è l’ultima fatica di Manea arrivata in libreria.
Lo incontriamo a Milano.
Nel suo ultimo libro, un racconto di poche pagine, tra i più duri e toccanti, ci porta fin dal titolo – «Il tè di Proust» – sul terreno del ricordo e del radicamento delle ombre nella memoria. In una sala, dove si aspetta un treno che tarda a arrivare, dove l’ennesimo smistamento divide gli abili e gli inabili al lavoro, davanti agli occhi di un bambino ha luogo una piccola cerimonia, «impossibile ma reale». È quasi un’iniziazione al ricordo: un’infermiera della croce rossa offre tè e biscotti. Si apre così il gioco della memoria. Un gioco dove la posta è l’esperienza del tempo o, per meglio dire, di una verità che si dispiega, si nasconde, riaffiora nel tempo.
In quel racconto entra in scena una madeleine. Entra in scena in condizioni storiche mutate, ovviamente, rispetto a quelle vissute da Marcel Proust nel celebre episodio della Recherche. Siamo tutti feriti dalla storia, ma siamo feriti in maniere diverse. Proust possedeva una sensibilità unica, colpita dalla vita quotidiana, dalla banalità di ogni giorno. Ma le cose mutano quando si è feriti da avvenimenti tragici della storia. La sensibilità del ragazzino al cuore del mio racconto è una sensibilità educata dalla catastrofe. Vive nel pericolo, nell’incertezza, ha pochi anni ma ha già fatto esperienza della precarietà estrema. In queste mutate condizioni, dove la fame, la disperazione, la paura e la morte premono, appare un principio di ricordo. Un’epifania, chiamiamola così. Impara così a proteggere il ricordo, senza paralizzarlo. Lo assapora come il biscotto che gli viene dato col tè. Forse, come scrivo nel racconto, le anime di coloro che abbiamo perduto vanno a nascondersi nelle cose inanimate. E il tempo non si dà ordine, nella memoria. Affiora e riaffiora nelle sensazioni, come in blocchi di passato inerte che irrompono alle nostre spalle.
È stato ancora Proust a ribadire che i grandi libri sono sempre scritti in una sorta di lingua straniera. Proprio quando crediamo di averli compresi, sfuggono. E quando sfuggono è forse solo lì, che ci approssimiamo a comprenderli. Per lei questa lingua straniera coincide più che mai con la lingua romena…
La lingua e la letteratura erano per me un rifugio dalla banalità quotidiana. Meglio: erano una vera protezione. La sola che avevo, in Romania, quando sono tornato dal campo di detenzione e ho cominciato a leggere, a studiare, a scrivere. Mi sono costruito una fortezza, dove poter coltivare qualcosa che non sapesse di stereotipo. Ho edificato muri molto spessi, che la censura non poteva abbattere o la polizia segreta attraversare. Nella mia stanza ero solo. Solo con la mia pagina bianca. Non dico che quelle pareti fossero totalmente impenetrabili. Nulla è impenetrabile, dinanzi a una forza che prevarica. Questo è precisamente il senso dell’aggettivo «totalitario». Ma anche nella totalità, dentro quello spazio chiuso, davanti a quel bianco si potevano elaborare linee di strategia e di fuga. Non per fuggire tatticamente e fisicamente, ma per ridare valore e senso alla vita attraverso la parola e la lingua. Fuori da queste linee, un’altra lingua cominciava infatti a prevalere: era la langue de bois, la lingua di legno dello Stato e dei suoi funzionari. Quella che in qualche modo bisognava aggirare era l’onnipervasività saturante del vuoto. Borges diceva che la censura è madre della metafora. Aggiungerei che è madre delle sfumature, del non detto, dei trucchi, dei piccoli segni deflagranti che talvolta potevano apparire innocui chi non sapeva leggere tra le righe. La letteratura, allora, era chiamata a svolgere anche una funzione che altri – i giornali, ad esempio – non erano più in grado di svolgere. Quando viviamo immersi in un ambiente totalitario, dove la lingua viene prosciugata, insterilita, conservare la lingua, custodirla, è un gesto clandestino, spesso condotto in solitudine, ma nella convinzione che non si è soli e, dall’altra parte del muro, qualcuno che non è un delatore o un censore saprà ascoltarti. La lingua custodisce l’umano, proprio nel punto in cui il potere mira a soffocarlo.
Nel 1979, lei affronta il suo primo viaggio fuori dalla Romania, ma decide di tornare. Il paese lo lascerà definitivamente solo nel 1986, poco dopo aver dato alle stampe «Plicul negro» («La busta nera»).
Nel 1979, la parola «Patria» significava per me la lingua in cui sono nato. E la lingua in cui sono nato è il romeno. Potremmo chiamare questa lingua madre una lingua placenta. Come una placenta ci alimenta e da noi, per osmosi, è alimentata. Ricordo che quando sono stato forzato a emigrare, perché le condizioni erano divenute oramai insostenibili, non avevo soldi, non avevo niente. Rischiavo allora di perdere anche la mia lingua. Cioran è diventato un maestro della lingua francese. A che prezzo?
Fuori dalla Romania, mi accorsi così che la mia unica ricchezza, ossia la lingua, era diventata bruscamente inutile. Attorno a me tutti parlavano inglese. Ero sordo, ero muto, ero in una condizione di mutilazione quotidiana. Anche qui serviva una strategia e, soprattutto, una linea di fuga. Superate le prime difficolta e imparato ciò che mi serviva per districarmi tra le faccende quotidiane, mi accorsi che una volta fuori, una volta andato in esilio intendo, la lingua dentro ti segue. Pragmaticamente – in questo mondo che si illude di vivere solo di traffici e commerci – la chiameremmo «inutilità», ma spiritualmente questa la chiamiamo «ricchezza interiore». Quando ti trovi in esilio, ti accorgi che sei tu a doverla custodire, questa ricchezza, non è soltanto lei a custodire te. Te la porti addosso, non solo dentro, questa lingua, come una conchiglia. La lingua della ricchezza interiore e della letteratura diventa pienamente una componente spirituale. Parli in inglese quando vai per strada, quando insegni, ma poi, se devi scrivere, pensare, è sempre alla madre che torni. Questo, però, non significa che non affiorino altre parole, di altre lingue. Questo non significa che la lingua nel suo complesso non sia sempre pronta a prenderci alle spalle. Oggi vivo a New York, una città che chiamo la «capitale Dada» dell’esilio. Sono in quello che molti considerano il centro del mondo. In un mondo, però, che non ha più un centro.
Di questo mondo senza centro, ma pieno di nicchie, lei fa cenno in quello che, a oggi, è il suo ultimo romanzo, «Vizuina» («Rifugio magico»). In questo romanzo, dove in controluce si vedono le figure di Mircea Eliade e Ioan P. Culiano, l’equilibrio di una vita mai perfettamente integrata, mai perfettamente dissociata, è rotto da una dura riflessione sugli attentati dell’11/9…
Dinanzi all’attentato alla Twin Towers, uno di questi intellettuali parla di un grave errore commesso dagli attentatori. Se lo scopo era colpire al cuore una civiltà, bisognava colpire le biblioteche. I santuari del commercio e della finanza sono un aspetto esteriore. Ma nella biblioteca c’è il cuore, perché là c’è tutto, anche sul commercio, anche sulla finanza, anche sulla letteratura, anche sull’arte. Là dentro si trova il codice della civiltà, la sua lingua, la sua matrice. Se lo scopo è distruggere il nostro mondo – questo il ragionamento che uno dei protagonisti svolge nel romanzo – allora bisogna distruggere le biblioteche che sono uno degli ultimi centri spirituali della nostra epoca.
Poche settimane fa abbiamo assistito a un altro attacco, stavolta alla redazione di un settimanale satirico, in Francia…
Difficile parlarne ad appena tre settimane, perché l’attentato parigino ha cambiato bruscamente l’atmosfera. Ha buttato al centro della scena globale una rivista che non era conosciuta ai più e ha di fatto creato un evento – sia detto con tutto il rispetto per le vittime e la più ferma condanna per qualunque atto di violenza. Sul terreno dei fatti parigini si è creato un evento che non ha prodotto molta riflessione, ma grande reazione.
Un evento senza lingua che lo nomini, lo affronti, ne discuta, se ne faccia letteralmente e coscientemente carico… Come se mancasse un filtro e la mediazione fosse diventata unicamente, nel senso etimologico, pornografica: sovraespone l’evento, saturando ogni spazio di reattività non emotiva…
Sospendiamo la riflessione su cose appena successe e concentriamoci sul cambio di atmosfera che, per esempio, ha toccato il discorso delle fedi. Parlarne in forma unicamente derisoria o banalmente ateista è davvero una strada per capire? Io che non sono religioso posso anche provare a pensare che la religione per tante persone sia un modo per uscire dalla frivolezza e dalla banalità. La modernità è sottoposta a numerosi attacchi. Ma non solo dall’esterno, anche all’interno abbiamo pressioni. Ma nascondere le disuguaglianze economiche, le nuove e le vecchie povertà, il debito infinito dietro la maschera dello scontro di civiltà è la strada più comoda. La Grecia non ce la fa? Affondiamola nel debito, ci viene detto. Ma se guardassimo alla vera ricchezza, quella delle biblioteche ad esempio, scopriremmo che in Grecia si traducono tanti libri quanti se ne traducono negli Stati Uniti. Dove sta la ricchezza spirituale e culturale, allora? Nella piccola Grecia che traduce tanto o nei grandi States che traducono poco? La traduzione ci interroga sulle differenze, sull’altro – ricordiamocelo. E chi si sta indebitando davvero, allora, sul piano culturale, corrodendo le proprie riserve di ricchezza, i propri rifugi? Dovremmo ripartire da qui, dall’equilibro, come ebbe a scrivere Lev Sestov, fra Atene e Gerusalemme.
ABBONAMENTI
Passa dalla parte del torto.
Sostieni l’informazione libera e senza padroni.
Leggi senza limiti il manifesto su sito e app in anteprima dalla mezzanotte. E tutti i servizi della membership sono inclusi.
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento

