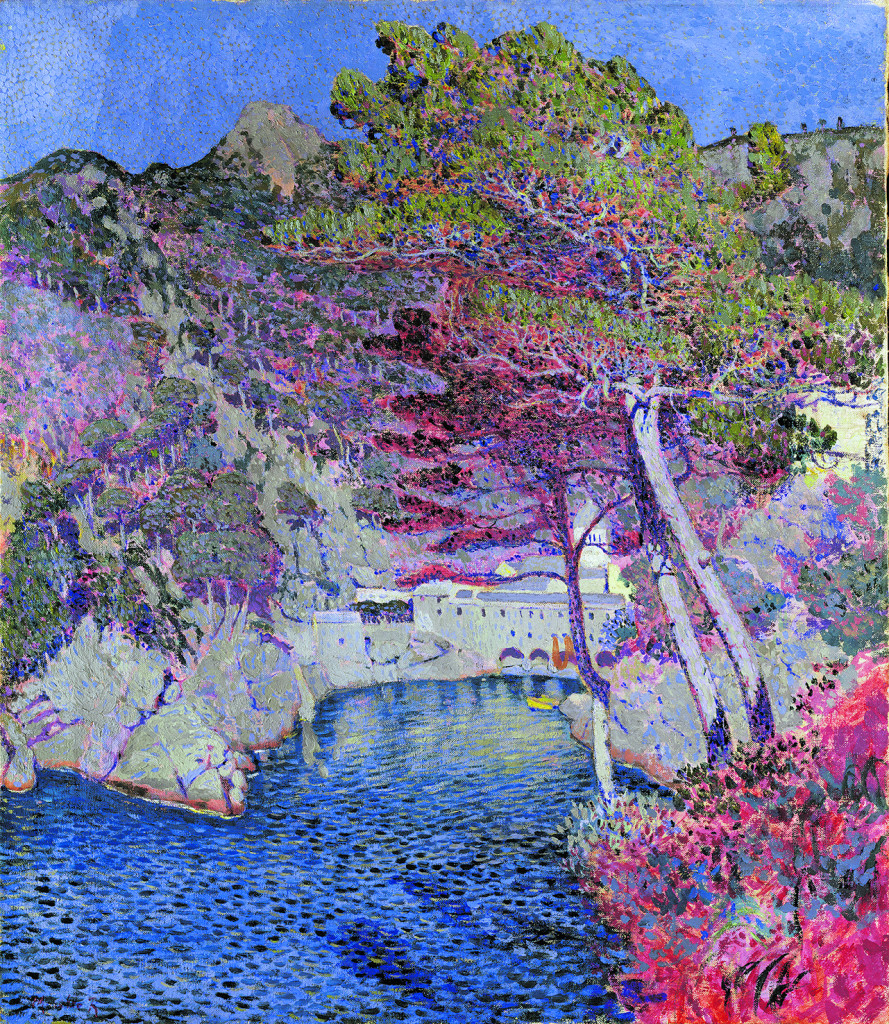
Montale, la poesia è merce da vendere imballata con l’etichetta ‘fragile’
A chi lo ha incontrato o lo ha ascoltato in qualche occasione – un convegno, una lezione, un semplice dialogo – può essere successo di sentir ripetere a Luigi Blasucci un adagio cui era, credo, piuttosto affezionato: «conosco le poesie, non la Poesia». Quell’adagio suonava come una professione di concretezza, di lontananza dal regime fumoso della teoria; e conteneva, anzitutto, l’esigenza di una apparentemente frugale ma profonda familiarità con i testi, con un linguaggio ben individuato, diciamo pure incarnato.
Ciò non impedisce al lettore di Blasucci di avvertire, qua e là, la rivendicazione implicita di una differenza, in qualche modo di una priorità, e persino delle capacità un po’ magiche, di ciò che chiamiamo «poesia». È quello che lui stesso – in alcune pagine che non sono le più note né le più impegnative fra quelle dedicate al suo autore, Giacomo Leopardi – ha chiamato lo «spazio specifico» della scrittura poetica: proprio in quello «spazio», Blasucci teneva a riconoscere incontestabilmente, insieme all’irrinunciabile grana conoscitiva legata al fatto poetico, lo spessore di un gesto pieno di vita.
Che si tratti della lirica di Leopardi o di quella di Eugenio Montale, resta la sensazione che la «differenza» della scrittura poetica sia un’ottima bussola per orientarsi fra le pieghe del lavoro critico di Blasucci, un punto di riferimento anche per attraversare questi suoi Nuovi studi montaliani, a cura e con una postfazione di Niccolò Scaffai (Edizioni della Normale, pp. 125, € 20,00).
Se si prende per esempio la seconda e ultima parte del volume – che ospita dapprima un saggio su Gianfranco Contini studioso di Montale, e poi un intervento riguardante la lettura in classe e il commento scolastico del testo poetico – si incontra un Blasucci impegnato a distinguere e a puntualizzare proprio nei confronti del Contini montalista.
Mentre questi ritiene – sulla scia di Benedetto Croce – che nella lirica di Montale i momenti di più radicale negatività siano precisamente i suoi momenti di ‘non poesia’, di ingombro e appesantimento intellettualistico, Blasucci non può non difendere, al contrario, una sorta di connaturata positività dello scrivere versi. Ascoltiamolo: «Quello di cui Contini, dunque, sembra non voler tener conto, è che la poesia “di per sé”, in quanto vitale atto espressivo, si realizza oltre ogni contenuto negativo».
A colpire è soprattutto quel carattere di per sé, quel tratto intrinsecamente affermativo della scrittura poetica, che trascende ogni negazione, ogni inclinazione nichilistica (in questo, detto per inciso, Blasucci appare molto fedele alle parole dell’Intervista immaginaria, datata 1946, nel quale la poesia è riconosciuta essenzialmente come «una delle tante possibili positività della vita» proprio da quel Montale che viene troppo sbrigativamente liquidato con l’etichetta di poeta del “male di vivere”, facendo perno su un suo citabilissimo verso).

Questi studi montaliani raccolgono tutti gli scritti dedicati da Blasucci al poeta ligure dopo il suo libro del 2002, Gli oggetti di Montale (il Mulino). Cinque capitoli su sette si presentano come l’analisi di una sola lirica: si va da un ‘osso’ come Spesso il male di vivere ho incontrato – proprio lui – fino all’autoritratto affidato da Montale a L’educazione intellettuale (l’esordio del suo sesto libro poetico, il Quaderno di quattro anni).
L’escursione cronologica dei morceaux scelti – dal 1925 al 1977 – dice molto dell’intensità del rapporto che lega Blasucci a Montale. E se è vero, come scrive Scaffai nella bella postfazione che chiude il volume – impeccabile nel restituire la fenomenologia di uno stile critico – che in Blasucci c’è una sorta di attenzione innata alla «tenuta storica dei suoi autori», allora è ancor più significativo che in questo libro il Montale tardo non solo non sia escluso, ma la faccia anzi da padrone assoluto: come a dire che anche dopo Satura, con il suo inconfondibile cambio di tono, Montale è un valore sicuro, un poeta da seguire comunque, come una stella fissa. E non è cosa che Blasucci abbia troppa voglia né bisogno di discutere: semplicemente, la testimonia, regalando ai lettori, una volta di più, un sincero esercizio di abnegazione.
Non è affatto trascurabile, al contempo, che Blasucci confidi ancora, così generosamente, nel genere della ‘lettura’ del singolo testo. «Poesie come persone», avrebbe detto un altro poeta, Vittorio Sereni: ciascuna vale un’esperienza umana, oltre che un’avventura conoscitiva. Una conferma in tal senso – oltre che la rassicurazione sulla durata di un’arte non più così al sicuro, quella dell’explication de texte – viene da un altro «esercizio» montaliano, l’analisi che Ida Campeggiani offre ora in Montale: La primavera hitleriana (Carocci editore «Bussole», pp. 111, € 13,00).
Anche in questo caso, sotto la lente di un’interprete tutta attaccata alla sua preda, la poesia montaliana riesce a rivelarsi «spazio specifico»: linguaggio che dialoga fittamente con la realtà, ma che ha poi tutto il diritto – e forse la necessità – di staccarsi da quello stesso dato reale. È ciò che la disamina di Campeggiani mostra perfettamente, cominciando intanto, con spirito di servizio, dalla parafrasi: il primo vero «problema interpretativo», come lo si definisce qui, posto da una delle liriche più complesse del terzo libro montaliano, La bufera e altro (del quale Campeggiani ha peraltro allestito l’intero commento mondadoriano nel 2019, insieme allo stesso Scaffai); poi passando al setaccio l’impianto stilistico-formale della lirica, nonché il suo contesto e i legami della stessa Primavera hitleriana con altri testi (e momenti) dell’universo montaliano.
Ne esce, una volta di più, un poeta che è difficile cogliere in flagrante: con il quale, fuor di metafora, è sempre complicato capire quali dati siano stati manomessi per volontà d’autore e quali si alterino, invece, per semplice difetto di memoria. Così la visita di Hitler a Firenze, che è l’occasione-spinta della lirica in questione, si mescola nella ricostruzione offerta – nella quale Campeggiani indossa i panni di una sensibilissima detective – anche alla precedente tappa veneziana dello stesso Führer, quattro anni prima di quel maggio 1938 da cui prende avvio la lirica della Bufera.
Ed è importante, fra il resto, il nesso che Campeggiani istituisce di volta in volta fra la Primavera hitleriana e Nuove stanze, o il mottetto della gondola, o la Ballata scritta in una clinica. Si può dire che la sua prima virtù sia la mobilità, ovvero l’incapacità di accontentarsi di una visione frontale: il testo, fra le sue mani, è dentro un dinamismo continuo, è un corpo sempre vivente. Anche per questo Campeggiani può scrivere che la scrittura montaliana corrisponde sempre «a una verità poetica, non biografica», e che, nei suoi versi, «la rappresentatività surclassa, almeno a posteriori, l’aspetto documentario»: ed ecco nuovamente rispuntare, per altre vie, la qualità della poesia come discorso altro, che non può essere addomesticato – o peggio spiegato – confrontandolo piattamente con la biografia: un bene da trattare, insomma, con delicatezza.
È stato lo stesso Montale, del resto, a parlare della poesia come di «una di quelle merci che si vendono imballate con l’iscrizione “fragile”». La si legge, questa frase, in una splendida recensione alla Beltà di Andrea Zanzotto, inserita fra i saggi raccolti in Sulla poesia (Mondadori «Lo Specchio», pp. 612, € 25,00), stampato in prima battuta nel 1976 e ormai da tempo introvabile: interventi che ripercorrono alcuni fra gli snodi decisivi del secolo – dalla Terra desolata di Eliot agli Strumenti umani di Sereni – e che hanno senz’altro la qualità di puntare all’essenziale, di indicare con agile sicurezza il segreto di una raccolta, di un’immagine, di un’intera esperienza poetica. Ogni grande poeta, dopo Baudelaire, contiene un grande critico: ma non tutti mantengono quella «postura leggera» in cui Campeggiani ravvisa, molto persuasivamente, una delle qualità decisive della saggistica montaliana.
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento