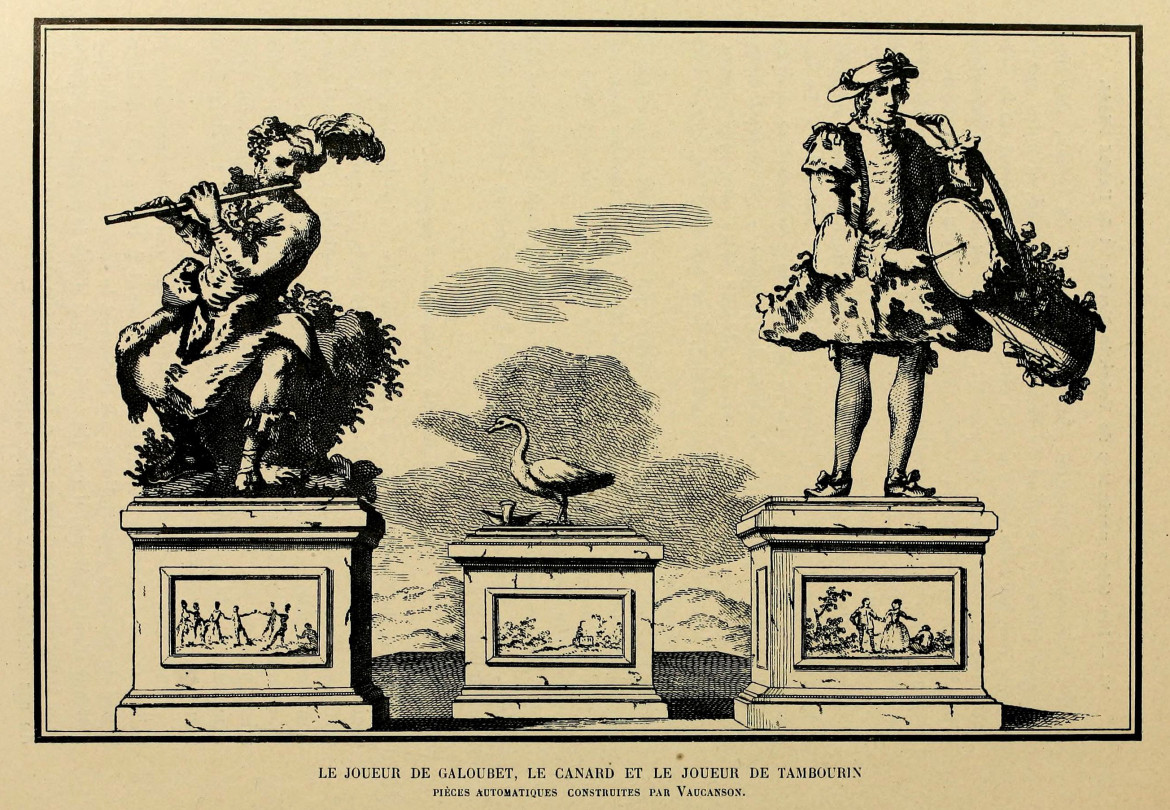
Ma per Lotman il culturale non è l’attuale
Lotman, il maestro della semiotica Pittura, teatro, balletto, cinema: il metodo semiotico applicato alla grammatica delle arti in Il girotondo delle Muse da Bompiani
Il girotondo delle Muse: così Silvia Burini intitola la raccolta, da lei curata, di saggi lotmaniani sulla semiotica delle arti – l’immagine (pittura e arti figurative), la scena (teatro e arti performative), lo spazio (architettura e ambiente urbano). Si tratta di un volume importante nel panorama italiano e internazionale non soltanto degli studi di semiotica e semiologia, ma altrettanto dei Visual Studies nonché degli studi comparatistici e di teoria della letteratura, per un’articolata serie di ragioni che è fondamentale illustrare qui al lettore (Jurij M. Lotman, Il girotondo delle Muse, traduzioni di Daniela Almansi, Silvia Burini, Patrizia Deotto, Emilio Mari, Alessandro Niero, Bompiani «Campo aperto», pp. 489, euro 35,00).
Innanzitutto la ragione storico-editoriale: quest’opera è la nuova edizione, notevolmente accresciuta e riveduta, del libro che, con lo stesso titolo, apparve nel 1998 per Moretti & Vitali, prefato da Cesare Segre. Se è vero che, allora, il volume e la sua proposta teorica si distinsero e attrassero, ad esempio, l’attenzione della prestigiosa scuola semiologica pavese, di Segre e di Maria Corti, oggi, l’edizione Bompiani – in occasione, per altro, del centenario della nascita di Lotman – ne assicurano l’adeguata e la rinnovata, ma soprattutto la necessaria circolazione: Il girotondo delle Muse è infatti un’opera che esiste solo in italiano e riunisce testi alcuni dei quali mai precedentemente tradotti nella nostra lingua (uno di essi, La serie grafica. Racconto e anti-racconto, è inedito anche in russo). L’idea che informa questa raccolta di saggi consiste nel restituire e ricostruire l’apertura à tous les vents del metodo semiotico lotmaniano: la sua presa, cioè, su tutti i linguaggi del fare artistico, con una ricaduta molto rilevante sugli studi teorico-letterari.
La seconda ragione è di carattere specificamente scientifico. Nella sua efficace introduzione, Silvia Burini sottolinea giustamente la distratta accoglienza riservata dalla Scholarship internazionale agli interventi di Jurij Lotman sulla grammatica della costruzione visuale (dalla pittura all’emblema all’illustrazione), sulla morfologia della rappresentazione scenica (tra teatro, balletto, festa, storia del costume per giungere al linguaggio cinematografico) e sull’ordine simbolico dello spazio architettonico e urbano, un vero e proprio caso di méconnaissance che ha marginalizzato, se non escluso, il nome di Lotman nella e dalla genealogia dei Visual Studies e quindi dei Visual Culture Studies che ne discendono. È un fatto: tanto nel panorama internazionale quanto in quello italiano, la disciplina o, meglio, l’inter-disciplina del visuale che oggi chiamiamo Visual Culture non passa attraverso Lotman e la semiotica, ma piuttosto attraverso la post-semiotica culturalista di Mitchell (riconosciuto maître à penser del cosiddetto Pictorial Turn), la quale, come giustamente rilevò a suo tempo Gottfried Boehm, trasferisce l’attenzione sull’impatto sociale dell’immagine, sconfinando, di fatto, in una critica della sfera pubblica (come chiamarla altrimenti?) di derivazione foucaultiana e francofortese (la Frankfurter Schule), nutrita, fra i plurimi ed eclettici apporti metodologici da cui attinge, di retorica decostruttivista derridiana e di rapsodismo lacaniano – si tratta soprattutto del Mitchell di What do pictures want (2005) e dei saggi successivi. La comparatistica italiana, ad esempio, ha recepito il problema del visuale in questa prospettiva.
Ben altra cosa era il rapporto tra testo verbo-visivo e cultura, tra testo e extratesto, nel pensiero di Lotman: la relazione tra cultura e arte è per Lotman costantemente misurata sul filo della teoresi (cioè sul filo del processo di transcodificazione e sull’intreccio dei movimenti di transcodificazione) e non della fenomenologia sociale, soprattutto se quest’ultima risulti intesa (come in e da Mitchell) al modo di un accumulo esperienziale au jour le jour schiacciato sull’attualità. In altri termini, la semiosfera di Lotman è un sistema-ambiente di regole, un sistema certamente non rigido – perché il semiotico lotmaniano mira alla trasformazione, non alla struttura inalterabile – ma pur sempre un sistema di regole dove il sociale non è automaticamente legittimato nel e dal suo semplice porsi (o essere posto) come «fenomeno», perché, dal punto di vista semiotico, il culturale non è l’attuale: non tutto il fenomenico è segnicamente e semanticamente annotabile (e annotato) – e, quando e se lo è, allora diventa testo. Silvia Burini rileva, a tal proposito, quello che pare essere a tutti gli effetti o un equivoco o un vuoto teorico mitchelliano intorno alla nozione di testualità, che è il nodo teorico dirimente dell’intera questione: «Il punto più rilevante [dell’indagine di Mitchell, n.d.a.] è quello in cui egli afferma che “l’esperienza visiva o l’alfabetizzazione visuale potrebbe non essere completamente interpretabile sul modello della testualità”. A quale modello di testualità fa riferimento? Se Mitchell avesse tenuto conto del concetto lotmaniano di testualità della cultura, basato sulla necessità di ricostruire il contesto, e di impararne la “lingua”, in cui il testo culturale è stato redatto per poterlo interpretare, la sua conclusione sarebbe stata probabilmente diversa» (p. 43 dell’Introduzione).
I Visual Studies e soprattutto i Visual Culture Studies tendono invece a sovrapporre (consapevolmente? quanto consapevolmente?) la testualità alle pratiche, pratiche non tanto pensate come le pensava Foucault (cioè come discorsività ovvero come forme testuali), ma come performance, cioè come realizzazione immediata e concreta di una situazione (o di un comportamento o di un’attività… complici forse, in questo, i Queer Studies?). È così che, ad esempio, durante la pandemia, sono proliferati incontri e pubblicazioni sul tema «The Visual Culture of Sars-Cov-2», dove si discuteva di guanti di lattice e occhiali e mascherine oppure di vuoto urbano o di concerti virtuali sui social media come attori di una semantica visuale… (si noti, appunto, l’uso residuale del termine «semantica» in questo contesto). Non ho dubbi che Lotman classificherebbe tale creolizzazione senza regole dei metodi e delle prospettive, dettata dall’urgenza di rincorrere l’evenemenziale, come un evidente caso di entropia semiotica, di sfrangiamento dell’energia e dell’effetto significanti e semantici dei codici. E, al proposito, è importante sottolineare che il concetto lotmaniano di byt, di «quotidiano», sulla cui centralità teorica insiste molto giustamente l’introduzione al volume, è l’esatto contrario dell’evenemenziale.
Ma ritorniamo alla nozione di testualità che Silvia Burini pone in primo piano. Jurij Lotman è stato uno dei più alti e arditi teorizzatori della testualità nella storia degli studi di teoria della letteratura e di semiotica: ne La struttura del testo poetico (Mursia 1972) egli delineava un’idea di testo inteso come entità segnica, non linguistica, quando per «linguistico» si intenda ciò che è proprio di una lingua naturale. Il segnico testuale non è dunque il linguistico perché il segno-del-testo è frutto d’un atto di transcodificazione compiuto vuoi sulla lingua naturale stessa vuoi su un altro o su una serie di altri elementi appartenenti a codici non linguistici. Credo che non occorra approfondire di più, addentrandoci nella multiplanarità semiotica del testo, per dissipare l’equivoco tra il testuale e il linguistico, da un lato; e per constatare, dall’altro, come l’idea lotmaniana di testualità poetica fosse già intrinsecamente predisposta al dialogo necessario con i sistemi segnici delle altre arti.
Stando a Lotman, dunque, il visuale (o il teatro o il cinema) proprio come il testuale, non è linguistico perché è meta-linguistico ovvero semiotico. Leggere (o rileggere) Il girotondo delle Muse diventa allora davvero illuminante in relazione al Lotman teorico della letteratura, al punto tale da convincerci a invertire il rapporto di preminenza tra lo studioso di letteratura e lo studioso delle arti: lo splendido saggio del 1979, La lingua teatrale e la pittura. Sul problema della retorica iconica (alle pp. 201-220), ci suggerisce, ad esempio, che lo sguardo innovativo e, direi di più, rivoluzionario di Lotman sulla letteratura è nato e si è forgiato nell’interesse primario dell’autore per il teatro – si pensi all’adorato Puškin e al venerato Shakespeare – nonché per la pittura, per la danza e per il cinema, in piena coerenza, del resto, con le radici chiaramente moderniste della sua formazione.
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento
