Lavorìo sui monotipi, così Seghers perse il senno
Nati sotto Saturno / Aspettando Rembrandt: Hercules Seghers Paesaggista innovatore, sbalordisce soprattutto per l’allucinata modernità delle sue acqueforti, che rendeva "uniche" con olio e pigmenti. Finivano come cartocci per i grani di pepe: infatti nessuno le capì tranne... un genio
 Hercules Seghers, "Mountain Valley with Dead Pine Trees", 1622-’25, Londra, British Museum
Hercules Seghers, "Mountain Valley with Dead Pine Trees", 1622-’25, Londra, British MuseumNati sotto Saturno / Aspettando Rembrandt: Hercules Seghers Paesaggista innovatore, sbalordisce soprattutto per l’allucinata modernità delle sue acqueforti, che rendeva "uniche" con olio e pigmenti. Finivano come cartocci per i grani di pepe: infatti nessuno le capì tranne... un genio
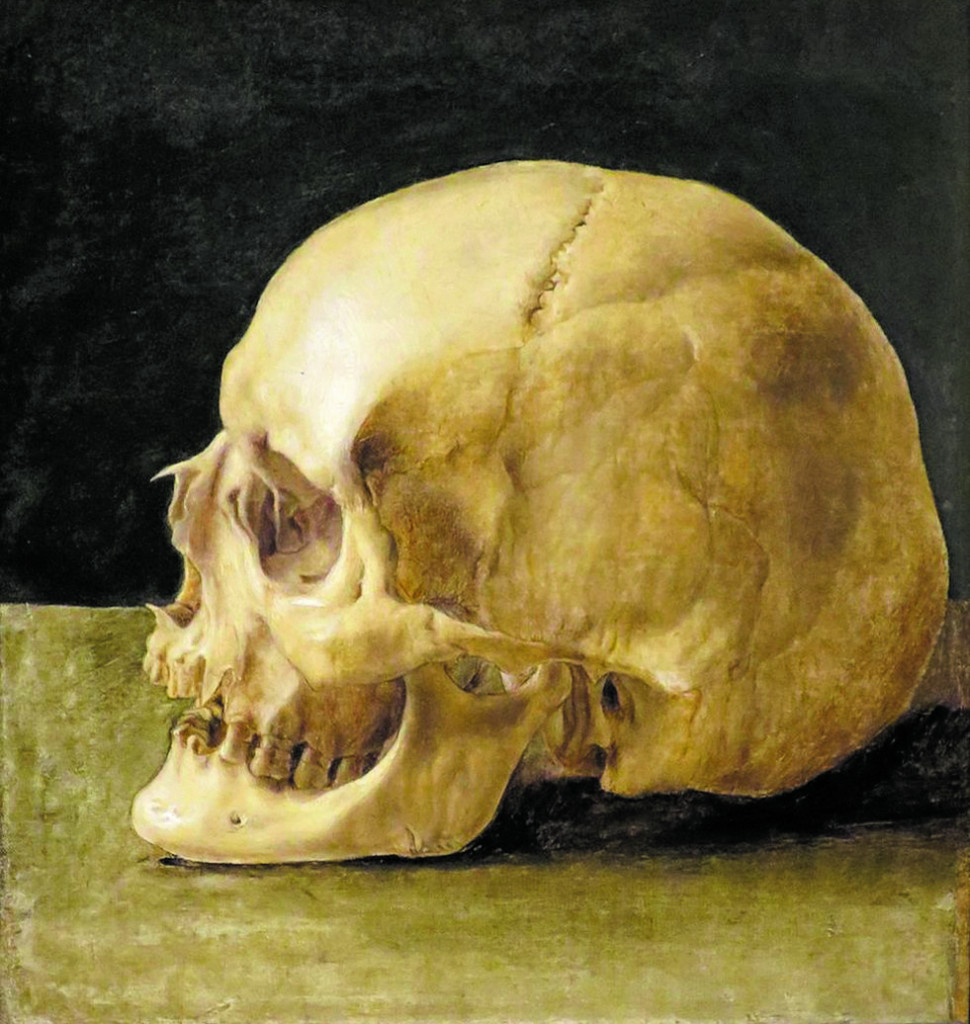
«Un paesaggio con una veduta, in prospettiva, tanto unico (raer) quanto la spiaggia di Porcellis che possiede Sua Altezza Serenissima». Così, nel 1650, il mercante Johannes De Renialme scriveva da Amsterdam a Federico Guglielmo, Elettore del Brandeburgo. L’opera che intendeva vendere al principe tedesco era stata dipinta da uno dei più geniali artisti olandesi: Hercules Seghers. Nato da una famiglia originaria di Ghent, ma stabilitasi a Haarlem per fuggire le guerre di religione, di Seghers sappiamo pochissimo, ma quel poco è abbastanza per essere certi di almeno due fatti. Il primo è che fu un grande artista; il secondo è che ebbe una vita segnata dalle sfortune finanziarie e dal cattivo uso del denaro, che lo resero indigente e molto probabilmente alcolizzato. E del resto, sono le sue stesse opere a mescolare una sorta di allucinazione e una tensione verso tecniche e forme fuori dagli schemi.
Probabilmente, a determinare la sopravvivenza così rarefatta dei documenti riguardanti l’artista contribuì anche il suo continuo spostarsi tra le città delle Province Unite. Nato intorno al 1589-’90 – come si ricava da una carta in cui dichiara la propria età –, Seghers iniziò presto a interessarsi alla pittura. Per quanto si conosca ben poco della sua giovinezza, è facile immaginare che, con alle spalle un periodo nella bottega del paesaggista Gillis van Coninxloo, il paesaggio dovette essere al centro dei suoi interessi sin da subito. Un genere tutto sommato minore ma che, proprio a Haarlem, stava vedendo una grande fioritura e presto avrebbe assunto uno statuto identitario come genere par excellence olandese.
Dopo la scomparsa del padre Peter, il giovane Seghers tornò nella città natale: a Haarlem è infatti registrato nella Gilda di San Luca nel 1612, ma già nell’estate di due anni dopo un documento lo situa di nuovo ad Amsterdam, ed è probabile che fosse in città già da tempo. Lì ebbe infatti una figlia illegittima, Nelletje, che affidò alle cure della propria madre. Mentre stava definendo come sistemare la questione, il pittore si sposò con Anna van der Bruggen, donna originaria di Anversa e di quasi vent’anni più grande, nel 1613; e con lei comprò una casa nel 1619. Seghers si muoveva nel circolo degli emigrati dal sud dei Paesi Bassi, mantenendo e rinsaldando i legami che già erano stati dei suoi genitori: fra loro si trovavano la maggioranza di coloro coi quali commerciava quadri, e proprio ad alcuni di essi si rivolse quando, nel 1626, iniziarono le sue traversie finanziarie.
Non bastò a ripianare i debiti la vendita della casa sul Lindengracht, nel 1631. I creditori incalzavano. Di fronte alla malaparata, Seghers non ebbe altra scelta che lasciare Amsterdam, per rifugiarsi prima a Utrecht e poi, nel 1633, a L’Aia. Fu una vera e propria fuga: aveva lasciato uno stock di più di 130 dipinti a varie persone di fiducia, sperando probabilmente di venderli e ricavarne del denaro per appianare i debiti. Ma non funzionò.
È vero che molti artisti olandesi si trovarono costretti, presto o tardi, a comparire davanti ai giudici per questioni di insolvenza. Ma, nel caso di Seghers, dovette trattarsi per la gran parte di una malaccorta gestione delle proprie finanze, unita al fatto che le sue opere non avevano trovato buona accoglienza presso il pubblico. Un genere minore come il paesaggio, le peculiarità di quelle opere, così uniche e idiosincratiche nel panorama della pittura coeva, non ne facilitavano la vendita. I diciotto dipinti oggi attribuiti all’artista sono tutti ‘inquieti’, segnati da impaginati prospettici sghembi: immaginifiche vedute quasi sempre di piccole dimensioni, che lasciano intuire il portato dell’attento studio delle incisioni di Altdorfer.
A questo si aggiunga che molta parte dei propri sforzi, Seghers la dedicava alle sue specialissime incisioni. Ma più che incisioni si tratta di veri e propri monotipi, esemplari, cioè, su cui l’artista interveniva di volta in volta con l’olio e i pigmenti o con le matite colorate rendendoli, di fatto, unici. Quelle incisioni così raffinate, però, Seghers non trovava proprio il modo di venderle: «molte finirono per essere usate come cartocci per i grani di pepe». Di fronte a tutto ciò «il povero Seghers» pare perse il senno, iniziando a stampare le sue composizioni sulle proprie camicie e sulle lenzuola di casa. Mendicando presso i venditori di stampe e i librai si sentiva rispondere che non c’era mercato per quegli oggetti. Addirittura, un mercante cui s’era rivolto offrendogli una grande lastra di rame, gli rispose che quella non valeva neppure la piccola cifra che Seghers richiedeva. Con l’animo provato, senza scampo all’orizzonte, la leggenda racconta che, ubriaco, capitombolò per le strette scale di casa, rimanendovi ucciso.
Le sue doti dovevano essere del tutto fuori dall’ordinario, come apparve chiaro ai pochi contemporanei che avevano lo sguardo abbastanza acuto per accorgersene. Nel 1678 Samuel van Hoogstraten, che da giovane forse incontrò questo eccentrico pittore-incisore, lo ricordava come l’artista che aveva messo a punto la tecnica per stampare le composizioni su uno strato di pittura approntato sulla carta e financo sulle stoffe. Infatti, per queste opere, van Hoogstraten parla proprio di «pitture stampate». Un procedimento tecnico ardito, in cui un certo margine di imponderabilità aveva il suo peso nel risultato finale.
Guardando alla tradizione del paesaggio così come era stata definita, ad esempio, da Pieter Brueghel o da Hendrick Goltzius e dai suoi allievi, da Jacob Matham a Jan van de Velde, Seghers seppe cogliere gli elementi di novità di quelle opere – soprattutto incisioni realizzate a partire da disegni – e spingerli al limite massimo. Le due serie dei grandi e dei piccoli paesaggi montani, ad esempio, permettono di comprendere a fondo il modo di lavorare di Seghers. Una volta eseguita la tiratura, egli interveniva poi per differenziare ogni stampa, oltre a ritoccare, a volte, anche la composizione di partenza sulla lastra. L’uso di carte colorate (blu, verdi), l’aggiunta dei pigmenti, il lavorìo per ottenere particolari intonazioni, sono tutti aspetti cui Seghers era attentissimo: un’attività che richiedeva moltissimo tempo, che consumava le energie. E si può ben credere che «il povero Seghers» perdesse il lume della ragione di fronte al disinteresse che si vide sbattuto in faccia senza tante cerimonie.
Eppure, in un ristretto circolo di amatori e collezionisti, come dimostra la lettera citata più sopra, Seghers era affiancato nientemeno che al più famoso (e ricco) paesaggista del tempo, Jan Porcellis. Non è affatto casuale che a ricordare diffusamente Seghers e le sue opere sia van Hoogstraten, allievo di Rembrandt negli anni 1641-’42, che dovette imparare ad apprezzare quelle singolari creazioni dalle parole del proprio maestro. Infatti Rembrandt possedeva diverse opere di Seghers, e giunse a rielaborare la lastra del Tobia e l’Angelo (1630-’33) per una sua incisione, la Fuga in Egitto del 1652.
Non c’è da stupirsi se un artista così fuori dagli schemi sia riuscito a suscitare l’interesse degli studiosi moderni. Fu uno dei grandi padri della Storia dell’arte, Wilhelm Bode, a inaugurare la riscoperta di Seghers. E lo fece, ironia della sorte, a partire da un dipinto che si conserva proprio in Italia, agli Uffizi. 1871: durante una visita al museo insieme a Eduard von Liphart, Bode si rende conto che il Paesaggio montano con veduta non è opera di Rembrandt, cui era stato riferito quando il dipinto era entrato nella collezione pubblica nel 1839. Negli anni Bode avrebbe dedicato molta attenzione all’artista, accrescendone il catalogo e pubblicando, nel 1903, un cruciale contributo, che gettò le basi per il risarcimento della fortuna del «povero e sfortunato Seghers».
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento