L’abbandono dell’Alzheimer
Medicina Un'inchiesta del «Washington Post» ha portato alla luce il fatto che molti farmaci, nonostante gli effetti benefici riscontrati, non finiscono al centro di ricerche perché alle ditte farmaceutiche non conviene economicamente. Come nel caso del morbo della dimenticanza
 Un'opera di Jarek Puczel
Un'opera di Jarek PuczelMedicina Un'inchiesta del «Washington Post» ha portato alla luce il fatto che molti farmaci, nonostante gli effetti benefici riscontrati, non finiscono al centro di ricerche perché alle ditte farmaceutiche non conviene economicamente. Come nel caso del morbo della dimenticanza
Le case farmaceutiche hanno trovato la cura per molte malattie ma non lo dicono perché non gli conviene economicamente: lo avrete riconosciuto, è uno dei luoghi più comuni del complottisti. Ma forse stavolta è vero. Secondo un’inchiesta del Washington Post, la casa farmaceutica Pfizer avrebbe scoperto dati promettenti sugli effetti di un farmaco sul morbo di Alzheimer ma li avrebbe nascosti per ragioni di convenienza economica.
Lo scoop del quotidiano muove da un rapporto del 2015 che doveva circolare solo negli uffici della Pfizer e su cui il giornale ha potuto mettere le mani. Il dossier sintetizzava i risultati delle analisi dei dati delle assicurazioni sanitarie riguardanti centinaia di migliaia di americani. In un sistema sanitario quasi interamente privato come quello statunitense, le banche dati assicurative sono preziosissime perché riportano i malanni e le cure della gran parte della popolazione. Da questi elementi, i ricercatori della Pfizer hanno estratto un campione di 127mila pazienti, la metà dei quali affetti da morbo di Alzheimer. Solo un centinaio di loro utilizzava un farmaco impiegato contro l’artrite reumatoide denominato Enbrel e prodotto dalla Pfizer. Nella metà senza la malattia, gli utilizzatori di Enbrel sono risultati quasi il triplo. L’effetto benefico di quel farmaco sembra emergere anche dalla correlazione con i dati su altri sintomi, come la perdita di memoria e il declino cognitivo moderato, i tipici segnali precursori dello sviluppo dell’Alzheimer.
CON UN PO’ DI AUDACIA statistica, lo studio concludeva che quel rimedio riduceva del 64% la probabilità di contrarre il morbo di Alzheimer e suggeriva all’azienda di avviare un trial clinico su un campione di tre o quattromila persone per verificare – con procedure più scientifiche – se l’effetto protettivo dell’Enbrel fosse reale.
La Pfizer non ha seguito queste indicazioni. Anzi, all’inizio del 2018 ha dichiarato pubblicamente la cessazione di ogni attività di ricerca e sviluppo legata alla cura di Alzheimer e Parkinson, a causa della quasi totale assenza di risultati concreti. Perché questo dietrofront, proprio quando l’azienda aveva in mano dati promettenti su cui lavorare?
Secondo l’autore dell’articolo Christopher Rowland, la decisione si spiega con le scarse prospettive di profitto. Il brevetto sul farmaco Enbrel, che dà a Pfizer il diritto di produrlo e commercializzarlo in esclusiva, stava per scadere negli Usa; in altre regioni del mondo, Europa compresa, sono già in circolazione farmaci biosimilari.
Senza brevetto, dunque, ogni azienda farmaceutica avrebbe potuto produrre etanercept (il principio attivo dell’Enbrel) come cura contro l’Alzheimer.
La concorrenza avrebbe fatto calare i prezzi e, di conseguenza, i profitti della Pfizer, che avrebbe anche dovuto accollarsi i costi per i costosi trial clinici. Il sospetto, dunque, è che un potenziale filone di ricerca contro il morbo di Alzheimer sia stato sacrificato alla ricerca del guadagno, a danno dei circa cinquanta milioni di malati nel mondo.
LA PFIZER, ovviamente, sostiene un’altra versione dei fatti. Secondo l’azienda l’effetto del farmaco sull’Alzheimer è troppo debole e un eventuale trial clinico avrebbe avuto poche probabilità di riuscita. «La scienza è stata l’unico fattore determinante nella scelta di non proseguire la ricerca», ha detto il portavoce della Pfizer Ed Harnaga.
Molti scienziati non sono d’accordo con questa valutazione. E in ogni caso si chiedono come mai l’azienda non abbia pubblicato le sue conclusioni, lasciando alla comunità scientifica la possibilità di valutarli.
La difesa dell’azienda è piuttosto debole e paternalistica: hanno deciso di non rendere noti i risultati per non far perdere tempo prezioso agli scienziati. Tra l’altro, in letteratura anche altri studi avevano suggerito un possibile link tra etanercept e Alzheimer, e ogni scienziato sa quanto sia importante, nel sapere medico, che un risultato ottenga diverse conferme indipendenti.
La vicenda mostra l’importanza della trasparenza nella ricerca scientifica odierna: solo condividendo i dati su cui si basano le scoperte scientifiche possono essere confermate da altri scienziati e diventare fatti consolidati, su cui costruire nuova conoscenza.
DATO CHE IL COMMITTENTE della ricerca è spesso un’industria farmaceutica, in medicina talvolta si preferisce non pubblicare i risultati di uno studio se questi contrastano con le strategie di mercato dell’azienda. Il movimento a favore dell’open access o accesso aperto, però, si sta facendo strada anche nelle scienze mediche. Il 25 giugno è annunciato il lancio di un nuovo archivio di ricerche pubblico e gratuito, chiamato «Medrxiv» (crasi delle parole «med» e «archive») su ispirazione dello storico archivio Arxiv dei fisici e del più recente BiorXiv usato dai biologi. Sarà un sito internet in cui ogni ricercatore potrà pubblicare i propri studi, lasciando al lettore il compito di giudicarne la rilevanza.
CON LA MEDICINA però non è così facile. Pubblicare ricerche mediche senza passare per una valutazione accurata (come avviene nelle riviste tradizionali) può essere molto pericoloso: se il sito Medrxiv ospiterà ricerche favorevoli all’omeopatia o contrarie ai vaccini, finirà confondere ancor di più i cittadini meno esperti.
Lo scandalo Pfizer dimostra come la logica imprenditoriale e quella della ricerca scientifica spesso confliggano. In casi come questi, il diritto alla salute dovrebbe prevalere sulle esigenze puramente economiche di un’azienda: se un’azienda non ritiene redditizio esplorare una linea di ricerca promettente, dovrebbe farlo quella pubblica. Ma ne servirebbe una forte e organizzata, capace di intervenire almeno laddove il mercato non basta: merce rara ormai in tutto il mondo.
NOTIZIARIO SCIENZA
L’intelligenza artificiale inquina

Ipotesi: i pianeti influiscono sul Sole?
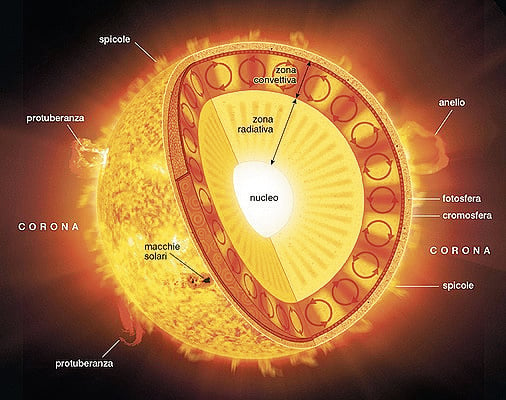
Le gemelle modificate vivono di meno

I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento