La vulnerabilità alla prova della filosofia. E dei corpi
STORIA DELLE IDEE Un percorso di letture: dal saggio «Essere fragili», di Joan-Carles Mèlich, al romanzo di Senka Maric «Corpo kintsugi»
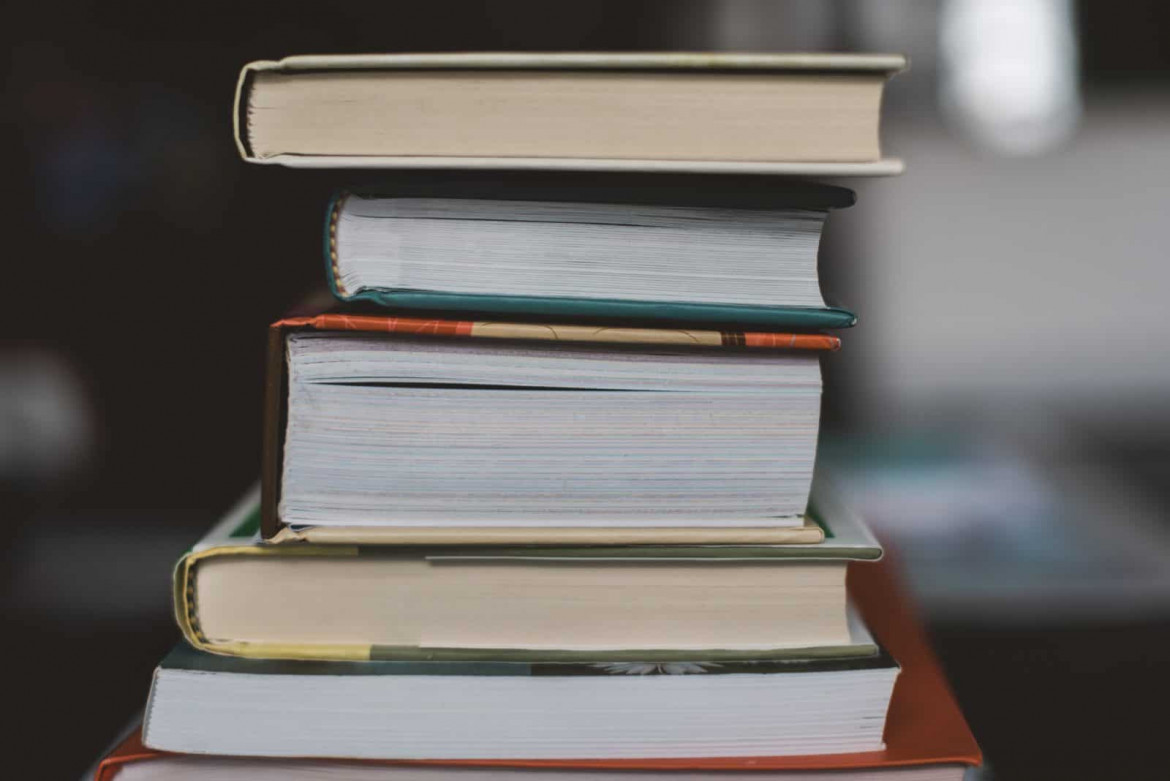
STORIA DELLE IDEE Un percorso di letture: dal saggio «Essere fragili», di Joan-Carles Mèlich, al romanzo di Senka Maric «Corpo kintsugi»
Nel suo saggio Essere fragili (pp. 128, euro 12, traduzione di Simone Cattaneo), Joan-Carles Mèlich affronta l’idea di vulnerabilità nella sua accezione attiva e «passionale», in relazione. Non è debolezza, anzi è processo trasformativo. E si risponde, anche alle ferite che non riguardano noi stessi, attraverso «l’appello dell’altro»; se di primo acchito la mente potrebbe andare a Buber e Lévinas, i riferimenti di Mèlich sono numerosi e non scontati: da Virginia Woolf a Hannah Arendt e Rainer Maria Rilke, da Jean-Paul Sartre a Judith Butler a Adriana Cavarero. Sgranando il dato empirico, e distillando quello della «condizione umana» che ha storicamente pagato il prezzo di dualismi occidentali piuttosto violenti, il filosofo spagnolo sostiene che «i corpi vulnerabili non possono esistere senza l’etica, non più da intendersi in termini di normatività, bensì come cura di sé e dell’altro». Interessanti i passaggi dedicati ad esempio alla carezza, come pratica inattesa (sul contatto e la carezza Luce Irigaray ci ha consegnato, anni fa, riflessioni mirabili) che fanno del vulnus una qualità più esistenziale che biologica. E ciò è vero, ma non del tutto. Perché una non esclude l’altra.
NEL TRAGITTO della finitudine che concerne il vivente quale posto ha, per esempio, l’eventualità della malattia? Lo scopriamo grazie al romanzo di Senka Maric, basato sulla esperienza diretta dell’autrice: «Questa è la storia di un corpo. Della sua lotta per sentirsi intero mentre la realtà lo fa a pezzi». La protagonista ha 42 anni quando nella estate del 2014 si accorge di avere il cancro. Nel giro di un mese e mezzo viene operata tre volte, al seno. Si sottopone alla chemioterapia e il suo racconto dettagliato dei tagli (e dei medicinali) è reale e altrettanto frammentato. Ciò che però la scrittrice e poeta bosniaca compie con il suo Corpo kintsugi (Antonio Mandese editore, pp. 125, euro 16, traduzione di Elvira Mujcic) – che nel 2018 vince il prestigioso premio Mesa Selimovic e viene tradotto in mezzo mondo – è un romanzo che possiede una rabbia erotica sorprendente.
Lo stile risente delle ormai tre sillogi pubblicate da Senka Maric: minimalista, frasi brevi, acuminate e autoptiche che creano congiunture svettanti piani temporali e passaggi di età. Il risultato è la «celebrazione» collocata nella parola giapponese kintsugi, l’arte di riparare le ceramiche rotte con l’oro liquido, perché niente scompaia e tutto sia visibile. La scelta di questa pratica diventa politica quando Senka Maric, pure nello sprofondo di un dolore personale, intanto sceglie di darsi del tu per poi sigillare intorno a sé un coro di voci femminili che compaiono, transitoriamente, al suo cospetto.
È QUESTA CIFRA collettiva a rendere il romanzo affiancabile ad altre narrazioni del cancro, sia pure diverse; basterebbe pensare a Audre Lorde e Carla Lonzi ma, più di recente, a volumi importanti come quello di Mounia El Kotni e Maëlle Sigonneau (Im/Paziente. Un’esplorazione femminista del cancro al seno, edito da Capovolte). Del resto che anche la malattia sia situabile in un corpo sessuato non è affare trascurabile, e lo si capisce molto bene là dove non c’è stereotipo che tenga né il tentativo di parlare per conto di altre e altri ma nella deliberata pretesa di una indagine al centro di un sé non pacificato – anche quando la guarigione (come nel caso di Senka Maric) è avvenuta.
Corpo kintsugi non è certamente un messaggio all’umanità che dichiara guerra ai tumori (in tal senso, anche sull’uso di un certo repertorio bellico, Susan Sontag scrive parole indimenticabili nel suo Malattia come metafora). Senka Maric, nata a Mostar, è invece nella rivolta di una carne, la propria, che non teme di andare fino alle radici della irrequietezza come sfondo dell’esistente. Sa invece che i segni sul suo corpo non sono colate d’oro eppure a circolare ogni tanto compare anche l’amore, caldo come il latte con il miele che le preparava la nonna quando era ragazzina. Lo sa e la forza talvolta la perde, nell’esercizio (indesiderabile, a volte intollerabile) di sopravvivenza e riparazione.
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento