La rivendicazione logica della storia e l’umanità che ha necessità della poesia
Scaffale I «Discorsi di Oxford» di Benedetto Croce per Treccani. I saggi raccolti nel volume apparvero nella rivista «La Critica» nel 1930 e nel 1934
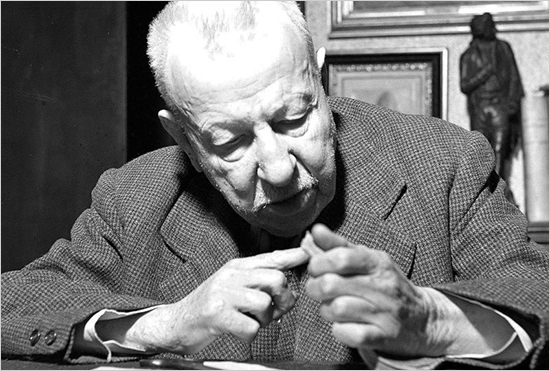 Benedetto Croce
Benedetto CroceScaffale I «Discorsi di Oxford» di Benedetto Croce per Treccani. I saggi raccolti nel volume apparvero nella rivista «La Critica» nel 1930 e nel 1934
Per le edizioni Treccani Libri, esce Discorsi di Oxford. Antistoricismo e «Difesa della poesia» (pp. 144, euro 15, con un saggio di Gennaro Sasso, a cura di Emma Giammattei). L’autore è Benedetto Croce che il 3 settembre 1930 si trova a Oxford, durante le giornate del VII congresso internazionale di filosofia.
In quell’ambito, Croce presenta la sua lettura dal titolo Antistoricismo. «Più o meno presso ogni popolo di Europa – dirà Croce – si nota oggi una sorta di decadenza del sentimento storico, quando non addirittura uno spiccato atteggiamento antistorico». Vengono contrapposti due movimenti aventi effetti diversi ma una causa comune. Da una parte quell’antistoricismo futurista «che idoleggia un futuro senza passato» e ammette una storia solo a venire, dall’altra un movimento che detesta «l’idea stessa della storia come regno del relativo e del contingente», che si oppone all’«individuale» e – dunque – al vario, il cui movimento primo è l’incessante opera di «restaurazione» che, neppure a dirlo, all’interno dello storicismo crociano, appare come «la più fragrante negazione della storia». Entrambe queste forme hanno «l’origine nel comune rigetto della storicità, e si oppongono nel concepire diversamente l’opera che all’uomo tocca di adempiere».
QUESTE DUE FORME antistoriche, nota Croce, hanno un riflesso nelle strutture della letteratura e dell’arte manifestandosi «nei conati di ritorno al classicismo dei generi fissi» o nei luoghi di un’accademia che paradossalmente vogliono contrastare e che invece rinnovano, restaurando il passato. È lo specchio del fascismo in cui «gli anarchici trapassano in autoritari» e «la barbarie – che è essenzialmente antistoricismo – viene guardata in relazione alla nuova e più alta forma di autorità». Si chiede allora Croce se «nell’odierno antistoricismo» ci sia una qualche forma vaga di «vita spirituale», se in «quell’involucro di stravaganze», «in quel distruggere operi già innanzi un costruire». La risposta, per buona pace degli antistoricisti, è nella storia, che è «storia della libertà» per cui ogni «antistoricismo odierno» appare come una forma eretica di disperazione.
In questo testo, Croce torna alla rivendicazione logica di una storia «e nient’altro che storia» cui sembra mancare, proprio nel percorso ontostorico, l’imprevisto antico della rottura. Esiste la storia, certo, ma – verrebbe da chiedersi – dove sono i popoli ? È qui che la filosofia della storia diviene piuttosto una «religione della storia» (come dirà Chabod), ed è così che si manifesta, come ha scritto Tessitore, quel «crociano storicismo in forma negativa», «l’intento di coniugare la filosofia della vita storica di uomini di carne e sangue con lo storicismo come storicità, espressione compiuta di tutta l’umanità».
SONO ALLORA queste ipotesi a subire un’immediata risposta politica nel primo dopoguerra. Del resto, fu proprio a causa della concezione storicista che, nel Pci dei primi anni cinquanta, venne a prodursi una crisi neppure secondaria tra gli iscritti più anziani e i giovani compagni che avrebbero desiderato affrancare il partito dall’influenza dei canoni crociani ancora imperanti. Eppure Croce è lo stesso filosofo che il 28 e 29 gennaio 1944 è incaricato di aprire i lavori del primo congresso del Cln al Teatro Piccinni di Bari, lo stesso che, in quell’occasione, aveva ricordato il ruolo della politica e le responsabilità di ognuno avute nella guerra civile spagnola prima e in quella italiana poi. Così quella storia che il filosofo intende nel saggio sull’«antistoricismo» è ancora preda di uno storicismo ininterrotto o forse, per intenderla nel suo senso definitivo, andrebbe considerata come espressione di una storia che è anche (e prima di ogni altra cosa) storia letteraria. Come per Vico la forma della libertà nata nella barbarie è essenzialmente letteraria, allo stesso modo lo è per Croce. Ed è qui che la critica letteraria si fa critica della società. Perché «l’umanità – che coincide con il sentimento storico – non può far di meno della poesia».
D’ALTRA PARTE, proprio nella conferenza oxoniense ora ripubblicata Croce racconta che, sebbene si ricordino Totila e Alboino (ovvero i re ostrogoti e longobardi) non è per coloro che «scannarono e devastarono coi goti» che la storia continuò a progredire quanto – semmai – per il fatto di avere avuto un Boezio e un Gregorio che, continuando «la tradizione romana concorsero a generare gl’italiani dei Comuni e quelli del Rinascimento». Quasi a dire – con Vico – che nella storia dei regimi teocratici o autoritari («nei secoli di violenze e barbarie»), emerga sempre, forte del più ideale storicismo, una forma di incondizionata libertà.
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento
