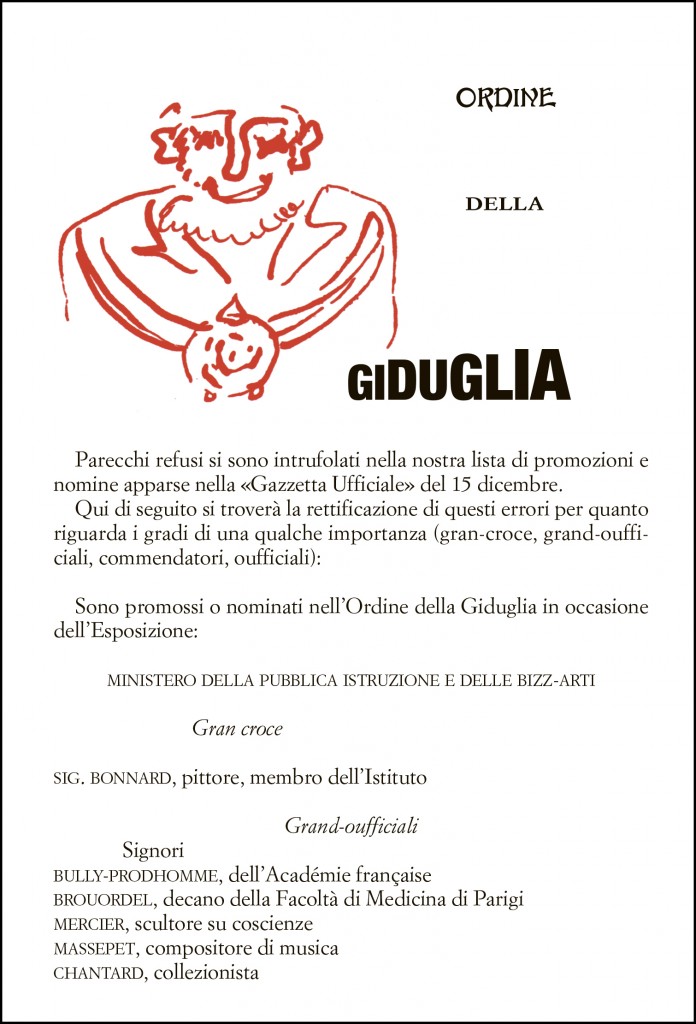
Pagine dall’Almanacco illustrato di Padre Ubu con i disegni di Pierre Bonnard
Alias Domenica
Jarry, padre Ubu nell’officina Vollard-Bonnard
Avanguardia francese Tre giorni fitti di lavoro alla galleria del mercante di Cézanne, con le illustrazioni a tre colori di Bonnard: l’«Almanacco illustrato di Padre Ubu», da Castelvecchi
Pubblicato più di 6 anni faEdizione del 18 febbraio 2018
«E’ nella cave di rue Laffitte che fu composto Il grande almanacco illustrato. Tutti sanno che ne sono autori Alfred Jarry per il testo, Bonnard per le illustrazioni e Claude Terrasse per la musica. Quanto alla canzone, essa è di Ambroise Vollard. Tutti lo sanno, pertanto nessuno sembra aver notato che Il grande almanacco illustrato è stato pubblicato senza nome d’autore né d’editore. La sera in cui immaginò quasi tutto ciò di cui si compone quest’opera degna di Rabelais, Jarry spaventò chi non lo conosceva chiedendo dopo cena il vasetto di sottaceti, che divorò con ingordigia». Così si legge in...

