Invulnerabilità e altre mitologie
ITINERARI CRITICI «Raccontare la cura», un volume di Laura Marzi (Futura editrice). Il confronto tra letteratura e realtà rende visibile relazioni di potere e dominio, soprattutto nel lavoro
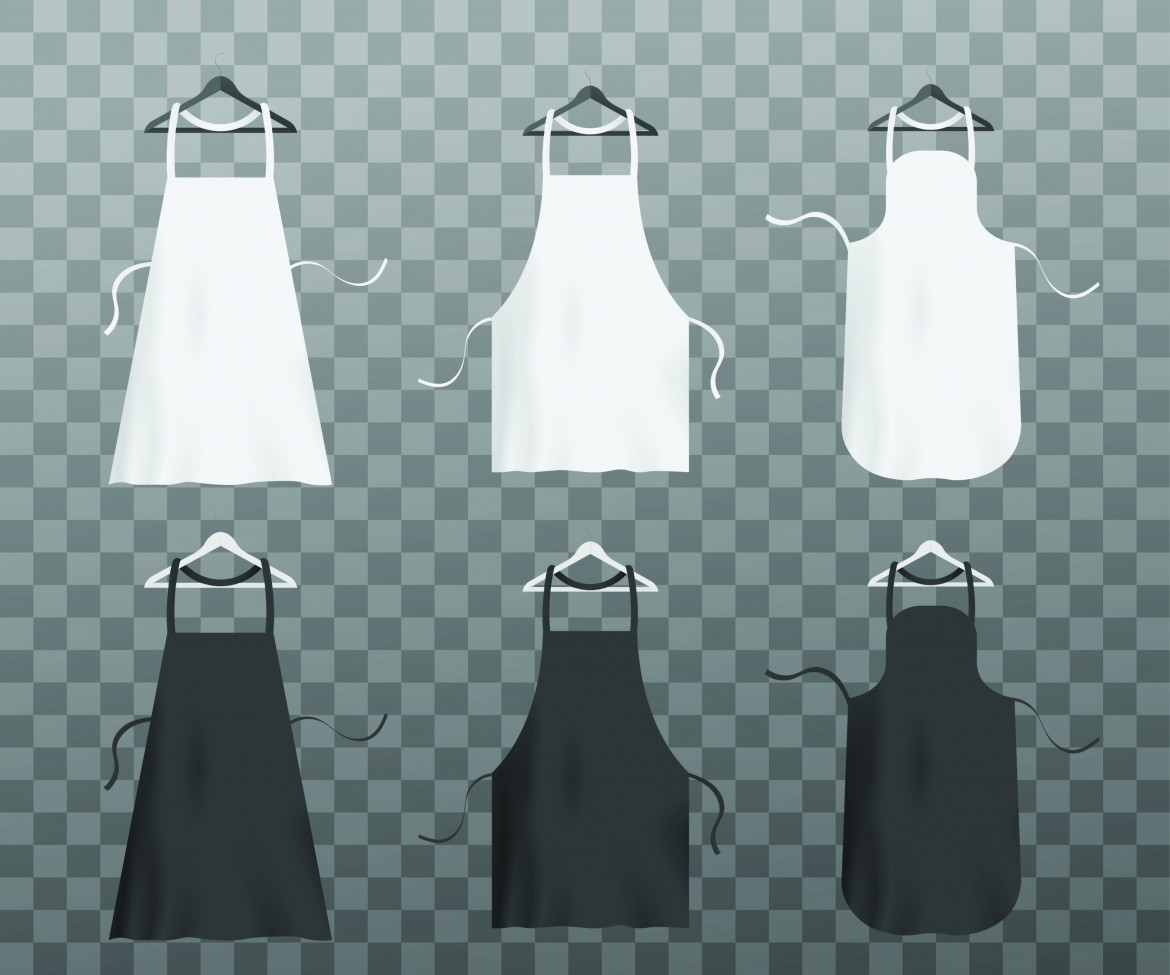 Foto Shuterstock
Foto ShuterstockITINERARI CRITICI «Raccontare la cura», un volume di Laura Marzi (Futura editrice). Il confronto tra letteratura e realtà rende visibile relazioni di potere e dominio, soprattutto nel lavoro
Raccontare la cura è un volume di Laura Marzi edito poche settimane fa da Futura (pp. 120, euro 16). Pubblicato per la prima volta in Francia nel 2022 da Ens (Éditions de École normale supérieure de Lyon), è un percorso interdisciplinare che l’autrice, scrittrice e collaboratrice di queste pagine, porta avanti da diversi anni con l’acume che la distingue nel panorama della critica femminista e che le consente di sondare con sapiente disinvoltura diversi campi, dalle letterature comparate alla filosofia, la sociologia e la linguistica. Complesso, si potrebbe obiettare, fare il punto su cosa sia la cura, parola scivolosa che innesca molta retorica, e oggetto di ricerca che in Italia ha prodotto molti e interessanti scambi, anche a partire dalle pratiche politiche (un esempio è il supplemento al numero 89/2011 della rivista Leggendaria del «Gruppo del mercoledì» – allora formato da Fulvia Bandoli, Maria Luisa Boccia, Elettra Deiana, Laura Gallucci, Letizia Paolozzi, Bianca Pomeranzi, Bia Sarasini, Rosetta Stella e Stefania Vulterini – che è un approfondimento ancora oggi importante sul tema della cura) oppure per ciò che concerne gli studi di Elena Pulcini, come di Luigina Mortari e altre. Che la cura inneschi uno spostamento, culturale e politico, è visibile anche nel Manifesto della cura. Per una politica dell’interdipendenza (The Care Collective è fondato dal 2017).
MOLTE PERÒ sono le istanze che porta con sé la cura e Laura Marzi affronta il tema da una prospettiva poco frequentata in Italia, intanto perché per dire la cura sceglie l’intersezione di letteratura e realtà a confronto, partendo dai testi perlopiù narrativi. E poi, e questa è la ragione forse principale, perché sceglie un orizzonte di avvistamento come i care studies, consegnando una bibliografia importante, tradotta in italiano in maniera discontinua. Tra i primi nomi che compaiono c’è quello saldo della filosofa Sandra Laugier, che segnala come la cura si realizzi nell’accesso privilegiato alla vita ordinaria riscontrabile nella letteratura; come lei sono molte a essersi dedicate a questo nodo, tra le altre Dominique Hétu e Amalia DeFalco. L’arcipelago corrisponde tuttavia a un gruppo di studiose che fanno capo agli studi sul care – in Francia e non solo – e che vanno da Marie Garrau e Alice Le Goff a Patricia Paperman, Caroline Ibos, Pascale Molinier, allargando la riflessione sulla cura.
Secondo Marzi, «la letteratura risulta essere uno strumento non solo adeguato se non anche necessario per l’analisi dell’oggetto di ricerca in questione: il lavoro e la relazione di cura». Se molto è stato scritto, proprio per ciò che rende la cura questione in carico alle donne, vero è che il femminismo ha potuto se non riscrivere almeno riappropriarsi del tema con le dovute differenze di contesto. Nel caso di Laura Marzi, la scelta letteraria non è neutra perché illumina una differenza di classe là dove analizza la relazione di potere (e dominio) tra chi sono i destinatari e le destinatarie della cura e i e le care workers, per esempio nel romanzo di John M. Coetzee, Slow Man in cui la distanza tra la lavoratrice e la persona di cui si occupa è irriducibile. Lo spettro è più ampio e le connessioni tra i testi, non solo letterari, che raccontano l’approccio dei care studies è ancora più rilevante quando ci si concentra sul mancato riconoscimento subito dall’etica e dal lavoro di cura indagandone i motivi, almeno quelli ineludibili: al primo posto c’è l’illusione, tutta occidentale, di una umanità invulnerabile e indipendente, mentre la dipendenza segna (presto o tardi) la vita di chiunque (per l’invecchiamento o la malattia).
IL MITO DELLA INDIPENDENZA è tuttavia anche un privilegio, ovvero è indipendente solo chi può permettersi che altri si occupino dei suoi bisogni. Un aspetto interessante, tra i tanti che il volume di Marzi sollecita, è quello legato al cosiddetto «eroismo di genere» che l’autrice chiama «eroinismo» (dando a tale concetto quella di un eroismo in relazione, femminista), partendo dalle analisi etnografiche condotte da Caroline Ibos a proposito delle tate ivoriane che lavorano per le famiglie parigine. Se l’eroismo neutro, maschile in particolare, si fonda sull’autosufficienza assoluta, colui che non ha bisogno di nessuno, l’eroinismo «si definisce attraverso azioni volte al mantenimento e alla salvaguardia della vita in un contesto relazionale». La vita ordinaria è vulnerabile, nessun eccezionalismo.
*
SCHEDA. L’estate romana di «Feminism»
«In forme diverse», l’estate di Feminism, si svolgerà nel giardino della Casa internazionale delle donne di Roma, nell’ambito di Diva’s Jazz, da luglio a settembre. Di seguito alcune date: si comincia martedì 2 luglio alle 19 con la presentazione del libro di Nadia Pizzuti, «Iran. La lunga marcia delle donne», edito da All Around. A settembre invece (il 4, ore 18,30) la presentazione del libro di Laura Marzi, «Raccontare la cura» edito da Futura. Il 5 settembre sarà la volta di «Più ci rinchiudono più diventiamo forti», (Mondadori) che viene presentato da Parisa Nazari. Con la collaborazione di Archivia, Casa internazionale delle donne, LeSconfinate, Muovileidee, nasce la nuova rassegna
che si terrà nei mesi di luglio e settembre. Il programma completo qui: www.casainternazionaledelledonne.org.
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento