In terra siciliana, l’ulivo e il legame tra selvatico e coltivato
POESIA A proposito dell'ultima silloge di Giuseppe Cinà, edita da la Vita Felice
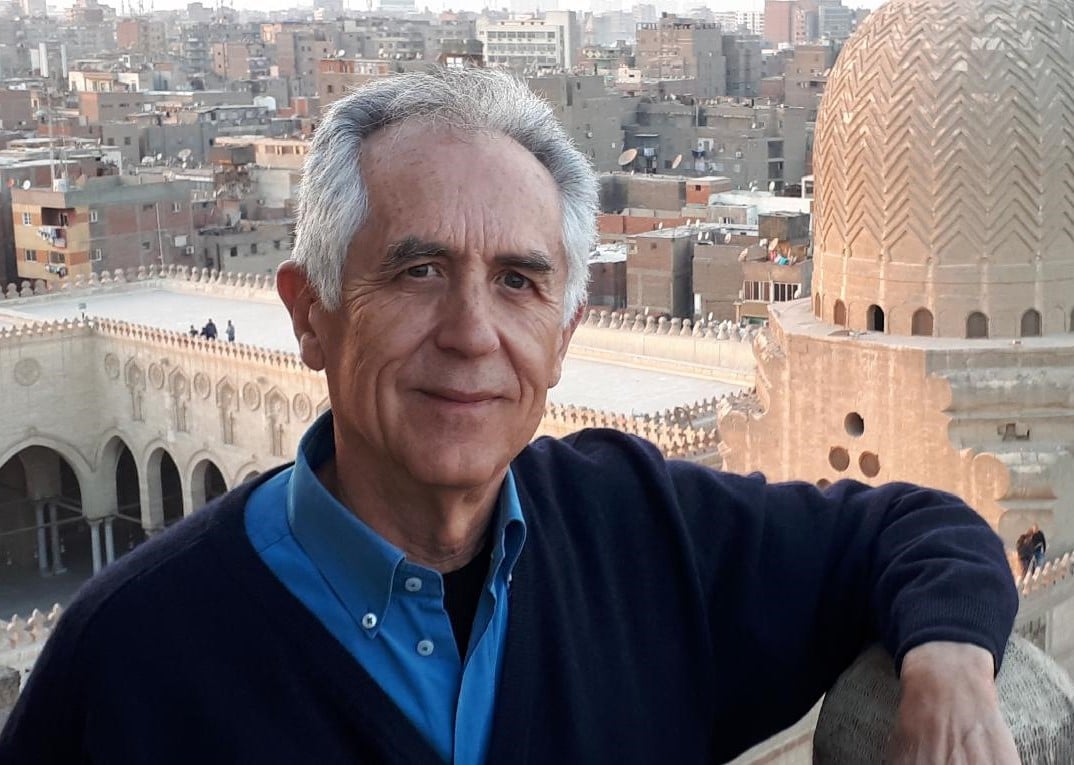 Giuseppe Cinà
Giuseppe CinàPOESIA A proposito dell'ultima silloge di Giuseppe Cinà, edita da la Vita Felice
Nel suo L’àrbulu nostru (prefazione di Velio Abati, La vita felice, pp. 140, euro 14) in lingua siciliana Giuseppe Cinà si muove entro le coordinate della tradizione alta della letteratura occidentale, per sposarla con la cultura popolare, antropologica, della civiltà contadina. Qui si consuma per intero la parabola dell’ulivo, dalla sua dimensione sacrale delle origini mitiche ai «toni sempre più laici, fino ai giorni nostri» e all’esaurirsi del rapporto che lega l’uomo all’ulivo nel mondo globalizzato che lo ha ridotto sempre più a predabile risorsa. Nel suo precedente La macchia e u jardino l’ulivo era già presente nella poetica dell’autore, e qui trova il suo naturale e articolato sviluppo; e come scrive nella prefazione Velio Abati, «Cinà ha scoperto che lu jardinu e ancor più la cura dell’alivu fanno tutt’uno con la materia viva del dialetto».
IL DIALETTO è dunque il grande tramite verso le radici di questa millenaria civiltà contadina di cui rinveniamo le prime tracce già nel neolitico in Anatolia. E Cinà ce la mostra come nella cronaca di un «presente atavico», poiché, per quanto possa sembrare un ossimoro, il presente è quello che continua ad accadere oggi, forte di ciò che è sempre accaduto in un passato remoto. La macchia e u jardino ha sin da subito messo a fuoco una delle antinomie portanti di questa poetica: il rapporto tra selvatico e coltivato. Qui l’autore cerca di dare voce a entrambe le dimensioni, spesso restituendo al selvatico la dignità altrimenti negata, a volte valorizzando l’arte della civilizzazione (sull’esempio dell’innesto o della potatura), a volte riconoscendo al selvatico il suo momento di trionfo (come nel caso dell’ogliastro), ma in ogni caso cercando una composizione delle antinomie, forse intuendo i limiti di un opus contra naturam, sentendo che una civilizzazione, che abbia reciso le sue radici istintuali, è opera morta. E quella occidentale è moribonda. E forse, a partire da questo sradicamento, nel libro è avvertibile «un nostos che prende corpo sulle tracce dell’ulivo, albero e principio fondativo come pochi altri della patria mediterranea»; e nostos è soprattutto «ricerca di sé nel tempo, nello spazio, nelle corde che ci legano alla società cui apparteniamo».
Strutturato in quattro parti, nella prima Cinà ci introduce alle origini mitiche dell’ulivo stabilendo le coordinate classiche – bibliche e omeriche – del suo orizzonte poetico. Nella seconda parte, facciamo ingresso nella Storia, forse la parte più narrativa del libro, con molti passaggi dialogati, e incursioni di teatralità, con personaggi tipici e quotidiani, come il carrettiere «in un orgasmo di cicale a messa cantata», ciascuno portatore di una sua verità, come a comporre una coralità di fondo che dal passato dà voce al presente.
LA TERZA PARTE, è forse quella più prossima ai toni meditativi e lirici, nella dimensione solitaria della voce poetante a contatto con il paesaggio aspro e selvatico, in linea di continuità con il libro precedente nella parte dedicata alla macchia mediterranea. E infine una quarta parte in cui la poesia si fa denuncia della partita truccata della modernità, con la sua prostituzione di valori, che spaccia per biologico ed ecologico quello che è solo merce. La pandemia che viene dalla Cina sta all’essere umano, come la xilella che viene dall’Africa sta all’ulivo – ci accorgeremo prima o poi che la globalizzazione di una specie sta distruggendo l’intero ecosistema? In un accorato richiamo la poesia sposa il «noi» della solidarietà: «Siamo ancora vivi/ diamoci aiuto!» Nata senz’altro con un’attitudine epica, è una storia vista con gli occhi dell’ulivo che si vede sradicato come l’africano migrato, ed esibiti entrambi come cimeli «all’entrata di fiere e grandi alberghi /_…_/ della beffarda favola in cui siamo/ tutti e due prigionieri». All’autore non resta infine che tentare di risvegliare gli urbanizzati del biologico a non vedere «solo una metà del mondo», rimanendo all’oscuro di quella che è la vita vera della campagna e la sua poesia, dove alle spalle dell’albero nostro ancora risuona la festa di più antiche nozze tra l’umano e il divino. Ed è forse a questa festa comunitaria che tutti potremmo tornare.
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento