Il linguaggio perduto e ritrovato in periferia
Un percorso di lettura Voci oltre il «centro». Il romanzo di Francesco Pecoraro, «Lo stradone» (Ponte alle Grazie), l’inchiesta di Goffredo Buccini, «Ghetti» (Solferino), il diario di Achille Lauro, «Sono io Amleto» (Rizzoli)
 Il quartiere romano di Torre Maura – Giuseppe Chiantera per Save the children
Il quartiere romano di Torre Maura – Giuseppe Chiantera per Save the childrenUn percorso di lettura Voci oltre il «centro». Il romanzo di Francesco Pecoraro, «Lo stradone» (Ponte alle Grazie), l’inchiesta di Goffredo Buccini, «Ghetti» (Solferino), il diario di Achille Lauro, «Sono io Amleto» (Rizzoli)
«Nascono potenze e nobiltà, feroci, nei mucchi di tuguri, nei luoghi sconfinati dove credi che la città finisca, e dove invece ricomincia, nemica, ricomincia per migliaia di volte, con ponti e labirinti, cantieri e sterri, dietro mareggiate di grattacieli, che coprono interi orizzonti». Tra i versi raccolti da Pier Paolo Pasolini in La religione del mio tempo (Garzanti, 1961) la periferia è, come nell’intera opera del poeta di Casarsa, a un tempo «nobile» e «feroce», orizzonte in divenire e luogo dell’anima, dove ritrovare qualcosa che evochi le radici perdute della civiltà contadina travolta dalla società dei consumi. In altre parole, per così dire, allo stesso modo passato e futuro. Quasi che a specchiarsi nei territori spesso considerati come «perduti» che sorgono oltre «il Raccordo Anulare», per restare ad una geografia cara a Pasolini, il Paese riveda un se stesso di cui ha perso memoria e scorga i primi annunci di un avvenire ancora di là da definirsi compiutamente, ma che già si respira nell’aria.

IL RAPPORTO, talvolta più lineare, altre decisamente contraddittorio che «le periferie» – termine, va detto, che racchiude ormai una realtà urbana moltitudinaria, dove vecchi quartieri popolari in piena gentrificazione si misurano con nuovi insediamenti dall’inedito profilo sociale -, intrattengono con il resto della «città», assumendo di volta in volta il ruolo di laboratorio del futuro e/o di ridotta delle radici, è da tempo al centro della riflessione e dei segnali che da questi territori arrivano. Al punto che tre libri, tutti a loro modo importanti e pubblicati in questa prima parte del 2019, pur muovendo da approcci e linguaggi tra loro anche molto diversi, per non dire quasi reciprocamente conflittuali, possono essere esaminati proprio a partire da questa sorta di ipotetica linea di faglia interpretativa con la quale si misurano con esiti imprevisti.
In questo senso, il primo segnale arriva da Lo stradone (Ponte alle Grazie, pp. 446, euro 18,00), il nuovo romanzo di Francesco Pecoraro (recensito da Guido Mazzoni su Alias del 28 aprile scorso). Lo scrittore romano, già nella cinquina finalista del Premio Strega nel 2014 con La vita in tempo di pace (Ponte alle Grazie), architetto e urbanista, racconta il Novecento attraverso la storia, che si perde ben più in là nel tempo, di un quartiere della capitale, quello di Valle Aurelia dove degrado e declino odierni, individuali come collettivi, si misurano con l’eco del sogno sovietico di una vecchia «periferia rossa»: in questo caso la Piccola Russia del borghetto operaio della Sacca.
SIMPATICAMENTE SPIETATO, dotato di un cinismo romantico come di una memoria di lungo corso, il protagonista-narratore osserva dal settimo piano di un palazzo «il Ristagno» che si impadronisce pian piano dello «stradone» come dell’intera città. «Da qui – spiega – il mio occhio sensibile vede di cosa sono capaci gli incapaci, vede come le non-scelte dell’amministrazione, la stupidità dei tecnici, degli urbanisti e infine degli architetti incide malamente sulla vita in una porzione di città, anzi di no-città, che è pur sempre la nostra». Solo il tempo di una pausa di riflessione, ed ecco che aggiunge con altrettanta, franca determinazione: «Ma le cose non stanno nemmeno così, non esistono veri responsabili, la città che costruiamo è un prodotto collettivo. La città fisica è la conchiglia deforme che la città sociale, come un gigantesco mollusco semideficiente, costruisce per sé e così facendo si rappresenta. La città demmerda è un’incerta, auto-celebrante, messa in figura della gente demmerda che ci abita e che la costruisce. Niente di più, ma neanche niente di meno».
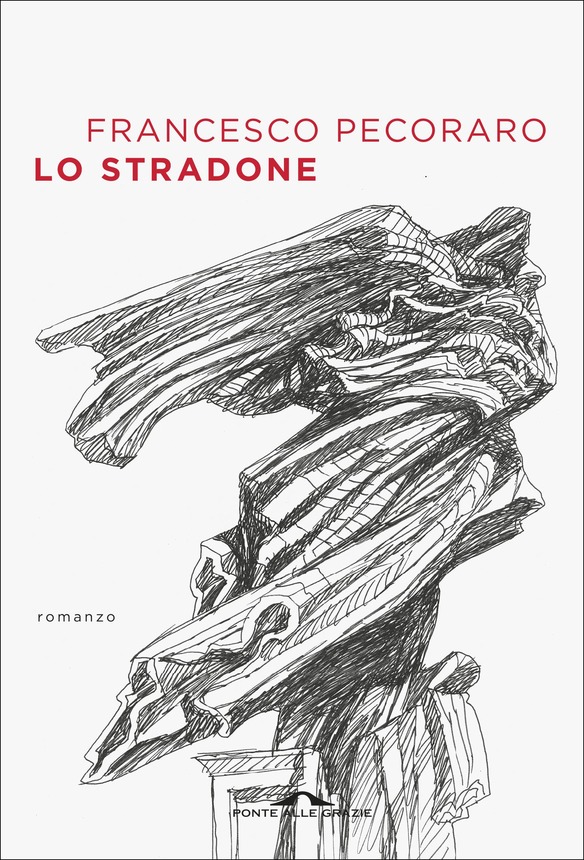
CIÒ CHE CHIAMIAMO PERIFERIA, in un gioco di rimandi che evoca Michel Houellebecq come Walter Siti, fotografa più in profondità la cifra dell’epoca: «La stabilizzazione, la morte delle aspirazioni al cambiamento e l’avvento della soddisfazione di essere come si è, confortati dal consumismo mediatico, dalla fine dell’utopia e dall’instaurarsi di una politica del presente, che non è altro che maldestra occasionale tecnocrazia del giorno per giorno, il populismo dell’arrivare alla fine del mese, del mi levi la tassa sulla casa, del cacciare tutti i foresti, del riuscire ogni tanto a svuotare qualche contenitore colmo di rifiuti».
Anche Goffredo Buccini, cronista del Corriere della Sera, utilizza ciò che sembrano apparirgli come le banlieue nostrane per indagare sulla coesione sociale a venire del nostro Paese. Il suo Ghetti, l’Italia degli invisibili (Solferino, pp. 332, euro 17,00) si presenta come un lungo reportage che si snoda lungo quei quartieri dove «si gioca il futuro» nazionale: Scampia, Corviale, Pioltello, Ostia, Tor Sapienza, il Moi di Torino, i Caruggi e la Diga di Genova, lo Zen di Palermo. Il punto di partenza del racconto è però la tragica vicenda di Pamela Mastropietro, uccisa un anno fa a Macerata e per la cui morte è stato condannato il nigeriano Innocent Oseghale. «Due marginalità su cui nessuno è riuscito ad intervenire si sono incrociate, l’esito è questo», scrive Buccini.
L’IDEA DI FONDO, in qualche modo paradossalmente consolatoria e allarmante allo stesso tempo, è che in questi territori, abbandonati dalla politica e dalle istituzioni, si stia combattendo «una guerra civile a bassa intensità» che coinvolge fasce sociali che scivolano verso la povertà e l’emarginazione e una parte dell’immigrazione «irregolare», mentre piccoli e grandi poteri criminali, al pari della nuove destre politiche, e del neofascismo loro alleato, speculano interessati sulla faccenda. La forza dell’indagine di Buccini non risiede però tanto in questa linea interpretativa, a tratti decisamente troppo netta quanto ad automatismi tra disagio sociale e presenza degli «irregolari», quanto piuttosto nel dare voce a zone i cui abitanti sono spesso interpellati solo quando le loro vicende «fanno cronaca», e non certo in senso positivo. «L’Italia invisibile» che prende corpo pagina dopo pagina descrive un abbandono che è prima di tutto sociale, educativo, assistenziale, denuncia una carenza dello Stato che prima che «repressiva» è legata alla condizioni di vita, agli alloggi, all’assenza di infrastrutture e di trasporti. Il Paese che si specchia nelle Vele di Scampia non è alla ricerca di un’«identità» ma di una vita degna di essere vissuta.

ALLO STESSO TEMPO, la periferia può diventare, a causa ma in qualche modo anche in virtù di tutto questo, laboratorio del presente, territorio incarnato della sperimentazione. Lo si è visto nel recente passato con le molte forme di auto-organizzazione e autogestione sorte fin dagli anni Novanta intorno all’esperienza dei Centri sociali, lo si vede, più prosaicamente, con il susseguirsi dei segnali che da questi territori muovono, ad esempio, alla conquista del mercato musicale. Come accade con la trap, forma meticcia e periferica cresciuta dentro la stagione della cultura hip hop, lambendo i canali dell’autoproduzione per arrivare al cuore delle majors. E tra i protagonisti di questo fenomeno, Achille Lauro, che ha portato l’immaginario tra il gangsta e l’iconoclasta del genere fin sul palco di San Remo, ha raccolto in una sorta di diario, Sono io Amleto (Rizzoli, pp. 255, euro 16,90) un itinerario personale atto ad essere però letto anche come una testimonianza generazionale. Cresciuto nella periferia orientale di Roma, tra zone popolari e nuovi insediamenti che evocano una middle-class resa incerta dalla crisi, tra Serpentara e Vigne nuove, passato per l’esperienza del Quarto blocco, il collettivo che riuniva al suo interno rapper, produttori, videomaker e grafici dell’ex Quarto municipio della capitale, per poi proseguire in solitaria accanto al producer Boss Doms, Achille Lauro racconta quella che potrebbe essere definita come la propria educazione sentimentale di strada. I «luoghi» sono onnipresente ma non raccontano solo territori grigi di cemento, ma ciò che vi alberga: rischi ma anche stimoli.
PER UNO DEI SUOI PRIMI DISCHI di successo, Ragazzi Madre, il musicista ha scelto non a caso di associare ad ogni brano un’immagine scattata da un fotografo documentarista sui quartieri di Roma dove è nato il concept dell’album; foto poi postate sulla sua pagina Facebook. L’argomento centrale sembra essere quello di associare alla durezza degli scenari urbani e della vita in periferia la forza dei sentimenti e dell’introspezione. Gli spazi metropolitani cresciuti a Roma oltre la città storica costruiscono propri linguaggi, stili, mode e talvolta finiscono per affermarsi fin dentro il mainstream del mercato musicale o tra i consumi giovanili. Del resto, taglia corto Achille Lauro, lo stile che accompagna la trap altro non è che «la moda periferica romana», il «coatto kitsch». Senza le pretese politiche di una parte almeno della scena hip hop degli ultimi decenni, oggi è la musica e la cultura giovanile delle periferie che domina la scena, invertendo almeno su questo terreno la polarità abituale delle città.
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento