I sommersi della Rete
Codici aperti Il web provocherà un’apocalisse sociale e culturale. Un sentiero di lettura a partire dal pamphlet di Jaron Lanier e dal saggio del docente del Mit Ethan Zuckerman
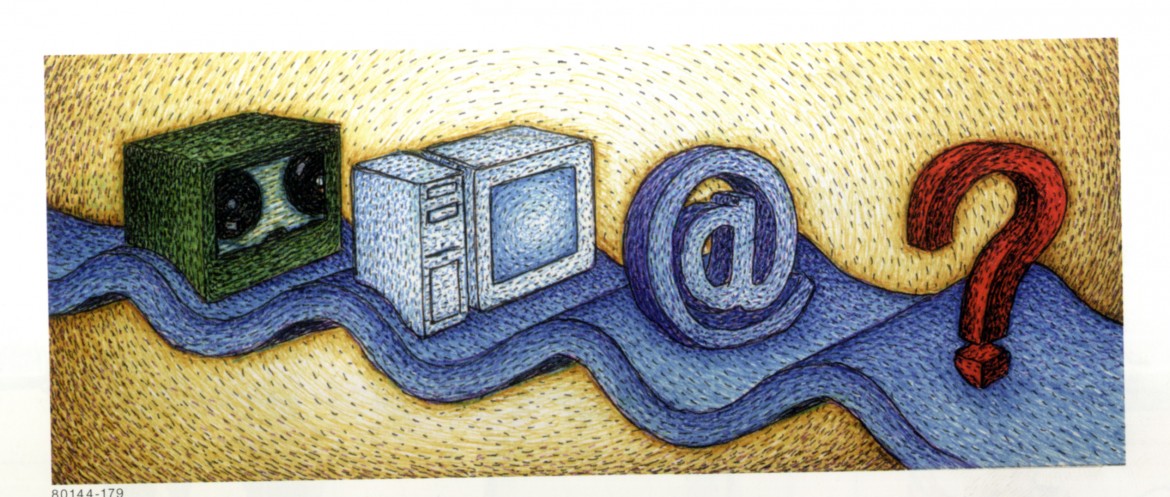 Immagine tratta da American Showcase
Immagine tratta da American ShowcaseCodici aperti Il web provocherà un’apocalisse sociale e culturale. Un sentiero di lettura a partire dal pamphlet di Jaron Lanier e dal saggio del docente del Mit Ethan Zuckerman
Il capitalismo rischia di crollare, seppellendo sotto le sue macerie la democrazia. Il tarlo che sta divorando le sue fondamenta è la cultura della gratuità egemone nella Rete. Le imprese che offrono servizi e contenuti nel web senza chiedere nessun compenso hanno un equivalente nella cancellazione di milioni di posti di lavoro in Europa e Stati Uniti. L’autore di queste affermazioni è Jaron Lanier, un ricercatore informatico che conosce bene la Silicon Valley. La risposta alle sue fosche previsioni arriva da poche centinaia di chilometri, da un luogo vicino a Boston simbolo al pari della valle californiana della cosiddetta «rivoluzione del silicio».
A fornirla è Ethan Zuckerman, docente dei media labs del Massachussets Institute of Technology, che guarda al web come un strumento utile alla diffusione di una attitudine democratica e cosmopolita che propedeutica alla crescita economica nel mondo. Sono autori di due volumi espressione di un ambivalente «spirito del tempo» che può tranquillamente salutare la Rete come la terra promessa e al tempo stesso considerarla un continente ormai saccheggiato e deturpato da novelli robber barons che, incuranti delle conseguenze delle loro scelte, stanno trasformando il pianeta in un incubo che annienta ogni possibilità di felicità. Le riflessioni di Lanier e Zuckerman non hanno nessuna pretesa di offrire una esaustiva analisi del mondo contemporaneo; piuttosto, sono da considerare come annotazioni su una realtà che sfugge a ogni interpretazione univoca. E come spesso accade ai libri che riflettono, come uno specchio, le ambivalenze della realtà, sono contraddistinti da una rinuncia a una loro rappresentazione critica.
Il ritorno degli hoboes
Jaron Lanier è noto nel mondo del web come pioniere delle ricerche sulle realtà virtuali, mentre Ethan Zuckerman è cofondatore di «Global Voice», uno dei forum più seguiti sulla cultura digitale. Entrambi hanno passato gran parte della loro vita connessi a Internet, ritenendo la Rete una delle nuove meraviglie del mondo moderno per la sua indubbia capacità di mettere in comunicazione uomini e donne. Nel 2007 la realtà ha però bussato alle porte delle loro case e dell’ingenua utopia che ha caratterizzato la loro giovinezza, in questi due volumi, ormai non c’è quasi più traccia. Gli Stati Uniti, paese dove vivono, ha visto le proprie città popolarsi di poveri e di uomini e donne che, come gli hoboes dei primi trenta anni del Novecento, girano il paese alla ricerca di qualche lavoro che consenta loro di sopravvivere. I luoghi simbolo della potenza economica americana sono stati infatti desertificati da spregiudicate strategie di imprese che hanno spostato, con l’attivo supporto dei vari governi, i loro siti produttivi in altri paesi.
Tutto ciò, nei due libri, costituisce l’ineludibile sfondo di un’analisi che trasuda un’amara disillusione. Certo, Ethan Zuckerman in Rewire (Egea edizioni, pp. 256, euro 26) continua a considerare Internet come l’habitat di una attitudine cosmopolita che come un virus continua a propagarsi per il mondo, anche se deve ammettere che le virtù democratiche della Rete sono più visibili al di fuori che non all’interno degli Stati Uniti, paese che ha visto dispiegarsi una capillare attività di controllo sulle comunicazioni on-line da parte delle agenzie di intelligence nazionali. Chi non nutre nessuna illusione sulle virtù salvifiche della Rete, invece, è proprio Jaron Lanier, che considera il pianeta sull’orlo di una apocalisse culturale e sociale. In questo La dignità ai tempi di Internet (Il Saggiatore, traduzione di Alessandro Delfanti, pp. 409, euro 22), lo ripete continuamente, come un mantra che dovrebbe allargare la coscienza: l’economia digitale produce disoccupazione e povertà.
In nome della creatività
Il disincanto di Jaron Lanier verso ogni lettura apologetica della Rete non è recente. Già negli anni passati aveva puntato l’indice contro la trasformazione di uomini e donne in gadget da vendere al mercato della pubblicità (Tu non sei un gadget, Mondadori). Altrettanto radicali sono state le sue critiche verso la pretesa da parte delle imprese di imporre standard nell’uso e nello produzione dei programmi informatici: standard che inibiscono processi innovativi e creativi nello sviluppo del software. In questo volume, la critica si concentra sulla cultura della gratuità egemone in Rete. Per il ricercatore informatico, questo significa la cancellazione di interi settori produttivi e l’appropriazione privata dei contenuti nonché di software innovativo prodotti dalla cooperazione sociale.
Il suo ragionamento si sofferma sul fatto che imprese come Google o Facebook, utilizzando software open source, offrono servizi e contenuti gratuitamente in cambio, però, di una cessione da parte dei singoli della proprietà sui propri dati personali, che vengono raccolti e memorizzati per essere successivamente elaborati e venduti ad altre imprese. L’essenza dei «Big Data» sta proprio in questo scambio luciferino: gratuità in cambio di rinuncia alle informazioni e contenuti prodotti dalle relazioni in Rete. L’effetto collaterale è la perdita di milioni di posti di lavoro. Lanier, che è anche un musicista, descrive la crisi verticale dell’industria discografica causata dalla pratica dello sharing (la condivisione di file musicali) e dal mancato pagamento del diritto d’autore agli artisti. Allo stesso modo indica nella possibilità di riprodurre all’infinito le immagini e nelle possibilità di fare foto con telefoni cellulari la leva che ha di fatto distrutto l’industria fotografica, terremotando l’intera filiera produttiva e trasformando in disoccupati i lavoratori impegnati nel settore.
Ma se questi esempi dell’economia «immateriale» sono ampiamente noti, altrettanto evidente è quanto accaduto nell’economia «materiale». Qui il nome simbolo degli effetti nefasti delle tecnologie digitali è Wal Mart, la catena di supermercati che vende e produce molti beni «tangibili», dall’abbigliamento all’elettronica di consumo e a molti altri manufatti più o meno tecnologici. merci non di qualità, ma vendute a poco prezzo. Wal Mart ha successo perché ha un pubblico in espansione costituito proprio da lavoratori che percepiscono bassi salari e impiegati impoveriti. Cioè quelle donne e uomini che la «rivoluzione del silicio» ha trasformato nell’esercito dei working poor. Sono i lavoratori dell’auto, dell’acciaio, delle costruzioni, del commercio, della sanità, dei servizi che hanno conosciuto le stigmate del decentramento produttivo – gran parte delle merci Wal Mart sono prodotti negli sweetshop asiatici, messicani e arabi – e del contenimento salariale che ha caratterizzato i trenta anni infausti della net-economy. E che hanno visto ridotti a cenere i diritti sociali conquistati nel lungo Novecento. Lavoratori e lavoratrici poveri come poveri sono i dipendenti di Wal Mart.
Jaron Lanier non è tuttavia ostile alla tecnologia ed è scettico verso una possibile decrescita più o meno felice. La sua «ricetta» per scongiurare l’apocalisse sociale e culturale che paventa è «in linea» con l’economia digitale. Propone infatti di remunerare ogni attività svolta in Rete, dalla consultazione di un sito, al messaggio inviato per commentare un prodotto o un «mi piace». La somma delle attività svolte on line consentirebbe l’accumulo di un reddito individuale per chi è disoccupato o una integrazione di reddito per chi percepisce un basso salario. Anche il consumo diviene produttivo: ogni volta che un film o un libro o un brano musicale viene visto, letto o ascoltato, il singolo ha diritto a un compenso, perché la visita di un qualsiasi sito alimenta il settore dei «Big Data».
Cittadinanze digitali
Il riconoscimento economico delle attività svolte in Rete ha come corollario una riabilitazione del diritto di autore, ricondotto, nello schema proposto da Lanier, alla sua natura originaria: diritto dell’autore ad essere retribuito per la sua opera e non diritto proprietario delle imprese. L’effetto indiretto è la ridefinizione di una cittadinanza dove il meccanismo di integrazione sociale non è data dal lavoro, bensì dalla connessione alla Rete.
Un’idea semplice a dirsi, ma difficile a farsi. Jaron Lanier non propone un modello sicuro di riuscita, ma è interessato ad affermare appunto il principio che la rete è un medium universale e contribuire alla sua valorizzazione economica, indipendentemente da ciò che si fa quando si è connessi, deve avere un corrispettivo monetario. Un punto di vista che ha fatto salire l’indice di gradimento di Lanier tra i gruppi di mediattivisti libertari tra le due sponde dell’Atlantico, propensi a limitare la loro critica alla net-economy in quanto tecnostruttura che ingabbia le potenzialità creative del singolo. Ma Lanier non è un mediattivista. Le sue tesi non vogliono certo trasformare la realtà, ma trovare il modo per una parziale redistribuzione della ricchezza che non modifichi i rapporti sociali dominanti: il suo obiettivo è, infatti, evitare il collasso del capitalismo – l’apocalisse annunciata con un tono blasé e vagamente messianico -, salvando e ricostruendo la «classa media», cioè la vittima sacrificale del capitalismo contemporaneo.
Qui serve un’opera di traduzione semantica: la classe media di questo volume non è il ceto medio europeo o i white collar di Charles Wirght-Mills, bensì la classe operaia, il lavoro vivo, il lavoro sans phrase di marxiana memoria. Già perché, ecco il paradosso della sua analisi, il capitalismo non ha, nel suo sviluppo, prodotto, secondo lo schema marxiano di critica dell’economia politica, il soggetto destinato a sovvertirlo: più semplicemente sta distruggendo proprio quel soggetto, trasformando tutti in una underclass che non ha capacità politica di fermare la distruzione delle basi materiali della ricchezza. Nella ricostruzione della «classe media» servono, e qui torna utile il saggio di Ethan Zuckerman, delle «figure ponte» animate da spirito xenofilo (la curiosità e la disponibilità verso l’altro) che mettono in rapporto mondi diversi e differenti. Sono cioè i «traduttori» di identità, di stili di vita, di regimi politici che inventano un nuovo cosmopolitismo e un regime di accumulazione della ricchezza che ha al centro il singolo, non più e non solo individuo proprietario, ma anche essere sociale che fa della sua partecipazione a una dimensione collettiva il suo tratto distintivo.
L’assenza del Politico
L’abbandono della giovanile e ingenua utopia sulla Rete come regno della libertà è però propedeutica allo sviluppo di una visione altrettanto ingenua, dove un ruolo centrale viene svolto dal mercato e dall’idea liberale che più si hanno informazioni più è possibile vivere in libertà. Le tesi dei due autori non sono robinsonate, come recitava il grande vecchio della critica all’economia politica quando analizzava gli studiosi del nascente capitalismo, ma poco ci manca. Oltre a una povertà e approssimazione analitica dei due volumi – elemento che contraddistingue più quello di Lanier che quello di Zuckerman – entrambe le analisi cancellano la dimensione del Politico, cioè dei rapporti e di esercizio di potere nel capitalismo contemporaneo. Sono libri sullo spirito dominante del tempo. Mettono sì in evidenza paradossi e contraddizioni della realtà contemporanea, ma non li interpretano. Né sono propensi a intraprendere l’esodo che, dopo aver attraversato il deserto del reale, riesca a dare forma alle ricchezze del possibile.
ABBONAMENTI
Passa dalla parte del torto.
Sostieni l’informazione libera e senza padroni.
Leggi senza limiti il manifesto su sito e app in anteprima dalla mezzanotte. E tutti i servizi della membership sono inclusi.
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento
