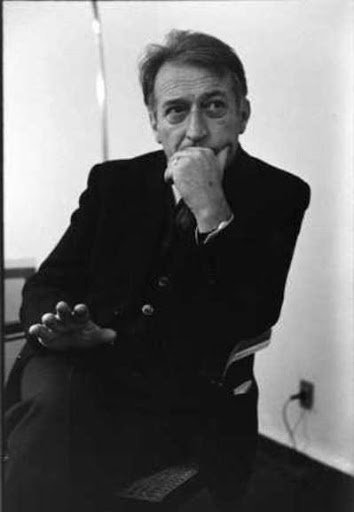
I bambini sono dei surrealisti in erba: poetica e pedagogia democratica di Rodari
Cosa succederebbe se a scuola (dalle elementari al liceo) e, persino, all’università si prevedesse un’ora di «Fantastica»? Un’ora, cioè, assai più libera e radicale del cosiddetto creative writing. Nel 1973 uscì per Einaudi la Grammatica della fantasia di Gianni Rodari ed eravamo ben distanti da una simile proposta che oggi – a oltre cinquant’anni dalla prima edizione, quando il libro ha ormai riscosso un successo planetario e le traduzioni sono fioccate dalla Francia al Giappone – appare attualissima e necessaria.
Vanessa Roghi in Un libro d’oro e d’argento Intorno alla Grammatica della fantasia di Gianni Rodari (Sellerio «la memoria», pp. 192, € 13,00) ricorda quanto la Fantastica – ovvero «l’arte di inventare», secondo il poeta romantico tedesco Novalis – possa essere uno «strumento politico», un momento di affermazione della coscienza civica per i bambini e per gli adulti. Proprio nelle prime pagine del saggio rodariano risuona con chiarezza l’obiettivo primario del suo metodo: «“Tutti gli usi della parola a tutti” mi sembra un buon motto, dal bel suono democratico. Non perché tutti siano artisti, ma perché nessuno sia schiavo». A lungo vagheggiata e sorta finalmente sotto gli auspici degli «Incontri con la Fantastica» tenutisi a Reggio Emilia nel 1972, la Grammatica della fantasia si giova di tre attrezzi fondamentali: l’errore creativo («sbagliando s’inventa»), il binomio fantastico e lo straniamento.
«Lo scontro di parole – osserva giustamente Roghi – diventerà il binomio fantastico, che della Grammatica della fantasia è, ancora oggi, uno dei capitoli più conosciuti e amati. All’inizio le parole da far scontrare sono (…) fiore e pista. Diventeranno, anni dopo, cane e armadio, per rendere più efficace quello “spaesamento sistematico” auspicato dall’artista surrealista Max Ernst». Scrive, a tal proposito, Rodari: «Occorre una certa distanza tra le due parole, occorre che l’una sia sufficientemente estranea all’altra, e il loro accostamento discretamente insolito, perché l’immaginazione sia costretta a mettersi in moto per istituire tra loro una parentela, per costruire un insieme (fantastico) in cui i due elementi estranei possano convivere». Il binomio fantastico è, per dirla con Lautrémont, un «fortuito incontro su un tavolo anatomico di una macchina per cucire e un ombrello».
Ma per «fare» in senso poetico bisogna avere, soprattutto, occhi sgombri, limpidi: lo straniamento di Viktor Šklovskij – ossia il «liberare le procedure del pensiero, liberare le parole dalle associazioni più ovvie e quotidiane» – può essere utile nel processo immaginativo. Il lavoro del poeta diviene così fonte di uno sguardo critico sul mondo: l’educazione linguistica coincide, quindi, con un’«educazione democratica». L’intuizione di fondo di Rodari è nel ritenere i bambini dei surrealisti in erba, legati sì al favolismo magico ma anche interamente capaci di cogliere la portata disgregante e corrosiva – sia sul piano linguistico che sul piano sociopsicologico – delle avanguardie di primo Novecento.
Non è un caso che Italo Calvino, dopo la morte dello scrittore di Omegna, valuti la Grammatica della fantasia come «un libro di pedagogia e di poetica da tener sempre presente: dico di poetica per pedagoghi e di pedagogia per poeti, pur che gli uni e gli altri siano privi di presunzione e fiduciosi e curiosi di “quel che può saltar fuori”. Le esemplificazioni degli esperimenti-giochi compiuti coi ragazzi sono piene d’interesse, perché i risultati sono sempre in qualche modo diversi dalle aspettative, in più o in meno, e sempre illuminanti».
In Un libro d’oro e d’argento Roghi sottolinea a ragione quanto la letteratura rodariana – profondamente permeata del pensiero di Gramsci, Piaget, Dewey, Jakobson, Eco – per troppo tempo sia stata recepita e considerata colpevolmente come «una letteratura di serie B». «Nuova forma di umiltà e di allegria», secondo Andrea Zanzotto, nell’opera di Rodari «dall’infanzia come nostalgia, regressione, irresponsabilità – evidenzia ancora Roghi – si volge all’infanzia come nucleo salvifico che, resistendo a ogni oltraggio, si dispone a crescere, a “rispondere per il futuro, anche se questo è indecifrabile come non mai”». La «Santa Infanzia» è il luogo in cui guardare la realtà in maniera differente, avverando il motto evangelico: «Se non cambiate e non diventate come i bambini…» (Mt. 18,3).
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento
