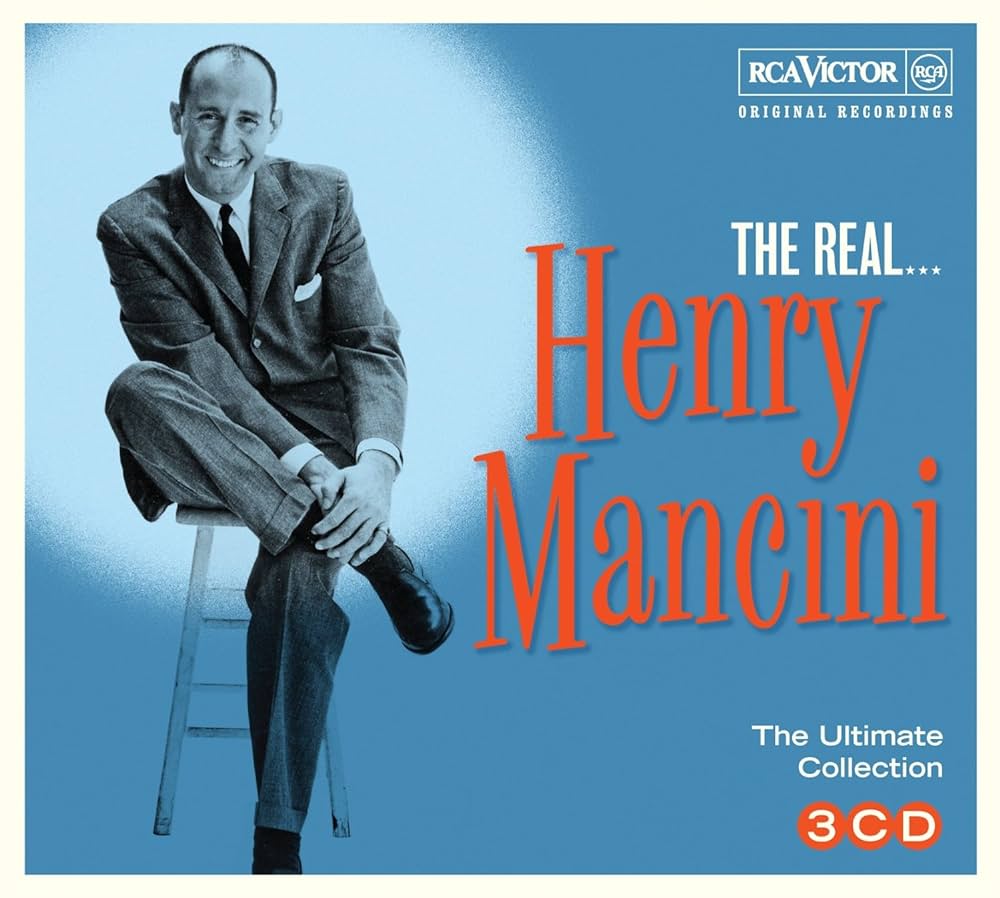
Henry Mancini, infallibile «easy»
Nell’immaginario collettivo il nome di Henry Mancini evoca immagini sonore in cui la leggerezza compositiva si coniuga a una forma che è strettamente legata alla sua formazione musicale. Mancini portava inoltre in sé un pezzo importante di Italia poiché le sue origini erano aquilane e questo affiorava nella sua incredibile duttilità nello scrivere melodie aperte. Enrico Nicola Mancini, questo il vero nome, era nato a Cleveland il 16 aprile 1924. Quello che è interessante di questo personaggio unico della musica applicata è che egli ben presto seppe come incantare il pubblico pagante con una forma che stava fra Giacomo Puccini e Duke Ellington.
ALLA JUILLIARD
Infatti questa incredibile mistura gli permise di avere successo come uno dei più ricercati e raffinati melodisti. Non solo di canzoni ma anche e soprattutto di musica applicata al cinema. Sarà stato anche che in quel mix di competenze musicali Mancini ci metteva tanto della sua formazione che nasceva proprio dall’apprendistato nel fare qualsiasi tipo di arrangiamento jazz e questo gli tornò utile quando dovette avere a che fare con le grandi produzioni orchestrali. Ma certamente è l’aver frequentato la Julliard School of Music di New York che gli darà il viatico per entrare con tutti i diritti nel mondo della musica da professionista.
Tenendo conto che l’iniziale studio del pianoforte gli pernetterà di esprimere due attitudini importanti, ossia l’ottima lettura a prima vista e una incredibile capacità di manipolare qualsiasi composizione classica per trasformarla in una elaborazione improvvisata in uno stile estremamente personale. Le qualità pianistiche verranno poi testimoniate in alcuni lp che lo videro protagonista ad esempio con il flautista James Galway. Ma tornando a New York, Mancini venendo dalla provincia si ritrova in un mondo incredibilmente musicale dove non manca la frequentazione della mitica Broadway con i suoi musical. L’incontro che gli cambierà indelebilmente la vita sarà con un compositore italiano emigrato durante il fascismo negli Usa perché ebreo. Ed era veramente un grande maestro Mario Castelnuovo Tedesco che gli americani seppero accogliere rispetto alla sua patria d’origine che si mostrerà sempre ambigua verso le sue qualità compositive tanto da giocargli un brutto scherzo per una prima alla Scala che mai avvenne per invidie interne al mondo musicale meneghino (esecuzione dovuta poiché egli risultò vincitore del Premio di composizione Campari).
Ebbene Mancini strinse ottimi rapporti con Castelnuovo Tedesco che insegnava privatamente negli anni newyorkesi prima di trasferirsi a Los Angeles. Non abbiamo molta documentazione che attesti questo rapporto ma è certo che in qualche modo Mancini come molti suoi futuri colleghi quali John Williams e Jerry Goldsmith si formò alla scuola compositiva del maestro toscano che nel suo lungo soggiorno a Los Angeles ebbe modo di insegnare composizione presso il locale conservatorio divenendo un punto di riferimento per le major del cinema poiché oltre a prestare la propria opera compositiva formò una discreta parte di giovani compositori che furono subito assoldati nel mondo della musica cinematografica.
Mancini ebbe modo di ringraziare sempre la formazione con il maestro italiano. La guerra lo allontanò dagli studi musicali poiché si arruolò nelle Forze Aeree degli Stati Uniti, le stesse che avevano al loro interno Glenn Miller, la vera colonna dello swing della prima generazione che grazie alle sue big band riuscì ad alleggerire gli animi degli americani durante gli anni della seconda guerra mondiale. Fu proprio Miller che, conosciuto Mancini, lo fece entrare nella ventottesima banda dell’aereonautica. Mancini non mancò di essere sul campo partecipando ad esempio alla liberazione dei campi di concentramento di Mauthausen e Gusen in Austria. I rapporti con Miller gli permisero di entrare di diritto, dopo la morte del trombonista, nella formazione della Glenn Miller Orchestra dove occupò il ruolo di pianista ed arrangiatore sotto la direzione di Tex Beneke. In questo periodo riprende i suoi studi musicali precocemente interrotti con Mario Castelnuovo Tedesco e con Ernst Krenek, altra figura importante della composizione contemporanea.
Mentre cerca di mantenere l’impegno con la Glenn Miller Orchestra riesce anche a partecipare a un concorso per la Universal Pictures e quindi entra come compositore, arrangiatore e direttore di numerose produzioni. I suoi primi film a cui presta la sua opera sono Il capitalista di Douglas Sirk, Sally e i parenti picchiatelli, La grande sparatoria o La città sommersa fino al grande successo che gli varrà la prima candidatura all’Oscar nel 1955 con le musiche e gli arrangiamenti per La storia di Glenn Miller di Antony Mann doveroso e romanzato tributo al musicista prematuramente scomparso. Nello stesso anno scrisse musiche e arrangiamenti per Il re del jazz, il film sul clarinetista Benny Goodman. Nel 1958 è importante l’incontro con Orson Wells per il quale scrive le musiche de L’infernale Quinlan che mettono in mostra le doti di sintesi classico/jazzistica di Mancini.
LA GRANDE SVOLTA
Il 1959 è un anno importante per il compositore poiché incontra colui con il quale percorrerà un bel pezzo di vita artistica: il regista Blake Edwards per il quale firma le musiche dello scanzonato Operazione sottoveste e per In due è un’altra cosa. E così fino al 1961, anno della grande svolta con uno dei temi più famosi della storia della musica cinematografica, Moon River, brano di riferimento di Colazione da Tiffany, film diretto da Edwards con una incantevole Audrey Hepburn.
Ovviamente vince l’Oscar per la migliore canzone e per l’intera partitura che rimane un segreto di equilibrio ad uso di tutti i remix degli anni duemila. L’anno dopo e sempre con Edwards vincerà ancora un Oscar per Days of Wine and Roses, tema dell’omonimo film, I giorni del vino e delle rose. Oramai Mancini è diventato il divo della musica easy statunitense, è ricercato per la sua unica scrittura musicale, compone per Hatari!, il film di Howard Hawks, ancora per Edwards (Operazione terrore) e nel 1963 scrive un’altra pietra miliare che è la partitura per Sciarada di Stanley Donen con un perfetto Cary Grant e l’altrettanto perfetta Audrey Hepburn. Mancini vince l’Oscar per la migliore canzone. In seguito una carrellata di ottime partiture per film come Arabesque, Peter Gunn: 24 ore per l’assassino, Hollywood Party. Nel 1970 incontra Vittorio De Sica che gli affida la scrittura della musica per uno dei suoi film più intensi, I girasoli.
Nel 1972 compone anche per Frenzy di Hitchcock ma poi, come succedeva con il regista inglese, la partitura non venne utilizzata per essere affidata a Ron Goodwin. E a chiudere il titolo che lo consegna alla storia della musica da cinema e non solo: The Pink Panther Theme, il tema del film La Pantera Rosa, diretto da Edwards e divenuto, a partire dal 1963, una vera saga cinematografica. Grazie alle musiche di Mancini e a Peter Sellers, il personaggio di Clouseau verrà ripreso negli anni fino al 2009, in tutto undici film.
Nel ’93 uscirà Il figlio della Pantera Rosa, ultimo di otto capitoli della saga originale, tutti diretti da Edwards con musiche dello stesso Mancini. In mezzo L’infallibile ispettore Clouseau?, regia di Bud Yorkin, interpretato da Alan Arkin nel ruolo di Clouseau e musiche di Ken Thorne. Anche se ricorrono alcuni personaggi della saga della Pantera Rosa, la pellicola non fa parte della serie originale. Dopo aver vinto nell’83 l’ultimo oscar per Victor Victoria, diretto sempre da Edwards, l’artista muore a Beverly Hills il 14 giugno 1994.
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento
