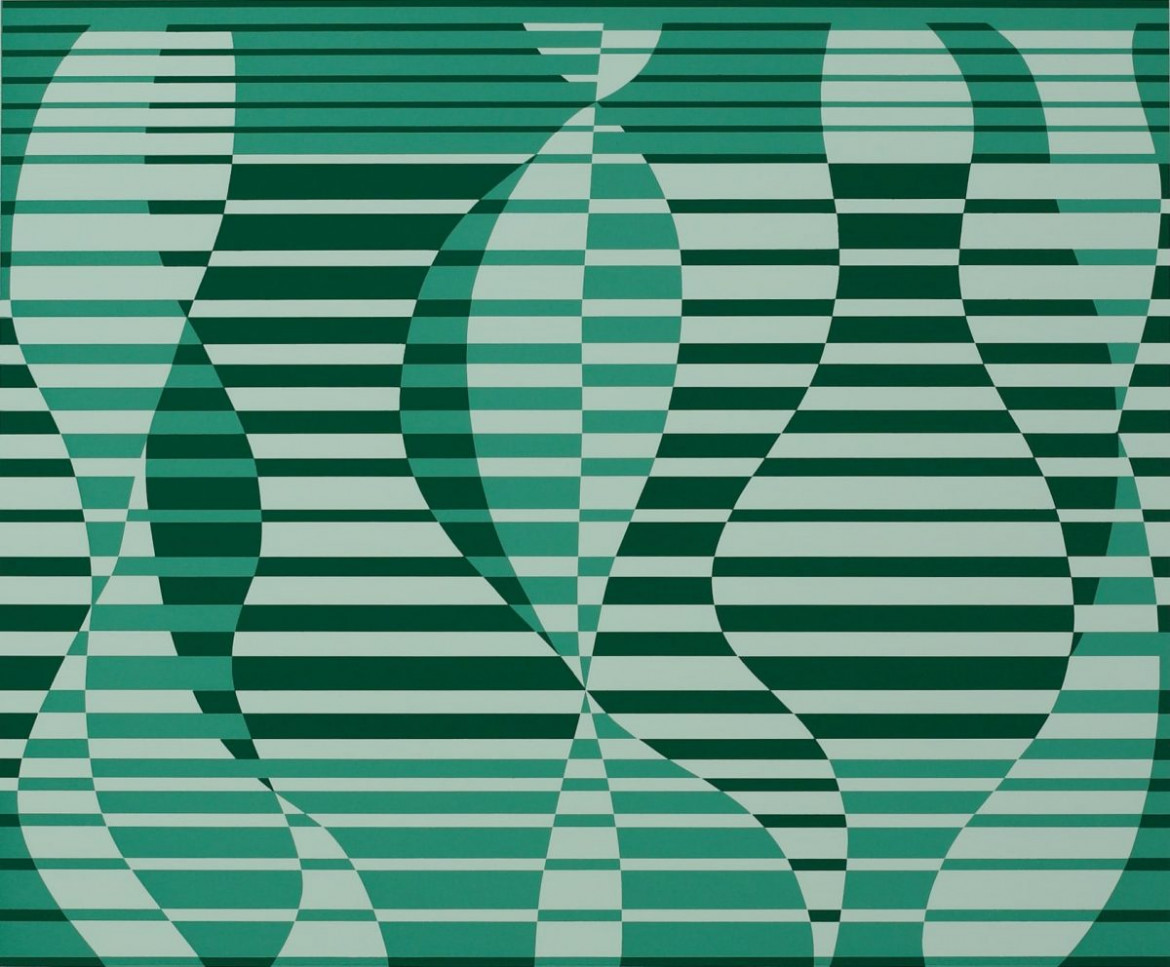
Heidegger, ciò che resta nascosto nei dati di fatto
Con concisa drammaturgia antonimica Heidegger ci immette nell’officina di una svolta filosofica, dove è in corso il montaggio del suo più peculiare dispositivo teorico, l’articolazione tra inizio del filosofare e fine della metafisica all’insegna della domanda sulla verità dell’essere: «Il nostro compito: l’interruzione del filosofare? Ovvero la fine della metafisica… Vogliamo andare alla ricerca dell’inizio della filosofia occidentale».
Nell’annunciare questo compito epocale il professore ha di fronte gli allievi dell’Università di Friburgo, corso estivo del 1932: come di consueto, lo ha interamente manoscritto sulla parte sinistra di fogli orizzontali, lasciando la destra per aggiunte e osservazioni. A dieci anni dall’edizione tedesca, il corso esce ora in Italia da Adelphi – Martin Heidegger, L’inizio della filosofia occidentale Interpretazione di Anassimandro e Parmenide, a cura di Peter Trawny, edizione italiana a cura di Giovanni Gurisatti, Adelphi, pp. 313, euro 42,00).
Il problema della traduzione
Il perimetro geo-filosofico del corso ottiene subito una sintetica descrizione: Occidente, oltre che geografico, è concetto storico «che intende la storia e la civiltà dell’Europa attuale, cominciata con i greci, e soprattutto con i romani, il cui sviluppo fu essenzialmente determinato dal cristianesimo ebraico». Non una parola sul «rischio di annientamento» che caratterizzerà solo tre anni più tardi la celebre diagnosi di Introduzione alla Metafisica, quando Heidegger vedrà l’Europa – popolo tedesco in primis – stretta nella morsa dei «popoli senza spirito», Russia e America, che rappresentano «la medesima desolante frenesia della tecnica scatenata e dell’organizzazione senza radici dell’uomo massificato».
Il corso del 1932 si tiene entro i confini della civiltà filosofica europea, la quale alloggia tuttavia una morsa forse anche più insidiosa: non solo «Romanità, ebraismo e cristianesimo hanno completamente mutato e falsificato la filosofia degli inizi, cioè la filosofia greca», ma proprio dai giganti di questa ha preso avvio quella dimenticanza dell’essere che Heidegger chiama «storia della metafisica». Dai primissimi anni Trenta, ha infatti intestato a Platone l’allontanamento dall’esperienza originaria della verità: la trasformazione di a-letheia (dis-velatezza) in conformità e correttezza avrebbe aperto la strada alla carriera dell’oggettività e in ultima analisi al dispiegamento moderno della tecnica. La ricerca deve dunque retrocedere verso l’aurora del pensiero greco e il suo «inizio più iniziale».
E l’intento non è certo ricostruttivo o storiografico: Heidegger ha di mira un’alternativa al destino storico dell’Occidente o, come più tardi si esprimerà, «ri-petere l’inizio…per trasformarlo in un altro inizio».
Data da questo corso – se si eccettuano pochi cenni precedenti – quel confronto con Anassimandro e Parmenide che diventerà insistente e quasi ostinato a partire dagli anni Quaranta. Unicamente in questo caso, tuttavia, Heidegger fornisce una traduzione integrale dei frammenti greci – il detto di Anassimandro, il poema didascalico di Parmenide – procedendo passo dopo passo, dando ragione dei singoli elementi, poi dell’intera frase, quindi del lascito completo, con un andamento pedagogico inusitato che non ripeterà.
Un intero linguaggio vede la luce. Termini chiave della tradizione filosofica (logos, physis, aletheia, chronos, archè), incalzati da un domandare radicale, ricompaiono trasformati, convertiti in «agenti dell’essere». Allo smascheramento del vocabolario metafisico insinuato nel tessuto greco – per la dike di Anassimandro «tutte le accezioni comuni di diritto, giudizio, punizione, ritorsione vanno accuratamente evitate»; la resa di telos con scopo «si adatta forse alla genesi biblica e alla dogmatica cristiana ma non alle asserzioni fondamentali della filosofia antica» – corrispondono espressioni inaudite, esito di un combattimento estremo con la lingua tedesca.
Heidegger riprenderà più volte queste traduzioni, le modificherà, giungerà a ritenere spurio tale o tale frammento, e di concerto continuerà anche a modellare una teoria della traduzione, che qui fa il suo esordio: «la traduzione è sempre il risultato e la sintesi ultima di un’interpretazione; non è mai un mero sostituirsi di una lingua straniera alla lingua materna, poiché presuppone la capacità di tra-dursi, con la forza originaria della propria lingua, nella realtà del mondo che si manifesta nella lingua straniera.» La portata di una traduzione, in altri termini, non è mai tecnica, ma investe il rapporto dell’uomo con l’essenza della parola e del linguaggio; il suo traguardo non consiste nel rendere accessibile un testo adattandolo all’orizzonte di comprensione corrente, ma nel salvaguardarne la distanza epocale e persino l’estraneità. Ma come accedere alla verità della filosofia degli inizi se ciò che esprime è divenuto inaccessibile? A una Considerazione intermedia – speculativamente impegnativa – Heidegger riserva il compito di affrontare le condizioni di possibilità del suo proposito. Si ritrovano qui le sue osservazioni peculiari sulla grande illusione insita nel rapporto dell’uomo con la storia e sui limiti costitutivi della storiografia scientifica basata sui dati di fatto. «Non v’è arte dell’interpretazione che ci consenta di superare l’abisso dei millenni…Dobbiamo imparare a capire che nel nudo dato di fatto della storia, l’essenziale rimane nascosto». I dati di fatto non si esauriscono in ciò che vi constatiamo, ma conservano una riserva d’essere che può ancora essere interrogata.
La portata della sfida
Che ne è di questa domanda? E chi la pone? Al culmine di un’estesa disamina del domandare, Heidegger riconosce la domanda dell’essere come quella destinale dell’uomo, ma perciò anche la più dimenticata. L’oblio dell’essere è infatti radicato nel nostro modo di esistenza, in quel Dasein che qui Heidegger chiama insistenza, poiché si rapporta sempre solo all’ente, a quanto ci sta sottomano, e non si preoccupa dell’essere. Che non può venire trovato lì davanti, come fosse un ente tra gli altri. Va cercato, interrogato per se stesso.
L’intera sfida della Considerazione pare consistere nel restituire all’essere il suo carattere problematico, degno di interrogazione. È lo stesso Heidegger a rimarcare che questa prospettiva si lascia alle spalle l’analitica di Essere e Tempo nella misura in cui non è più una filosofia dell’esistenza, al pari di quelle di Kierkegaard e Jaspers – da cui si congeda – ma una filosofia dell’essere in quanto tale. La formulazione cui approda – «Esistenza è l’essere dell’ente che noi stessi siamo» – sottrae la domanda dell’essere alla distanza storica e la posiziona «massimamente vicina» alla nostra esistenza, pronta ad essere dis-velata e a ri-petere l’inizio.
Chi abbia l’iniziativa di questa domanda fatale – se l’essere stesso nella sua dinamica storica di presenza e scomparsa, oppure «noi uomini d’oggi», da intendersi come il compito destinale del popolo tedesco, sarà chiaro – ahimè – di lì a pochi anni.
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento