Genocidio armeno, la memoria ritrovata narrando la propria storia
Percorso di letture I sogni interrotti e la determinazione di un popolo attraverso le mille voci della diaspora. Come per «La masseria delle allodole» di Antonia Arslan, il romanzo che meglio ha raccontato la tragedia, è spesso il riemergere dei ricordi famigliari che spinge verso la ricerca della verità
 Un'immagine da "La masseria delle allodole", diretto nel 2007 dai fratelli Taviani
Un'immagine da "La masseria delle allodole", diretto nel 2007 dai fratelli TavianiPercorso di letture I sogni interrotti e la determinazione di un popolo attraverso le mille voci della diaspora. Come per «La masseria delle allodole» di Antonia Arslan, il romanzo che meglio ha raccontato la tragedia, è spesso il riemergere dei ricordi famigliari che spinge verso la ricerca della verità
«Sono loro, i miei padri e madri, che emergendo da un pozzo profondo mi hanno narrato la loro storia e io mi sono seduta, un giorno di maggio, ad ascoltare e a scrivere. Ed è stato come intessere un tappeto». È dando voce a una memoria lungamente rappresa, conservata gelosamente in seno alle famiglie della diaspora, in Italia come nel resto del mondo, consultata a piccole dosi per lenire il doloroso silenzio di una perdita senza evocare fino in fondo l’orrore di cui quella ferita personale è solo un tragico frammento, che Antonia Arslan ha composto La masseria delle allodole, il romanzo che più di ogni altro ha saputo narrare la storia del genocidio armeno.
PIÙ DI UN MILIONE e mezzo di vittime, uccise a partire dal 24 aprile del 1915 quando su decisione dei Giovani Turchi, alla guida dell’Impero ottomano, a Costantinopoli furono arrestati i leader della comunità, tra loro anche diversi giornalisti, scrittori e poeti. Per i quattro anni successivi, nelle città come nei piccoli centri dell’interno dell’Anatolia, i soldati turchi uccisero sistematicamente tutti gli uomini e i bambini maschi, deportando donne e bambine verso il deserto siriano attraverso marce della morte accompagnate da ogni sorta di violenza.
L’obiettivo dichiarato era cancellare la presenza armena dalla società turca e rendere il Paese «omogeneo» dal punto di vista etnico, culturale e religioso, annullando così oltre mille anni di storia comune. Secondo il Patriarcato armeno di Costantinopoli, nel 1914 gli armeni in Turchia andavano da un minimo di 1 milione e 845mila ad un massimo di 2 milioni e 100mila, in pochi riuscirono a mettersi in salvo. Un crimine di cui la Turchia non ha soltanto mai riconosciuto la responsabilità, ma di cui oggi nel Paese è impossibile parlare per legge.
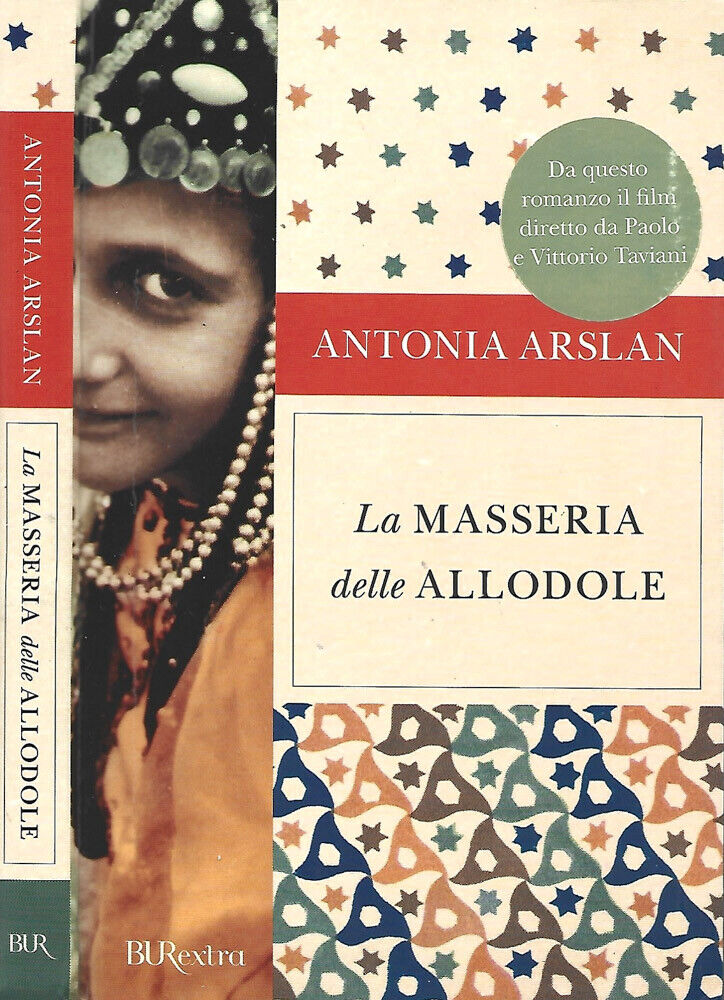
In La masseria delle allodole, portato sul grande schermo dai fratelli Taviani nel 2007, l’autrice racconta la genesi delle stragi a partire dalla condizione della propria famiglia d’origine, gli Arslanian, che alla notizia dell’inizio delle persecuzioni si rifugia in una residenza di campagna sperando di sfuggire alla furia omicida dei turchi. Così non sarà. All’arrivo di soldati, e dei banditi che si erano uniti a loro, tutti gli uomini saranno uccisi sul posto, mentre per le donne si aprirà la pagina drammatica della marcia forzata verso il deserto. Solo alcune donne riusciranno a sottrarsi a questo tragico destino ma, scrive l’autrice alla fine dell’opera, «nessuno farà più ritorno in quel luogo». Del resto, si legge ancora nel romanzo, «in quella lontana, solare giornata di maggio lei e i suoi famigliari, piccoli e grandi, tutti sono stati giudicati, e trovati colpevoli di esistere; e Dio si è velato».
Il percorso di Arslan nella memoria ritrovata degli armeni è inoltre affine a quello di altri scrittori che sono cresciuti in famiglie dove l’eco della tragedia poteva inaspettatamente irrompere nel tran tran domestico.
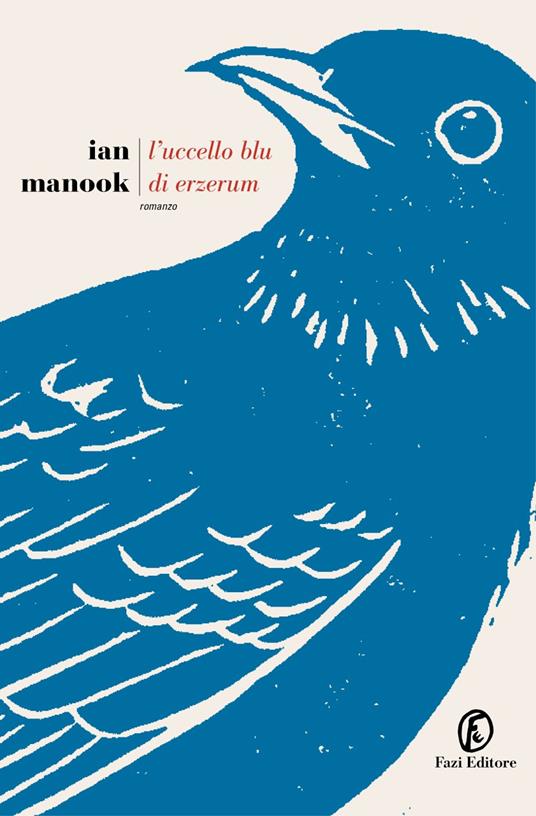
Un libro che, al di là della costruzione narrativa, spinge il lettore a misurarsi con il male assoluto che prese forma in quella vicenda. «Non volevo soltanto che questo romanzo evocasse il genocidio armeno ma che, per quanto possibile attraverso le parole, raccontasse davvero cosa è successo allora, ciò che mia nonna e altri parenti mi hanno raccontato nel corso degli anni. Perciò, le prime sessanta pagine spiegano cosa accadde, come gli armeni furono uccisi subito o deportati per essere eliminati lungo il viaggio o fatti morire una volta giunti a destinazione. Volevo mostrare concretamente l’orrore assoluto del genocidio. Volevo che si capisse come, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese, fu organizzato e messo in pratica il martirio di un popolo».

OLTRE AGLI STUDI che negli ultimi anni hanno iniziato a colmare il lungo vuoto che si era registrato intorno alla tragedia degli armeni, anche alcune opere narrative stanno contribuendo a far conoscere le forme e i numeri del genocidio. Se I quaranta giorni del Mussa Dagh di Franz Werfel (Mondadori, 2021), pubblicato la prima volta nel 1933, narra la storia di Gabriel Bagradian, un armeno da tempo stabilitosi in Francia che all’epoca si trovò a misurarsi con l’inizio della repressione turca e guidò un gruppo di resistenti che agivano intorno al monte Mussa Dagh, Il libro dei sussurri di Varujan Vosganian (Keller, 2011) ci porta nel cuore della piccola comunità armena di una cittadina della Romania dove emergono, attraverso i dialoghi e il confronto tra i personaggi, i fantasmi della violenza subita in Turchia e la necessità dell’esilio.
Infine, in La restauratrice di libri di Katerina Poladjan (Sem, 2021) ripercorre la storia del genocidio e la diaspora del popolo armeno attraverso le vicende di una giovane restauratrice di libri tedesca che a Erevan, la capitale dell’odierna Repubblica armena, si imbatte in un testo antico che, passato di mano in mano da una generazione all’altra, è appartenuto ad una famiglia che aveva cercato rifugio sulla costa del Mar Nero. Dentro quel libro, gli armeni in fuga avevano continuato, nonostante tutto, a conservare la propria casa e forse la propria «patria».
Del resto, come ricorda Antonia Arslan nel suo celebre romanzo, nelle famiglie armene, si trasmette «l’eco vivente di odori e sapori, un nutrimento vero, la nascita della nostalgia (per un Paese che non esiste più, per le colonne dei deportati, per una famiglia morente sotto il sole velenoso, per le tombe sconosciute lungo le polverose strade e i sentieri d’Anatolia… ma anche per tutto ciò che scomparve con loro di vivo e odoroso, di fatica e di gioia, di pena e di consolazione: l’anima del Paese».
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento