Da Mauss a Amselle, chiavi per decostruire il concetto di identità
Alfredo Salsano Da vero intellettuale, aprì orizzonti nuovi nell'editoria e ebbe un gran coraggio pubblicando anche libri come quella che oggi è considerata la Bibbia dell'antropologia contemporanea, «I frutti puri impazziscono» di James Clifford
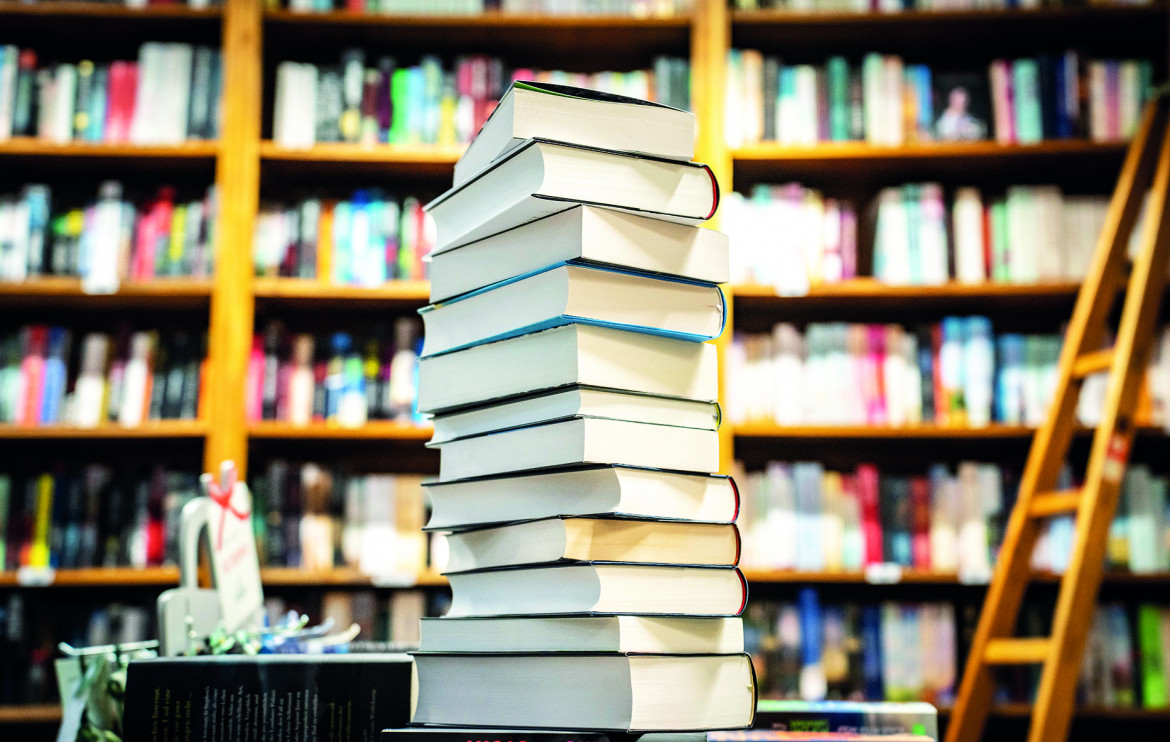 Foto Ap
Foto ApAlfredo Salsano Da vero intellettuale, aprì orizzonti nuovi nell'editoria e ebbe un gran coraggio pubblicando anche libri come quella che oggi è considerata la Bibbia dell'antropologia contemporanea, «I frutti puri impazziscono» di James Clifford
Sono ormai passati più di venticinque anni, ma mi ricordo bene la prima volta che incontrai Alfredo Salsano. Era nel suo studio alla Bollati Boringhieri, io dovevo intervistare Serge Latouche e già questo mi metteva una certa soggezione, l’essere in una casa editrice così prestigiosa aumentava quella sensazione, ma non so perché, il sorriso burbero di Alfredo in qualche modo mi tranquillizzò. Terminata l’intervista, rimanemmo a chiacchierare di antropologia, in particolare di Marcel Mauss e di Karl Polanyi e di come si poteva leggere l’economia con altre chiavi.
Da qualche anno, aveva avviato una linea editoriale, che tassello dopo tassello mirava a fornire strumenti di lettura diversi e alternativi alla visione utilitarista dominante. Per questo era interessato all’antropologia. Ci incontrammo più volte a chiacchierare, finché un giorno mi disse: «Suggeriscimi un classico moderno da tradurre».
UN OSSIMORO, INSOMMA. Bel problema. Ci pensai un po’, poi proposi Logiques métisses di Jean-Loup Amselle. Erano gli anni in cui il concetto di «identità» era centrale nel dibattito antropologico e la decostruzione di Amselle mi sembrava adatta. Devo dire che ancora oggi sono stupito della fiducia che un grande esperto del mondo editoriale e culturale concendesse a uno sconosciuto come me, ma era nata una simpatia reciproca e questo, forse, lo rassicurava.
AL PUNTO che mi chiese di tradurre il testo e di fare l’introduzione! Io non avevo pubblicato ancora nulla all’epoca. Il libro fu un successo e Amselle entrò a far parte del catalogo Bollati Boringhieri.
Salsano era incuriosito dall’antropologia, ne intravvedeva le potenzialità per una lettura diversa della realtà. Ci era arrivato attraverso la sua profonda conoscenza del pensiero socialista, e lo studio di Polanyi, il tutto finalizzato a rimettere in discussione il modello di sviluppo e la prospettiva economicista, che monopolizzano il pensiero occidentale. Non a caso era stato proprio Marcel Mauss, autore del Saggio sul dono (1922) il trait d’union a portarlo verso le discipline antropologiche. Ripropose, infatti, una nuova edizione del classico dei classici, quell’Argonauti del Pacifico occidentale di Malinowski, in cui lo scambio di oggetti diventa motore di relazione. Fu poi la volta di Marc Augé, Marcel Griaule, Michel Leiris, Francesco Remotti in un alternarsi di classici e di moderni dell’antropologia culturale, al punto di far diventare la sua casa editrice un punto di riferimento. Cercava, nel panorama antropologico, un supporto culturale ed etnografico a quella griglia interpretativa che voleva costruire attraverso i libri che pubblicava.
BISOGNA GUARDARLA ORA, a distanza, per capirne la coerenza, il carattere innovativo, controcorrente e talvolta provocatorio. In questo va riconosciuta la sua capacità di promotore culturale. Fu anche capace di un’operazione coraggiosa come la pubblicazione de I frutti puri impazziscono di James Clifford, una sorta di Bibbia dell’antropologia contemporanea, ma non certo un libro facile. Ricordo che, a proposito di questo libro, mi disse: «So che venderà poco, ma voglio averlo in catalogo». Questo era Alfredo Salsano, un misto di lungimiranza e di passione, un grande intellettuale, che preferiva stare dietro le quinte, mandare avanti altri.
Un giorno, dopo una delle solite chiacchierate, andammo al bar a bere qualcosa e non so come, gli raccontai in modo scherzoso qualche aneddoto sul rapporto tra i Dogon del Mali e i turisti. «Perché non ci fai un libretto?».
Rimasi fulminato: da mesi cercavo un’idea forte da proporgli, per pubblicare con una casa editrice come la sua e lui, così, semplicemente, mi dice «scrivimelo» sulla base di qualche battuta. Iniziò così, nel 2000 il mio rapporto di autore con la Bollati Boringhieri, che dura tutt’oggi.
IL CORAGGIO, questa era un’altra grande dote di Alfredo, un coraggio che ha dimostrato più volte, uscendo dagli schemi, proponendo autori e temi fuori dagli schemi, aprendo orizzonti nuovi. E l’umiltà era l’altra grande sua caratteristica: lo ammetto anche io ho imparato poco a poco a scoprire la sua vasta e profonda cultura e ho dovuto farlo da solo. Da lui mai una parola su di sé. Ancora oggi, se ci ripenso, mi chiedo quale coraggio abbia avuto a proporre a uno sconosciuto come me di entrare a far parte della sua squadra. Non ho la risposta, ma non smetterò mai di ringraziarlo.
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento