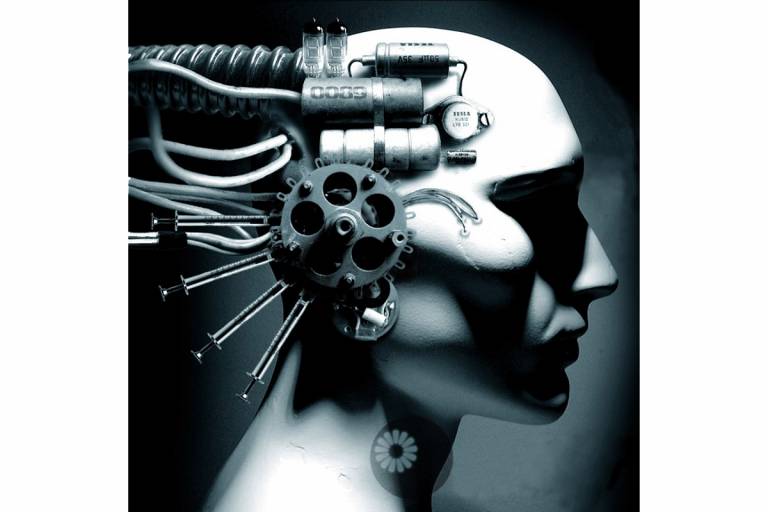
Brevi storie non umane
Sulla tristezza che deriva dalla separazione dell’umanità dal mondo sappiamo quasi tutto dai pensieri che Anna Maria Ortese ci ha lasciato scritti concisamente e che Adelphi ha raccolto in volumetti azzurrini. Ed è stata Clarice Lispector a svelarci le conseguenze inarginabili dell’incontro con l’altro da sé – la «blatta così vecchia da essere immemorabile» che fa da contrappunto alla voce in quello specchio deformante che è La passione secondo G.H., romanzo pubblicato per la prima volta in Brasile nel 1964 che si esaurisce nel giro di poche pagine, ma la cui eco sembra destinata a durare per sempre. Forse è proprio la brevità la cifra adatta a descrivere il nostro rapporto con la materia inumana, se le scrittrici di oggi continuano a indagare questo nodo soprattutto nel racconto, come se fosse specialmente negli spazi stretti che tutto quello che non siamo potesse innestare una generazione di senso.
NON SI TRATTA PIÙ soltanto della voce di una vecchia zia, arrivata nel cuore della notte ad avvisare il nipote che schiacciare uno scarafaggio con la suola delle scarpe sul pavimento della cucina innescherà il pericoloso meccanismo dell’invasione, come accadeva nel Bestiario sentimentale della messicana Guadalupe Nettel. E nemmeno di come, nel mezzo di una lite familiare, un bambino possa immaginare che le sue dita mutilate da un banco Piranha durante un bagno al fiume possano presto rinascere dalle ferite, come succedeva in uno dei racconti di Persone care, dell’uruguaiana Vera Giaconi.
A coltivare il discorso sono adesso le scrittrici giovanissime, che si passano lo spago di un ripiglino letterario a più mani, situandosi in maniera trasversale su uno spettro che sa spingersi indietro fino al Frankenstein di Mary Shelley, per caricarsi a molla e correre dritto avanti, oltrepassare Black Mirror. Nelle voci di queste autrici, nate negli anni ‘80 e ’90 nell’emisfero boreale, tutto quello che non siamo non è più, non soltanto, la natura – animale o minerale – ma sta insieme in un continuum alle nostre invenzioni artificiali, meccanismi che senza preavviso ci sfuggono.
AVVIENE COSÌ nella raccolta di Frances Leviston, La voce dentro (NN, pp. 256, euro 19, traduzione di Ada Arduini), dove le protagoniste dei dieci racconti hanno tutte lo stesso nome. Leviston è nata a Edinburgo nel 1982, le vicende che narra sono ambientate nell’Inghilterra di oggi, eppure il tono è quello che le bambine di fine Novecento immaginavano avessero le storie, seduttivo come solo la letteratura ottocentesca sapeva essere, di una vividezza sensuale e intima, che ci trascina dentro case e situazioni, a cui è impossibile resistere e da cui si fatica a congedarsi.
Qualcosa in grado di lasciare il margine dopo pochi attimi a uno stridente sentore di nostalgia, «il sibilo di un canale aperto che ti riempie la testa» con cui la raccolta si apre, un’interferenza a metà tra il ronzio di un insetto e un acufene che andrà a mescolare le immagini fantastiche ai nostri ricordi veri.
La persona che la incarna si chiama sempre Claire, in un certo senso ha la forma di un tulipano ma potresti essere tu, potrebbe essere chiunque «la sua interfaccia, è piccola piccola, mentre l’interno è sorprendentemente grande». Leviston fa emergere e strisciare questa voce aliena in superficie, dentro scene apparentemente rassicuranti che puntualmente vengono crepate da creature semi-organiche – robot di nome Patience venute a illuminarci sul futuro della cura, vecchie Singer anni Settanta utili a scucirsi di dosso modelli soffocanti che inspiegabilmente ricuciono legami, film erotici riemersi al momento sbagliato e marionette ritrovate nelle intercapedini dei muri di una casa di campagna che ci conducono per mano verso quel complicato atto d’amore che chiamiamo tempo.
Si tratta sempre del conto in sospeso tra madri e figlie, ci sono sempre almeno due possibilità – un vestito che ci era sembrato troppo stretto o che potrebbe rovinarsi, sentimenti rimasti sottesi che hanno «un che di strano e appiccicoso», come «una caramella trovata già scartata in una tasca dimenticata della borsa, mezza sciolta dal contatto con l’aria e punteggiata di lanugine e polvere» ma che comunque ci si ficca in bocca.
QUESTO MOVIMENTO che può disgustare e commuovere si raffredda e si fa liquido in Mantide (Bompiani, pp. 168, euro 16, traduzione di Pietro Lagorio) esordio in cui Julia Armfield, nata a Londra nel 1990, colleziona un serbatoio di scoperte e prime volte con un guizzo di scrittura tanto vitale da risultare mostruoso. «Durante la muta sogno – passo le notti sommersa da mari di denti e unghie, in un’asfissia di pelli cadute e lasciate senza un corpo. Un costante afferrare e perdere cose che diventano acqua tra le mie mani» confessa la protagonista della storia che dà il titolo alla raccolta. «Le ragazze mi acciuffano tra i gridolini e mi trascinano dentro. Sento che la pelle mi si stacca nelle loro mani, forse dovrei provare a pulire il pavimento dai pezzi che perdo»: l’adolescenza è un processo che parte da una bambina di carne e si compie nei deliri di una donna-insetto.
In queste storie brevi ma profonde come buche sulla riva, Armfield esplora il corpo nelle sue sbordature oltreumane, affidandogli il carisma di soggetto letterario, la distanza siderale di un pianeta. «Mi ritrovai col viso premuto sul suo petto nel punto troppo molle in cui la carne era ancora intatta e compresi che la superficie della terra è più sottile in alcuni punti. Sono i luoghi dove si rifugiano le cose più strane e vere» fa dire a una delle sue ragazze alle prese con il fantasma della sua ex. «Avevo ventisette anni quando il mio Sonno uscì da me come un passeggero che scende dal vagone di un treno, si guardò intorno in camera mia per qualche secondo e si sedette sulla sedia accanto al letto» scrive a proposito di una città colpita dall’insonnia che vede sdoppiarsi come ombre dalle sagome le sue persone.
UNA MATRIGNA veste da bambina il suo lupo femmina ed educa la figlia adottiva come un canelupo, una moglie preferisce seppellirsi sotto un banco di meduse di fronte all’oceano piuttosto che accettare la fine del suo matrimonio; nei microcosmi di Armfield la materia del mondo sa mescolarsi a quella dei sogni, una proprietà che evapora tra le pagine elettriche di Mary South, autrice americana che si definisce «late millenial» ma ha scelto di non comunicare la sua vera età a nessuno, alla prima raccolta con Mi ricorderò di te (Pidgin, pp. 276, euro 16, traduzione d Stefano Pirone).
I suoi racconti brillano di un presente aumentato, dove la realtà si ricombina in una lingua-codice, un pidgin per niente semplice tra la poesia e l’algoritmo che minaccia di darti la scossa. I personaggi di South sono insieme ma soli come accadeva nelle ricerche di Sherry Turkle, le loro vicende sono così vicine alle nostre ma ci disorientano perché le parole che conosciamo assumono tra i loro denti significati diversi. Così dalla prima pagina ci ritroviamo catapultati in un «Centro Fornitura Keith», dove ogni Keith è un organismo fatto di pelle e pompe infusionali, un ibrido tra un figlio, un anziano e un elettrodomestico che viene a mostrarci come una relazione di cura può compensare una perdita. Una neurochirurga racconta la storia della sua vita rispondendo alle FAQ su un intervento di craniotomia, ci svela i suoi pensieri inconfessabili mentre riapre lembi ossei per drenare liquidi cerebrospinali, rimuove ghiandole pituitarie, introduce i pazienti alla conoscenza di tumori globulari che portano nomi simili a quelli di startup appena avviate. «Un chirurgo potrebbe rimuovere un tumore ma rimpiazzarlo con uno zaffiro» dice prima di svelarci del suo ex marito, dei suoi due figli e di cosa hanno combinato in piscina.
EMOZIONI E SILICIO si mescolano fino a coincidere in questa galassia più-che-reale che si nutre di un’intelligenza superiore, pretende una scrittura ipertrofica. Ci sono architette famose di nome Helen Dannenforth che progettano serie di edifici intitolate «Organi danneggiati». Curatrici di contenuti incaricate dal «motore di ricerca più famoso al mondo» di intercettare e rimuovere i discorsi d’odio, proprio mentre annaspano nel vortice dell’odio di sé – tra doxing, ghosting, cyberbulli e selfie mortali, in attesa che in «un futuro non così distante l’algoritmo diventi sufficientemente sofisticato da controllare da sé il peggio che l’umanità ha da offrire», sempre in cerca dell’app più adatta per arginare le conseguenze della solitudine sentimentale.
In uno spaziotempo dove «i thechies sono l’ultimo ciclo REM del sogno americano», la memoria è tutt’altro che un disco rigido. Se uno stupratore può inviare newsletter vendendosi per un predicatore di bene, una madre potrebbe fingere che la sua secondogenita sia la prima figlia scomparsa il giorno del compleanno fino a crederci davvero. Alla fine, «per salvare l’universo dobbiamo anche salvare noi stessi», ci ammonisce la comandante spaziale Dinara Gorun a proposito del «nostro passato nebuloso». Come a dire, è la fantasia la nostra materia inorganica prima. Inutile affannarsi a formulare domande davanti a oracoli stellari, il cosmo lo serbiamo dentro.
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento