Alison Harvey, il campo e gli studi femministi
SCAFFALE Un volume a cura di Federica Timeto e con la traduzione di Olga Solombrino, edito da Meltemi
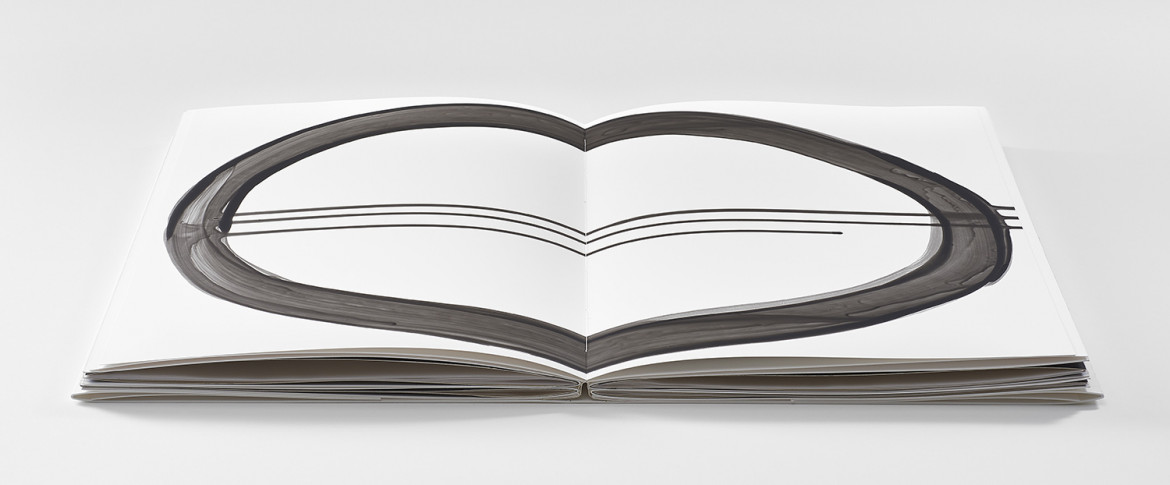
SCAFFALE Un volume a cura di Federica Timeto e con la traduzione di Olga Solombrino, edito da Meltemi
I media sono tra i dispositivi più potenti di produzione, riproduzione e naturalizzazione dei generi. Tutti i media, in tutte le loro fasi e in tutte le loro molteplici ramificazioni sociali, politiche, economiche e culturali. È pertanto evidente quanto sia necessaria una lettura critica di questo complesso mondo e delle sue proteiformi modalità di rendere visibili o, al contrario, di oscurare corpi, piaceri, discorsi, storie e soggettività.
IL VOLUME di Alison Harvey, Studi femministi dei media. Il campo e le pratiche, reso disponibile al pubblico italiano per i tipi di Meltemi (pp. 327, euro 22), grazie al lavoro di curatela di Federica Timeto e a quello di traduzione di Olga Solombrino, ci restituisce un’analisi ampia, ricca e articolata dell’incrocio tra narrazioni mediali, genderizzazione e potenzialità di trasformazione latenti dentro gli stessi media. La prospettiva è chiara: «La particolarità di questo libro è proprio quella di porre l’attenzione su quanto gli studi femministi dei media riguardino sia il modo in cui i media sono usati, prodotti e marcati dalle soggettività di genere, sia il potenziale contributo dei media alla creazione di un mondo più giusto e uguale per le persone che sono state escluse dai sistemi egemonici di potere». Più in breve: «Il modo in cui documentiamo e narriamo la storia è una questione politica».
E le questioni politiche, si sa, richiedono scelte di campo precise, poiché «non c’è alcun modo neutrale di creare le storie». La prima scelta di campo dell’autrice è quella di posizionarsi, con lucidità, tra le varie declinazioni del femminismo: Harvey legge la realtà dei media tramite una lente transfemminista intersezionale e decoloniale, una lente diametralmente opposta a quella del postfemminismo neoliberale, secondo cui «le cose stanno migliorando», secondo cui le oppressioni istituzionalizzate di genere (e non solo) sarebbero addirittura qualcosa di superato.
La seconda scelta di campo «non è giudicare le rappresentazioni mediali come “buone” o “cattive”, corrette o inappropriate, ma comprenderne le caratteristiche, il funzionamento, se e come sfidano le norme sociali». E, così, l’occhio si fa più attento: c’è infatti un «lato oscuro della visibilità», poiché, «quand’anche fanno la loro apparizione nei media», «donne, persone queer e razzializzate» possono comunque «essere inquadrate e ritratte in modalità limitate e monocordi, caratterizzate in maniera stereotipata o altrimenti semplicistica».
IL TERZO POSIZIONAMENTO decisivo è quello di provare, tramite un approccio genealogico e decostruttivo, a sviluppare «un impegno concreto». Il che significa, tra le altre cose, che «il nostro compito non è “dare voce”» alle persone oppresse – come se «non avessero mai parlato e la capacità di parlare sia un dono dei privilegiati» –, «ma combattere attivamente la cancellazione, il silenziamento e la marginalizzazione delle (loro) voci». Davvero i media nascondono in loro questa potenzialità emancipativa? Se i libri sono media e se quello di Harvey è un libro, la risposta non può che essere affermativa come affermativa dovrebbe essere la politica che ne consegue.
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento
