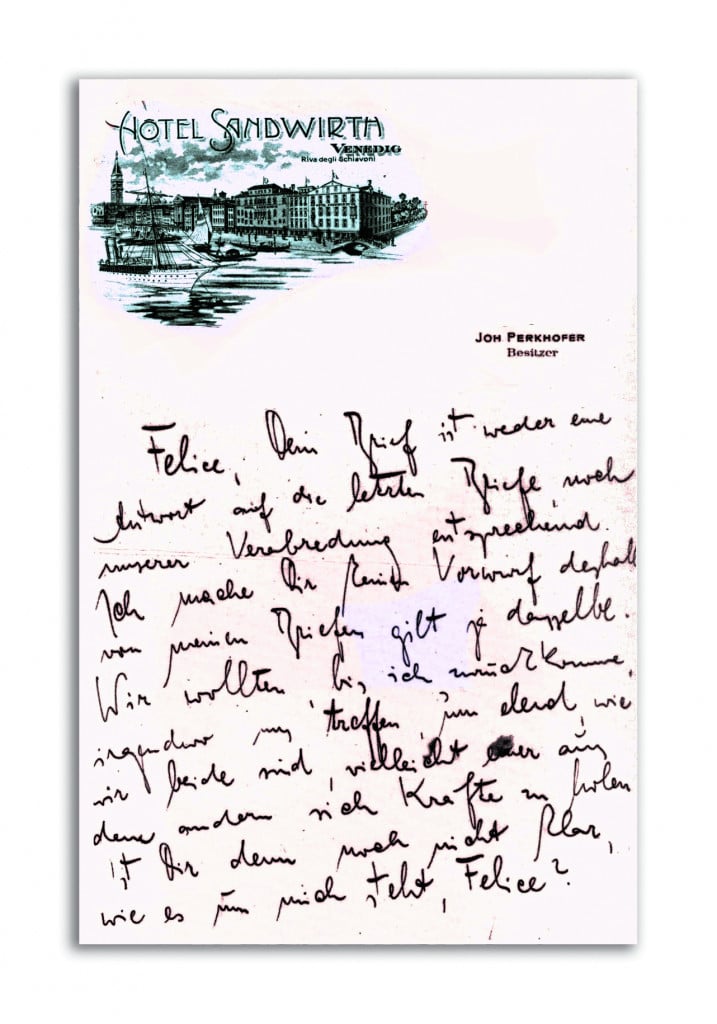L’hanno definito una “bolla di sapone”. Anzi, “Seifenblase” per dirla in tedesco, visto che ad occuparsene sono stati soprattutto i commentatori di Berlino, nel paese che aveva visto gonfiarsi – e quanto – quella bolla. Espressione comunque esagerata perché nonostante tutto il movimento pirata – di questo si sta parlando – ha ancora una rappresentante in Europa: Julia Reda, eletta proprio in Germania. Espressione esagerata, ancora, visto che alle ultime elezioni europee i pirati hanno presentato il loro simbolo in ben sette diversi paesi. La scorsa volta, invece, quella vela nera con dentro la “P” c’era in una sola nazione. Ma certo il movimento – in Europa dove è nato e in tutto il mondo dove ha provato ad estendersi – vive una crisi durissima. Drammatica. In tutto il vecchio continente hanno racimolato solo 800 mila voti. Nulla.
Crisi, allora. Accentuata dal fatto che viene nascosta. Ignorata. Christian Engstrom, ex eurodeputata svedese – nel paese che aveva visto il vero esordio elettorale dei pirati ma che nel giro di cinque anni ha visto crollare il consenso dal 7 al 2% – il giorno dopo i risultati, se n’è uscita più o meno così: peccato, è andata male. Rick Falkvinge, anche lui svedese – il vero fondatore del movimento e che poi si è ritagliato un ruolo di “grande vecchio” – se possibile è sceso ancora più sul banale: “Lo sapevamo che sarebbe stata dura”.
Le ragioni di questa sconfitta? Nessuno ha perso tempo a spiegarle. E dire che in Germania, fino a pochi anni fa, la crescita dei pirati sembrava inarrestabile: da Berlino fino al Norrhein Westfalen, ovunque nei Land i pirati sfondavano e superavano il sette, l’otto per cento.
Poi, il declino. Il crollo.
A Berlino, alle europee, li ha votati uno su cinque di quelli che li avevano preferiti alle amministrative di tre anni fa. E così, a maggio hanno racimolato un modesto uno e tre per cento. Che, grazie alla legge tedesca, ha consentito a Julia Reda di sedere a Bruxelles. Unica rappresentante europea, s’è detto, del movimento pirata. E lei, come primo atto, ha votato Jean-Claude Juncker alla presidenza della Commissione. Allineandosi alle decisioni dei Verdi (nel cui gruppo è entrata a far parte). Un voto, motivato successivamente sul suo blog, dal pericolo della destra antieuropea e, addirittura, da un’apertura sul tema della trasparenza nelle trattative per il Ttip che Julia Reda avrebbe scovato nelle parole di Juncker. “Apertura” notata esclusivamente da lei e che subito dopo è stata accantonata anche nei suoi discorsi.
Così il crollo è proseguito pure in Sassonia dove si è votato pochi giorni fa. Le ragioni? A leggere i loro scritti, a leggere ciò che circola nei siti internazionali, ad ascoltarli di persona, la risposta è semplicissima: la rissosità interna. Che ricorda molto da vicino le versioni ufficiali che forniva la sinistra italiana di fronte ai tanti disastri elettorali.
Hanno litigato fra di loro, insomma. E la soluzione è in linea con la superficialità di quest’analisi: un nuovo board, un nuovo gruppo dirigente, che garantirà d’ora in poi che il confronto avvenga nei limiti della “buona educazione”. Nel rispetto di tutti.
Tutto qui. Ma il garbo stavolta non riuscirà a nascondere la crisi. Che è molto più profonda e che è di sostanza. Rivelata proprio da quei “litigi” che Stefan Körner, il nuovo presidente, dice di voler sopire.
Litigi tutti politici, esplosi proprio nel pieno della campagna elettorale europea. Come quando Anne Helm, una delle figure di spicco dei pirati tedeschi, partecipò ad una manifestazione antinazista a Dresda. Indossava una maglietta – che poi si tolse in stile Femen – con su scritto: “Grazie Bomber Harris”. Arthur Travers Harris è il maresciallo inglese che ordinò il bombardamento su Dresda, per colpire i rifornimenti tedeschi durante la seconda guerra mondiale. Fece trentamila morti fra i civili.
Quella di Anna Helm fu dichiaratamente una provocazione – il tema: fin dove era lecito spingersi per combattere il nazismo, è ancora argomento tabù in Germania – che però fece uscire allo scoperto dissensi profondi. Dissensi che crebbero di lì a poco, quando la bandiera del Partito Pirata sventolò assieme alle altre, all’occupazione del Rote Flora ad Amburgo. Lo storico centro sociale sgombrato violentemente dalla polizia.
E’ stato a questo punto che la destra del partito è uscita allo scoperto: quei segnali, l’incontro sul campo coi movimenti sociali più radicali, smentivano la filosofia dell’ex presidente Sebastian Nerz, secondo cui il partito pirata doveva essere “liberal sociale”. Neologismo che avrebbe dovuto combinare la cultura comunitaria, tipica della sinistra sociale tedesca, con il “laissez faire” dei nuovi liberisti, che teorizzavano la fine dai lacci e lacciuoli dello Stato per liberare le potenzialità delle start up.
Con buona pace di chi, anche in Italia (si pensi al libro di Ubaldo Villani-Libelli, il primo pamphlet sull’argomento) rimaneva estasiato davanti al miraggio del “nuovo partito pirata, né di destra, né di sinistra”. Semplicemente “nuovo”. E invece quel “nuovo” s’è trovato a fare i conti con le domande di sempre, con domande antiche: da che parte stare?
In Germania hanno deciso di non decidere. E sono quasi scomparsi.
Altrove va anche peggio. Fino al caso della Grecia. Dove alle ultime europee, i pirati – presentatisi da soli, contro tutto e tutti – hanno racimolato lo zero e tre per cento. Ma ad Atene hanno trovato la formula magica contro l’insignificanza: una coalizione di tutti gli esclusi. I pirati greci, insomma, hanno proposto a tutti i partiti che non hanno raggiunto il quorum alle europee di allearsi – “coalizione di scopo” – in vista delle politiche. Liberali, monarchici, verdi, socialisti insoddisfatti, contadini, pescatori, tutti. Con la sola esclusione “dei fascisti” (che d’altronde in Grecia non hanno bisogno di alleati) e “degli estremisti”, per altro non meglio definiti.
Certo, il quadro non è omogeneo, non tutti i paesi raccontano la stessa storia.
Fuori dalla Ue, c’è per esempio l’Islanda, dove di partiti affiliati al movimento pirata internazionale ce ne sono addirittura due. Uno l’aveva creato il comico Kristinsson Gnarr che fino a due mesi fa era il sindaco di Reykjavik, alla guida di una coalizione di destra conservatrice. Un mese fa, alle urne, ha dovuto lasciare il posto ad una maggioranza composta dai socialisti, dai rosso-verdi e dal partito pirata vero e proprio. Che ha imposto nel programma non solo l’adozione di sistemi operativi open source in tutti i computer dell’amministrazione ma ha preteso e ottenuto che i soldi così risparmiati vadano investiti nell’edilizia popolare. In una città dove i senza casa sono l’uno per cento degli abitanti. Una curiosità: nel sito piratetimes – che è considerato l’organo ufficiale del movimento internazionale e che per questo soffre di una certa “ufficialità” nei racconti – il report dall’Islanda comincia così: “il partito, composto in gran parte da militanti punk-movimentisti…”. Nell’isola dei vulcani, insomma, hanno scelto.

E qui, poche settimane fa Kim Dotcom – che nonostante tutto è diventato uno dei simboli della battaglia contro l’ottusità del copyright – ha annunciato la sua intenzione di candidarsi alle ormai imminenti elezioni in Nuova Zelanda. La Costituzione lo consente.
Naturalmente il partito pirata locale ha pensato di cogliere la palla al balzo e gli ha proposto di entrare nelle sue fila. Con un orrendo escamotage programmatico: i pirati neozelandesi hanno offerto di inserire nella loro piattaforma un paragrafo che sembra pensato ad hoc, sul diritto degli imprenditori a liberarsi dai vincoli dello Stato. Da tutti i vincoli. Ma non è bastato quest’improvviso innamoramento neoliberista per convincerlo. Kim Dotcom, e la sua formazione Internet Party, hanno scelto di allearsi col Movimento Mana. Un piccolo gruppo di sinistra, di sinistra radicale, nato per dare voce alla minoranza maori – da sempre discriminata – e poi via via diventato una sorta di assemblea che unisce i dissenzienti di tutta la Nuova Zelanda: da chi si oppone al fracking fino a chi si batte per il free software.
Crisi, perdita di autorevolezza ovunque, allora. E poi c’è l’Italia. Dove il partito pirata – che per altro è uno dei più “antichi”, fu fondato nel 2006 – ha già alle spalle una buona esperienza elettorale. Sempre in coalizione con forze di sinistra. Alle ultime europee, ha scelto di schierarsi con l’Altra Europa, dando vita a DigiTsipras, una sorta di forum sui temi digitali che ha integrato il programma dell’alleanza.
Ma le stesse domande – quelle che attraversano l’intero movimento – si ripropongono anche qui da noi. Chi legge i dibattiti sui forum – non si viola nessuna netiquette a rivelarli – si accorge che tutto ritorna sempre lì: da che parte stare? I pirati italiani sembravano aver scelto, sono stati protagonisti delle assemblee della lista Altra Europa, anche dopo il voto. Ma quelle scelte ogni tanto ritornano in discussione. Sistematicamente. “Non si può teorizzare il superamento del mercato”, “il mercato va rispettato, non osteggiato”, eccetera, eccetera. Le voci della destra interna, anche in questo caso chiamiamola così per facilità di comprensione, sono tornate a farsi sentire. E un’altra volta i pirati italiani dovranno scegliere.
Lo faranno questo week-end, sabato 13 settembre e domenica 14 a Roma, in un’assemblea nazionale.
Per molti di loro, comunque, è un’attività frustrante. Perché i pirati italiani – gli unici, assieme agli islandesi, ad avere un partito senza dirigenti, dove “tutti sono portavoce” – sono stati i primi ad adottare un sistema di democrazia digitale, Liquid FeedBack. Una vera assemblea on line, dove si discute e si decide su tutto. Uno strumento che però non funziona più spedito come nei primi tempi: invece di votare su cosa fare qui ed oggi, l’assemblea telematica è costretta a votare – a tornare a votare – su grandi temi ideologici. Siamo per il mercato o no? Lo Stato deve avere un ruolo negli investimenti per uscire dalla crisi o no? Dobbiamo confermare la nostra collocazione? La domanda di sempre, insomma: da che parte stare? E ogni volta, i pirati italiani devono ricominciare daccapo.
Forse domenica 14 settembre a Roma sceglieranno, torneranno a scegliere. Come hanno fatto in Austria dove hanno confermato l’alleanza con la sinistra radicale che ha fatto loro sfiorare il quorum. O, meglio, come hanno fatto in Spagna. Anche qui alle spalle c’è un clamoroso insuccesso elettorale. Zero e due per cento. Ma piuttosto che paralizzarsi sul come rilanciare il partito hanno deciso di andare in mare aperto.
E hanno lanciato la prima iniziativa europea contro il Ttip, una settimana fa. D’intesa con Attac. Hanno scelto di essere un “pezzo” di un movimento sociale, piuttosto che rinchiudersi a discutere su cosa debba essere un partito.
Hanno scelto il mare aperto. Come del resto ci si aspetterebbe dai pirati.