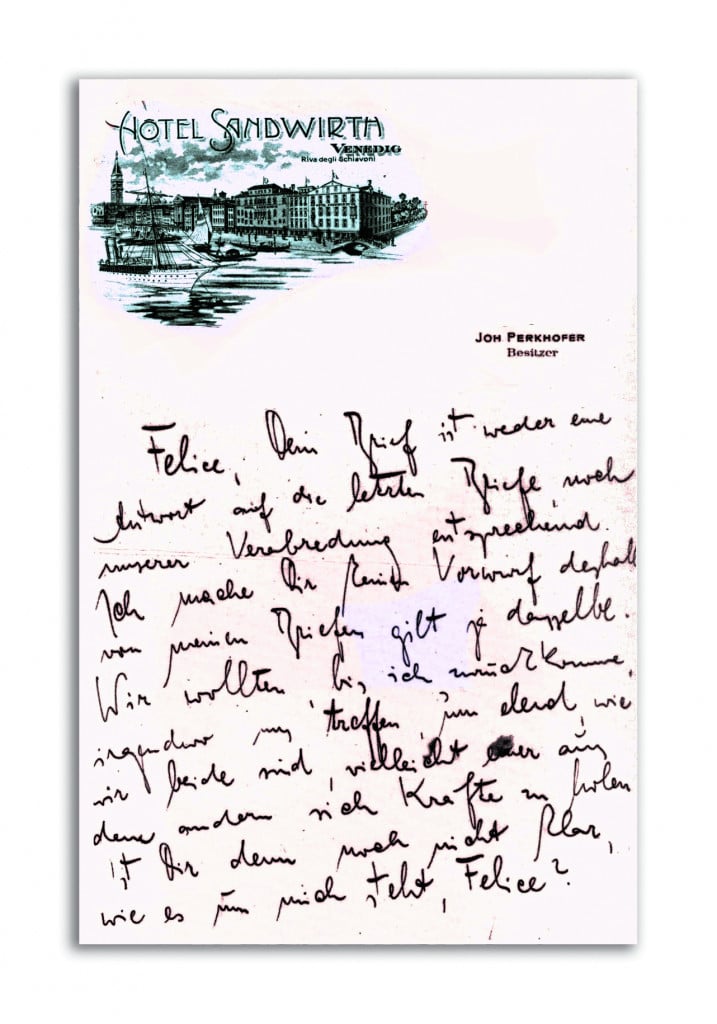La lezione politica che Hannah Arendt trae dai «fatti d’Ungheria» del 1956 è consegnata a un saggio straordinario – scritto a caldo e comparso nel 1958 come epilogo della seconda edizione di Le origini del totalitarismo – che solo ora viene presentato nella sua versione estesa al lettore italiano, sotto il titolo La rivoluzione ungherese e l’imperialismo totalitario (a cura di Simona Forti e Gabriele Parrino, Cortina, pp. 108, € 14,00).
«Quel che è successo in Ungheria non è accaduto in alcun altro luogo del mondo; i dodici giorni della rivoluzione hanno in sé più valore storico dei dodici anni che sono trascorsi da quando l’Armata Rossa ha “liberato” il paese dalla dominazione nazista». Animata dall’emozione del testimone diretto e, si direbbe, da una vera e propria eccitazione teorica, Arendt attiva revisioni, riesami e novità concettuali decisive, procedendo nelle vesti di allieva dei fatti, «gli unici insegnanti affidabili degli scienziati politici».
La fiamma della rivoluzione d’Ungheria ha illuminato in primo luogo «l’immenso paesaggio del totalitarismo postbellico»: alla sua luce Arendt si incarica di «testare e ampliare» le proprie comprensioni precedenti – affidate soprattutto a Le origini del totalitarismo.
Un riesame a maglie più serrate è riservato in particolare ai meccanismi totalitari sovietici, rimasti meno definiti rispetto a quelli nazisti: la creazione del sistema degli stati satellite – attuata in perfetta ripetizione delle tappe e dei metodi del dominio totalitario; la crisi seguita alla morte di Stalin (nel 1953) – esito della mancanza di regole successorie e ragione della competizione mortale tra i potenziali eredi; il discorso di Chrušcëv al XX congresso del Pcus (nel febbraio 1956) – ambigua vetrina di una ‘destalinizzazione’ che si rivela mera riforma nei metodi e nelle istituzioni di dominio, mentre per le questioni ideologiche e politiche il capo del Cremlino torna «all’impiego sconsiderato dei metodi di Stalin».
Ciascuna di queste linee analitiche concorre a togliere fondamento alle speranze degli osservatori occidentali in una riforma del regime dall’interno, e avvalora il monito di Arendt a non misurare la minaccia del totalitarismo con il metro «relativamente innocuo» del conflitto tra un ordine economico capitalista e uno socialista. Esplosiva le pare piuttosto la contraddizione tra la «finzione totalitaria», fondata sulla sistematica negazione della realtà dei fatti, e «la nuova fatticità del mondo nell’era atomica».
Mentre elaborano concettualmente l’autonomia della politica dalla presa dello Stato, queste analisi portano anche in vista la distanza di Arendt dalle contrapposizioni tipiche della guerra fredda, in cui sarebbe stata a lungo e ostinatamente incasellata. È la stessa Simona Forti, in una introduzione penetrante quanto eloquente, a fornire da par suo la sentenza definitiva: «Non esiste in Arendt un anticomunismo preconcetto dettato dalla sua presunta fedeltà agli assiomi del liberalismo, dall’individualismo alla libertà di mercato».
Di più: Arendt condividerebbe l’idea di comunità politica che orienta il comunismo e lo stesso pensiero di Marx: la speranza, cioè, nell’avvento di una società di liberi ed eguali, di uno spazio pubblico orizzontale senza dominanti né dominati. La distanza di Arendt si misurerebbe piuttosto nei confronti del materialismo storico e della sua concezione dialettica.
Effetto immediato della rivelazione – via New York Times – del discorso ‘segreto’ di Chrušcëv sui crimini di Stalin, la rivoluzione ungherese non invera alcuna causalità storico–dialettica, ma irrompe nella storia senza preavviso, liberandosi di scatto dagli automatismi totalitari: «Se mai è esistito qualcosa come la “rivoluzione spontanea” di Rosa Luxemburg abbiamo avuto il privilegio di esserne testimoni: un’improvvisa insurrezione di un intero popolo con nessun altro obiettivo se non il bene della libertà».
Balzata sulla scena senza colpo di stato, né cospiratori, né programmi «e addirittura senza la guida di un partito», la rivolta ungherese si presenta allo stesso tempo come un evento unico e come un modello teorico, una sorta di ‘rivoluzione in purezza’, il cui magistero illumina la riflessione.
Nella lezione che trae dalla sua rapidissima vicenda – l’esercito si disintegra nel giro di poche ore, il governo in pochi giorni e ancor prima era collassato il «mortale incantesimo di apatia e di impotenza» indotto dal terrore totalitario – Arendt non fa che affilare e testare il proprio arsenale teorico.
Lo snodo più eloquente – messo in risalto dallo scavo critico di Gabriele Parrino – si rivela consistere nella comparsa dei consigli, gli stessi puntualmente emersi nel ‘48, nella Comune di Parigi, nella Rivoluzione d’ottobre (i soviet!), ogni volta che il popolo ha fatto sentire la propria voce «senza venire imboccato da un partito o pilotato da un governo».
Alternativo al sistema dei partiti –- che sempre è risultato vincitore – il sistema dei consigli non origina infatti nel Parlamento, ma direttamente dall’agire insieme in uno spazio pubblico plurale e comune: i quartieri, i caffè, le Università, le caserme, gli uffici, le fabbriche. Ovunque le persone sono state insieme hanno formato eterogenei gruppi consiliari dove «un incontro casuale di persone si è trasformato in un’istituzione politica».
Nella loro spontaneità Arendt vede espressa una forma di potere autenticamente e radicalmente democratica, che la fa finita con la separazione verticale tra governanti e governati, quella separazione che innerva la filosofia politica a partire da Platone e induce a scambiare il potere con il dominio. Il raffronto ravvicinato tra i due sistemi porta in luce soprattutto una differente forma di rappresentanza. «Intrinsecamente anti–partitici», i consigli selezionano i propri rappresentanti dal basso, sulla base della fiducia nelle loro qualità personali, e non invece dall’alto, sulla base di programmi o ideologie.
Arendt insiste sul pericolo costituito da questo principio puramente personale per la dittatura di un partito e suggerisce che forse proprio per questo l’esercito russo ha colpito in Ungheria con tanta rapidità e spietatezza: «perché con essa il sistema sovietico originale è rientrato sul palcoscenico della storia», mostrando come «la libertà sia insita nelle capacità umane di azione e di pensiero». Senza poter dire se il sistema dei consigli si sarebbe mostrato all’altezza delle esigenze della politica moderna e capace di sostituire la democrazia rappresentativa, Arendt celebra la rivoluzione ungherese come autentica azione politica: per quanto sconfitta, è stata capace di operare la prima frattura nel totalitarismo sovietico e persino nella fede rocciosa dei comunisti d’Occidente. Un inno alla libertà che «l’intellighenzia russa si dimenticò di sognare».