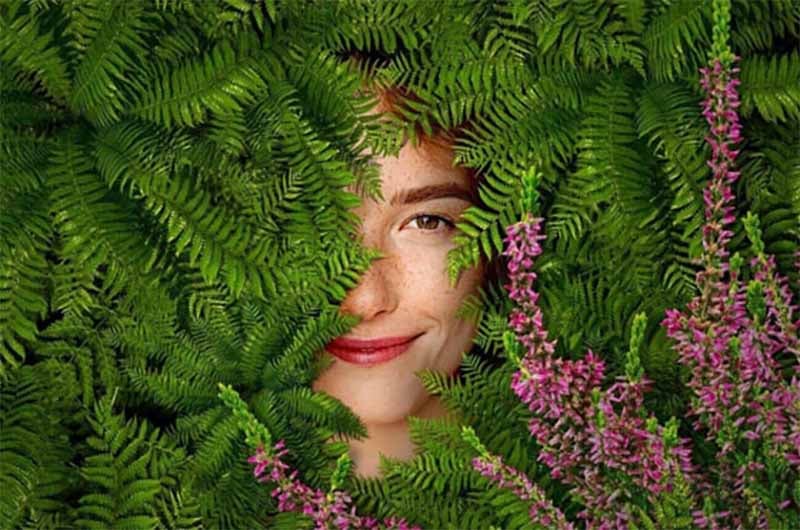Clima, situazione drammatica ma il governo è fermo
Emergenza L’Italia è «un paese alla frontiera del clima», come scritto nel sottotitolo di Siccità, il libro pubblicato da Giulio Boccaletti, direttore scientifico del Centro euro-mediterraneo per i cambiamenti climatici, a settembre 2023

Emergenza L’Italia è «un paese alla frontiera del clima», come scritto nel sottotitolo di Siccità, il libro pubblicato da Giulio Boccaletti, direttore scientifico del Centro euro-mediterraneo per i cambiamenti climatici, a settembre 2023
Le ultime stime dell’Osservatorio siccità del Cnr dicono che già nel «trimestre primaverile Sicilia, Calabria e Basilicata cominciano a mostrare segni di deficit marcato», aggiungendo che «sul medio periodo le percentuali aumentano e si aggiunge alla lista anche la Puglia», mentre «sul lungo e lunghissimo periodo, una buona fetta di Sud e isole maggiori risulta colpito da siccità severo-estrema, a cui si aggiungono piccole aree delle regioni settentrionali».
L’Italia è «un paese alla frontiera del clima», come scritto nel sottotitolo di Siccità, il libro pubblicato da Giulio Boccaletti, direttore scientifico del Centro euro-mediterraneo per i cambiamenti climatici, a settembre 2023. Chi governa deve assumere quanto ormai dimostrato dalla comunità scientifica: tutto il Bacino del Mediterraneo, su cui affaccia il nostro Paese, è un hotspot dei cambiamenti climatici, cioè uno di quei luoghi nel mondo dove saranno più marcati gli effetti negativi, tra cui figurano anche l’aumento delle temperature medie e la riduzione (o l’eccessiva concentrazione) delle precipitazioni.
La redazione consiglia:
Le imprese negano l’emergenza caldo e il governo non fa niente«Quando si parla di siccità (una piovosità sotto la norma), non si sta descrivendo il fenomeno di cui abbiamo esperienza diretta. Ciò che lamentiamo – scrive Boccaletti – è la scarsità, il prodotto di un’aritmetica complessa nel tempo e nello spazio. È il sintomo della nostra incapacità – in presenza di un mutamento nelle precipitazioni – di riorganizzare usi e bisogni. È questo fallimento, più che il calo di precipitazioni, che dovrebbe preoccuparci a fronte di un cambiamento climatico secolare e in accelerazione».
Risuonano stonate le parole con cui il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha ricordato meno di una settimana fa, il 17 giugno, la Giornata mondiale per la lotta alla desertificazione e alla siccità: «Siccità, degrado del suolo e desertificazione sono problemi ambientali correlati tra loro, che possono determinare impatti sociali ed economici severi: sono frutto di una gestione non sostenibile del suolo, aggravati fortemente dai cambiamenti climatici e da stress idrico, nonché dagli incendi».
Senza alcun riferimento a una situazione drammatica ed esplosiva, senz’altro destinata ad acuirsi dopo un inverno, l’ultimo, che ha toccato record negativi di precipitazioni nevose in quasi tutti i bacini dell’Appennino, da quello del Tevere in giù.
Mentre il governo italiano è ancora appeso a un Commissario straordinario che vede la soluzione nella costruzione di nuovi invasi, ipotesi su cui concordano perfino Fdi e Lega, sponsorizzata tanto da Lollobrigida quanto da Salvini, il problema è già a uno stadio successivo: se le immagini drammatiche degli animali che in Sicilia bevono da pozze fangose fa giustamente il giro d’Italia, poca evidenza viene data alle spighe vuote del grano duro, come denuncia Slow Food, ma è questo il risultato di una riduzione della disponibilità idrica nella zona radicale del suolo, che ha impatto sulla crescita ottimale delle piante e causa una riduzione delle rese.
La scarsità idrica, poi, è anche uno dei fattori che innescano processi di degrado del suolo e desertificazione e che influenza la capacità di sequestro del carbonio delle piante. È un terribile circolo vizioso i cui effetti diventano sempre più difficilmente controllabili. «È tempo di crisi climatica» ha detto in occasione dell’ultima Giornata mondiale dell’Ambiente il segretario generale delle Nazioni unite, António Guterres. L’Italia è ferma al suo Piano Nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, pieno di misure soft e che propone pochi cambiamenti strutturali. Ma il tempo è scaduto.
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento