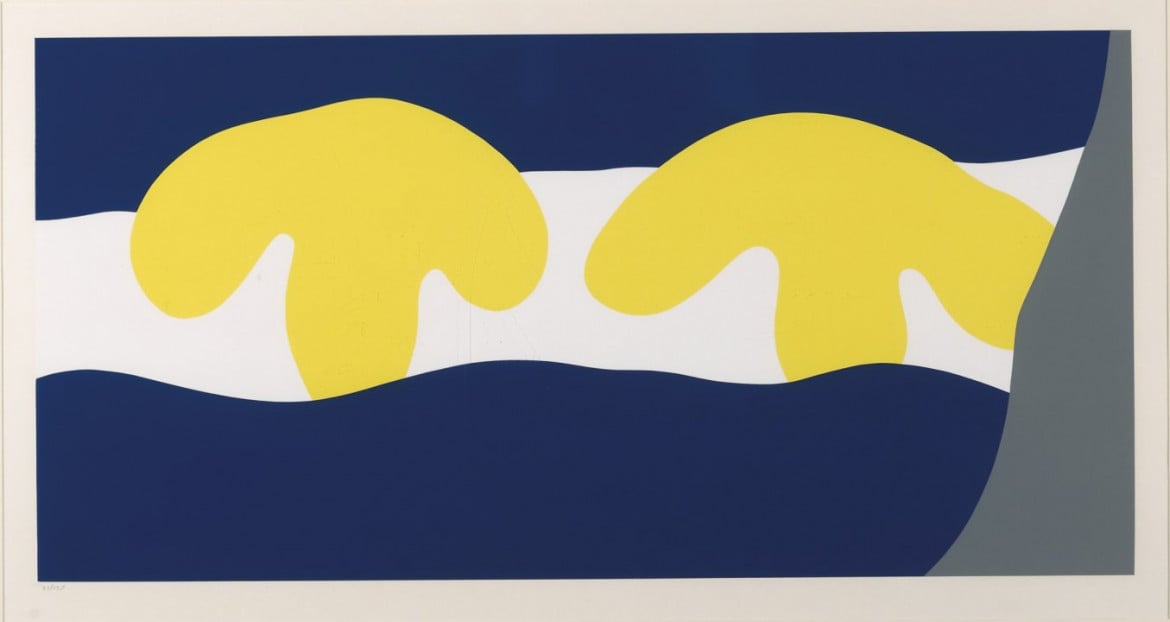Nel suo nuovo film, in concorso a Filmmaker (sulla piattaforma MyMovies da sabato 5 per 72 ore), Lech Kowalski filma un’altra Parigi, lontana dall’immagine della Ville lumière. Ma reale per i migliaia di migranti e richiedenti asilo accampati alle sue porte. Quello di Kowalski è un cinema anomalo nel campo del documentario. È una storia cominciata a New York, con l’arrivo dei Sex Pistols in tournée nel sud degli Stati Uniti (DOA, 1980). E che, dal fenomeno musicale punk, si è spostata verso l’essere punk come condizione generale del proletariato dei nostri tempi.
Da una piccola comunità polacca (The Boot Factory, 2000) agli operai in lotta della Renault (On va tout peter, 2019), Kowalski ha filmato il farsi punk del mondo. È un cinema politico e è al tempo stesso personale. Ma non è mai un’operazione introspettiva. Quello di Lech è un cine-occhio che si osserva attraverso altri occhi. L’occhio di Dee Dee Ramone. L’occhio di sua madre. In C’est Paris Aussi è l’occhio di un nativo americano di nome Ken Metoxen. È con lui che Lech ha scelto di andare nella baraccopoli parigina. Non per fare accostamenti astratti tra storie diverse. Ma, molto sensualmente, per vedere cosa accade quando persone che portano il peso della propria storia nel proprio sguardo si incontrano, si scontrano, si riconoscono.
Ammetterai che è strano che un nativo americano si ritrovi a farti da guida nelle baraccopoli di Parigi.
È un film che ha una lunga storia. Il progetto è nato quattro anni fa. Lo abbiamo girato in parte in America, nella riserva dello stato di New York dove vive Ken. In parte a Parigi. All’inizio c’è non un’idea, ma un desiderio: quello di connettere insieme, emotivamente, la sua storia personale e la mia. Quando ero ragazzo, vivevamo in una fattoria nel Nord del Wisconsin. Alcuni nostri vicini erano nativi. Quando la banca ci ha preso la fattoria, perché il bestiame si era ammalato, mia madre ha dato quello che ci restava alla famiglia nativa. Tutte le famiglie di nativi nei dintorni erano povere. Noi eravamo poveri, ma loro lo erano più di noi… Questa connessione con i nativi fa parte della nostra mitologia familiare. Mia madre ed io ne abbiamo parlato spesso. Il giorno in cui è morta, è quello in cui ho incontrato Ken.
È un tuo personale «Thanksgiving».
Non ci avevo pensato, ma sì, c’è qualcosa del genere. C’è una logica nell’oppressione che osserviamo nel mondo. E che emerge nella mitologia con la quale i paesi e le persone che hanno potere manipolano il pensiero e la rappresentazione delle persone che opprimono. I nativi americani sono una categoria molto speciale di popoli che hanno subito un genocidio. C’è in loro uno spiritualismo che è universale. Credo che sia quello che mi ha attirato di più in Ken. Volevamo esplorare uno spazio creativo insieme. Non abbiamo mai avuto chiaro dove ci avrebbe portati. Ma l’energia proveniva dalla volontà di conoscerci attraverso un puro sforzo artistico. E questo ci ha portato a ragionare in termini estetici per creare qualcosa che non ha nulla a che vedere con la nostra realtà. Ken non vive a Parigi. Non conosce il tipo di persone che abbiamo incontrato nel film. Ma il suo desiderio era anche in qualche modo di esplorare sé stesso e la propria sessualità.
Sulla carta è un film sui migranti, sulle bidonville intorno a Parigi, sui richiedenti asilo… Un film «su». Vedendolo si resta sorpresi, non è un film che osserva ma piuttosto un film che crea.
Certi film sono retti dall’idea di ottenere un risultato: far passare un messaggio o rispettare certi criteri fissati dai produttori o dalle film commission. Il nostro invece è un film leggero. È stato fatto con uno spirito libero. Lavorando con Ken, ho avuto la sensazione di ritrovare la spensieratezza dei miei primi film. È stato come scrivere una poesia.
Ed anche la sessualità di Ken, di cui hai parlato, non è un tema che il film «tratta».
Ken è venuto in Francia perché in America non riusciva ad esprimersi. Né come artista, né come persona. In lui c’è aspetto mascolino. E un aspetto femmineo. Nella riserva dove vive questo sua duplice carattere è represso. Per questo gli ho detto: vieni a Parigi, prova a vedere se qui puoi vivere anche come donna. C’è una parte di questo nel film. Ma in effetti non è un tema del film. Ken lo porta con sé, nella sua esplorazione di Parigi che quindi diventa anche un’esplorazione sulla propria sessualità.
Questa duplicità appare anche negli incontri più «virili», come quello con il pugile.
Nella cultura dei nativi americani c’è una forte valorizzazione della virilità. Ken è sinceramente affascinato dalla mascolinità di questo pugile afgano che incontra per le strade di La Chapelle. La scena della lezione di pugilato nel caffè è in effetti anche la scena di sesso del film. È come in D.H. Lawrence, il legame virile è portatore di una grande sensualità.
Come mai tu e Ken vi siete ritrovati a frequentare le baraccopoli?
Sono andato molte volte in queste baraccopoli intorno al raccordo anulare, con la cinepresa, o senza. Alle volte solo per parlare. Altre per osservare come queste persone vivono o cercano di sopravvivere. Senza abbassare lo sguardo o distoglierlo, come fanno alcuni passando di là. E in effetti di tutti i posti dove siamo andati a Parigi è l’unico dove Ken ed io ci trovavamo a nostro agio. Non nego che di primo acchitto può sembrare pericoloso. In effetti lo è, ma è l’impressione che si ha andandoci… Qualcuno ci ha tirato qualche pietra, ma è tutto. Ed è ok, perché siamo degli intrusi con una macchina da presa. La ragione è che in questo genere di posti l’esistenza è più intensa che altrove, i rapporti tra le persone sono più semplici. Si potrebbe dire più spicci. Ma anche più veri. Quando entri in quello spazio, qualcosa accade al tuo corpo e alla tua testa. Devi comunicare con le persone intorno a te in un modo molto diretto. Le vicende di queste persone che abbandonano il proprio paese, le ragioni che li spingono, dove cercano di andare, queste storie mi interessano. Abbiamo passato molto tempo lì, semplicemente a parlare. C’è gente che viene da ogni parte del mondo. E che ha attraversato il mondo intero, per davvero, non in aereo. C’è dunque questa ricchezza di esperienze. Ken si è molto legato a loro, ad un livello che non è solo emotivo, per la storia del suo popolo, perché vive in una riserva, ma anche dal punto di vista fisico. Come se ci fosse una certa somiglianza di famiglia tra questi popoli asiatici e i nativi americani, che si rivela ad un livello elementare: i tratti del volto, il colore dei capelli, la forma del corpo. Ma che poi, con lo scambio, si rivela anche in alcuni tratti culturali, come una certa delicatezza nel rapporto con gli altri, in una società che è per altro molto mascolina.
A un certo punto, filmi uno stivaletto abbandonato… Per quelli che conoscono il tuo cinema è come una sorta di madelaine che ci riporta involontariamente alla memoria «Boot Factory». Come se tutti i tuoi film avessero un legame comune, che è il punk…
La scena più punk per me è quella in cui certi ragazzi chiedono a Ken di mostrargli i suoi orecchini, e Ken se li toglie e glieli regala. Questo dono è una connessione punk. Al livello in cui il punk interpreta una certa perversione rock che non è nell’anello o nell’orecchino ma nel fatto di passarsi questi oggetti così intimi – una ribellione, in una società che valorizza l’asetticità. Nel punk c’è sempre un rapporto con la morte e con la giovinezza. E gli abitanti di questo luogo sono giovani costretti a sopravvivere. È quello che ho sentito, filmando questo spazio, che non è né l’inferno né il paradiso, ma una sorta di limbo. È uno spazio molto potente. Perché è vicino alla morte. Quelli che lo abitano aspettano di uscirne. Sperano di non finire rinchiusi lì per sempre. Non possono fare i bagagli e tornare da dove sono venuti. E non hanno un posto dove andare. Non appartengono a nessun luogo. Ne abbiamo percepito la violenza quando, con Ken, siamo andati invano alla ricerca del pugile. Dove si troverà? Sarà ancora vivo? Cosa gli sarà successo? Quando frequenti la baraccopoli, vedi spesso le stesse facce. E poi, tutto a un tratto, non le vedi più. Spariti. Dove? Che cosa sono diventati? In un certo senso, quella realtà è simile a quella dei campi di concentramento. Ed è a qualche chilometro dalle nostre case. Quando ho filmato il lungo cammino di Ken, attraverso Parigi, pensavo al cammino di queste persone. Allo spazio in cui si trovano. Questo spazio sta crescendo, credo, nel mondo. Sempre più persone cadono al suo interno. Questo è quello che abbiamo esplorato in questo film.